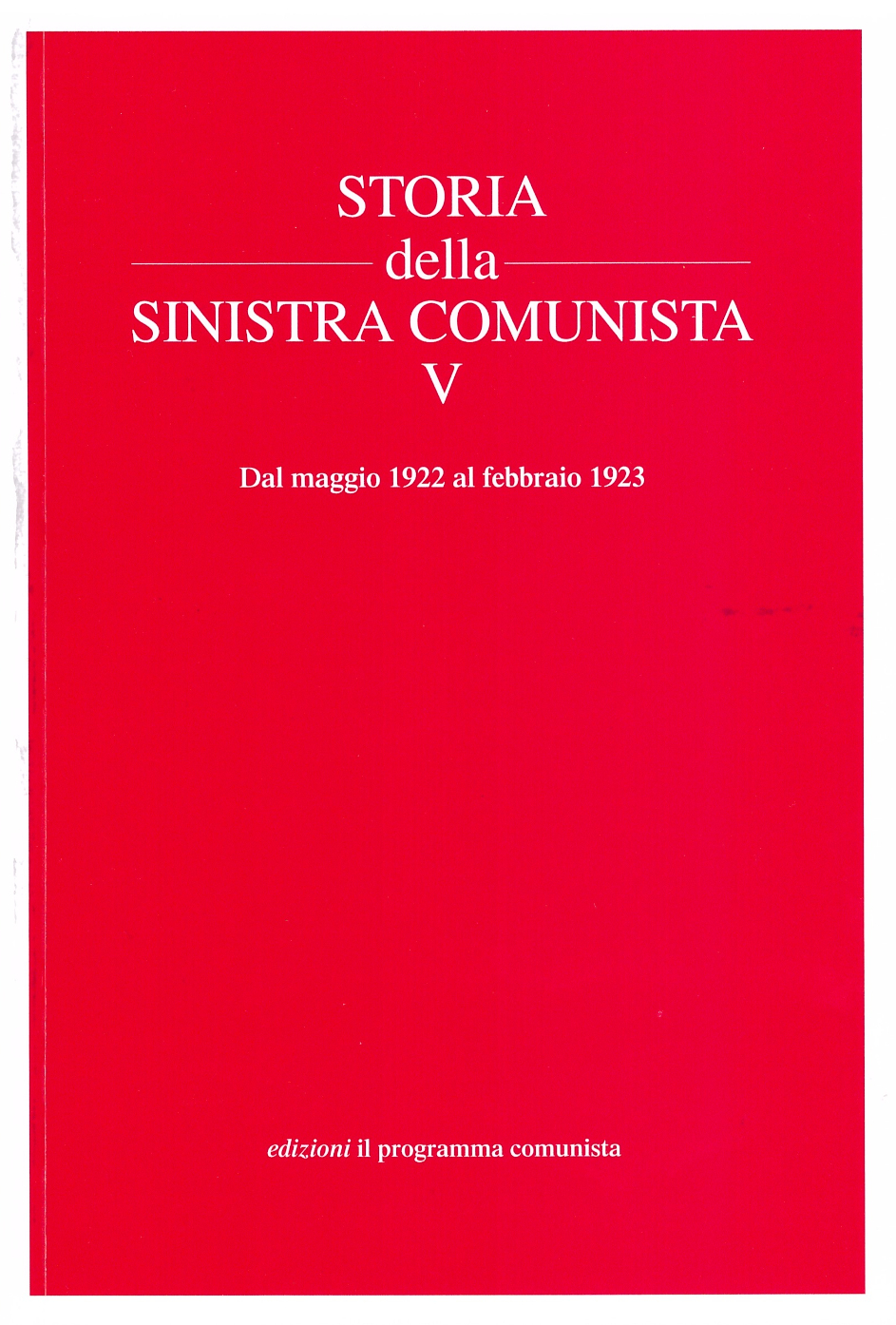La dinamica imperialista e l’illusione europeista
Nel secondo dopoguerra, la debolezza delle classi dominanti d’Europa, sconfitte o disastrate, ha richiesto la ricostruzione dei loro apparati economici, politici e militari. Gli Usa hanno diretto tale ricostruzione, accolta con grande favore dalle borghesie dei paesi vinti, in quanto premessa alla ripresa dell'accumulazione capitalistica. Il Piano Marshall ha consentito l’avvio delle ricostruzioni nazionali, una volta obbligati gli sconfitti a mettere in piedi un indefinibile manufatto chiamato “Europa”. Sarà, in ogni caso, la grande borghesia a impiantare il progetto di “integrazione economica”, a metterlo sul piano della concretezza, a difesa dei diversi interessi nazionali. La prospettiva dell’Europa “politicamente unita” è stata, invece, l’illusione della piccola borghesia dei grandi Stati europei, che ha fornito gli “spiccioli ideali”, spinta dalla necessità che il processo di sviluppo capitalistico la coinvolgesse ampiamente.
Il passaggio all'organizzazione economica settoriale (Ceca, Euratom, Pac, ecc.) fu diretto dal pragmatismo delle grandi borghesie occidentali in ripresa. Il “progetto unitario”, che ha coinvolto dai sei Stati iniziali fino agli attuali 27, ebbe il suo massimo credito nei trattati di Bruxelles (1947), di Parigi (1951) e di Roma (1957). Il progetto, fino alla fine degli anni '60, fu messo in crisi dai contrasti franco-inglesi, in un clima di forte crescita economica, e fu poi ripreso dopo la crisi valutaria del 1970, che vide l’inconvertibilità del dollaro e più tardi la cancellazione degli accordi di Bretton Woods. Più importante e determinante fu la crisi economica mondiale degli anni 1974-‘75. Sarà quindi la grande crisi finanziaria giapponese del 1987 ad accelerare i tempi dell'“integrazione economica” a direzione franco-tedesca, nell'affanno che il capitalismo europeo mostrava sotto i colpi della concorrenza tra Usa e Giappone. La traversata degli anni ’90 e il decennio successivo sono stati una spericolata corsa verso il baratro: la prima guerra del Golfo, l’unificazione tedesca e la recessione che sopravvenne, la stagnazione del Giappone, il crollo della Russia, le guerre nei Balcani, le crisi economiche e finanziarie in Asia (le cosiddette “tigri asiatiche”), la crisi economico-finanziaria americana (2000-’01), la ripresa della seconda guerra del Golfo (2003), fino all’attuale profondissima crisi economica che dura già da più di dieci anni... In questa traversata, dopo la crisi economica del 1992, vedrà la luce, nello stesso anno, il Trattato di Maastricht, cui seguirà nel 2002 l’istituzione della moneta unica, l’Euro.
L’“Europa Unita" non è mai stata intesa dalle borghesie nazionali come un unico Stato sovranazionale, con un solo Parlamento, un solo Governo, una sola Magistratura, un solo Esercito, se non nelle elucubrazioni idealistiche e retoriche di settori marginali della piccola borghesia di destra e di sinistra. In realtà, i veri collanti e acceleratori dell’unificazione europea, di natura economica, e mai politica né sovranazionale, sono state le guerre imperialiste e le crisi mondiali di sovrapproduzione. La “prospettiva unitaria” della grande borghesia non ha avuto come obiettivi, come dicevamo, che “accordi di libera circolazione delle merci” fra gli Stati, per diminuire gli effetti delle crisi economiche, che colpiscono ora uno ora l'altro di essi e tutti insieme gli Stati. Gli organismi comunitari dell’Unione europea (Consiglio, Commissione, Parlamento) rappresentano istituzioni insignificanti e sono giocoforza sottoposti alle dinamiche nazionali dei singoli Stati. Mai come adesso, nel corso della recente crisi di sovrapproduzione apertasi nel 2007-’08, ciò si è dimostrato vero. L'“Europa degli Stati” è la comunità più realistica delle “bande nazionali”.
Breve storia di integrazione economica
La storia dell’area economico-politica europea, che ha portato alla nascita della moneta unica (l’euro), è esemplare per capire la nascita della sua impalcatura. Fino al 1993, questa storia dimostra che mai l’“unità politica” è stata al centro della realtà europea. Nel 1950, si parla solo di Unione Europea dei Pagamenti e nel 1951 di Ceca (Comunità europea del carbone e dell’acciaio); nel 1955 si annuncia l’obiettivo di creare un Mercato comune; nel 1957 il Trattato di Roma istituisce la Comunità economica europea (Cee) con il compito di coordinare le politiche monetarie in funzione di un mercato comune; nel 1964 si costituisce un Comitato dei Governatori delle varie banche centrali nazionali; nel 1969 si dà incarico di un progetto per raggiungere l’Unione monetaria; nel 1972, dopo la bufera americana sulla inconvertibilità del dollaro, viene creato lo SME, il Serpente Monetario Europeo, per limitare le variazioni dei tassi di cambio tra le valute comunitarie di Germania Occ., Francia, Italia, Benelux e tra queste e il dollaro, mentre viene abbandonato il sistema dei cambi fissi di Bretton Woods. La creazione prospettata di un Fondo Europeo di Cooperazione rimane, tuttavia, un guscio vuoto. Nel 1979 appare l’Ecu (Unità di conto europea), definita come un paniere, composto da importi determinati di ciascuna valuta comunitaria, media ponderata delle valute che la compongono, in funzione del loro prodotto interno lordo.
Un accordo franco-tedesco, in quegli anni, decide di uniformare la politica monetaria sulla base della Banca centrale tedesca e per limitare le variazioni di valore della moneta si costituisce un tasso di cambio di riferimento con un intervallo di 2,25%, sopra e sotto il valore centrale, detti “margini di oscillazione”. Quando una moneta raggiunge, deprezzandosi, il margine inferiore, le banche centrali nazionali interessate vendono la moneta forte e comprano quella più debole per impedirne la discesa oltre il margine. Fallisce, tra l’altro, l’idea del Fondo Monetario Europeo che, tecnicamente, doveva ricevere il 20% delle riserve di oro e dollari delle banche centrali nazionali. La Germania, allora portavoce politica ed economica di quest’area di “libera circolazione”, ha nel marco tedesco la propria grande forza, che diviene mezzo di stabilità per gli altri paesi europei, dopo la grande fiammata inflazionistica degli anni ’70 e ‘80. Gradualmente, comunque, la Bundesbank si afferma in tutta Europa, come base istituzionale dello SME. La liberalizzazione dei movimenti di capitale rende, comunque, più fragile la stabilità dei cambi tra monete.
Da qui sorse la necessità di rilanciare, dopo molte resistenze, l’Unione monetaria. Si capì, tuttavia, che l’Unione monetaria poteva partire solo da un’unione di “monete nazionali” e che occorreva una Banca centrale europea, che nascesse contemporaneamente alla moneta unica. Tutte le banche centrali nazionali hanno, come si sa, una lunga storia: la moneta nazionale, infatti, risolve non solo un processo di smaterializzazione dell’oro ma anche un problema di integrazione del sistema capitalistico sotto il comando della borghesia nazionale. Il Trattato di Maastricht del febbraio 1992 fissò, a quel punto, le regole politiche e i quattro parametri economici e sociali necessari per l’ingresso dei vari Stati aderenti alla cosiddetta Unione Europea: a) il rapporto tra deficit pubblico e Pil non superiore al 3%; b) il rapporto tra debito pubblico e Pil non superiore al 60%; c) il tasso di inflazione non superiore all’1,5%; e d) il tasso d’interesse a lungo termine non superiore al 2%.
La ratifica, tuttavia, innescò dal 1992 una crisi valutaria (la lira e la sterlina sospesero la loro partecipazione allo SME e contemporaneamente lo scudo portoghese, la sterlina irlandese, la peseta spagnola vennero svalutate). Nel 1993 una nuova ondata coinvolse il franco francese, che costrinse ad allargare i margini di oscillazione del 15%. Gli eventi sopraggiunti confermarono, ancora una volta, l’instabilità del sistema capitalistico dovuto alla finanza pubblica, alla crisi economica e alla debolezza della Bundesbank. Finita la bufera, la convergenza si ristabilì: ma il balletto riprese inevitabilmente poco dopo. L’Istituto Monetario Europeo costituito spinse a un’azione comune le banche centrali nazionali nella messa a punto della Banca centrale europea e riconobbe come fattori determinanti gli Stati nazionali, e non la loro esclusione, e che la forza, che fino alla metà degli anni ‘90, era nelle mani del marco tedesco, ora risiedeva nell’Euro.
Fin dall’inizio, tuttavia, viene accettata la clausola dell’esclusione della sterlina inglese dall’Euro: nasce così, di fatto l’UE, a due velocità, con due monete, che porterà successivamente, nel 2017, all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea (Brexit).
La Banca Centrale Europea (BCE) è stata istituita il 1° giugno 1998, in base al Trattato di Maastricht sull'Unione europea e allo “Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea”, mentre ha iniziato ad essere funzionale dal 1º gennaio 1999, quando tutte le funzioni di politica monetaria e del tasso di cambio delle undici banche centrali nazionali sono state trasferite alla BCE. Nella stessa data, sono stati stabiliti irrevocabilmente i tassi di conversione delle monete nazionali rispetto all'Euro. Scopo principale della Banca centrale europea è quello di mantenere sotto controllo l'andamento dei prezzi e quindi il potere d'acquisto nell'area dell'Euro ed esercitare il controllo dell'inflazione, badando a contenere, tramite opportune politiche monetarie, il tasso di inflazione di medio periodo a un livello inferiore (ma tuttavia prossimo) al 2%. Il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) comprende, a norma del Trattato di Maastricht, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dei 28 stati membri dell'Unione europea, a prescindere dall'adozione della moneta unica. Solo i governatori delle banche nazionali dei paesi appartenenti all'“Eurozona”, però, prendono parte al processo decisionale e attuativo della politica monetaria della BCE. Il cosiddetto Eurosistema è infatti composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dei paesi che hanno introdotto la moneta unica. Le banche centrali nazionali dei paesi al di fuori della "Zona Euro" sono invece abilitate a condurre una politica monetaria nazionale autonoma. Fintanto che vi saranno Stati membri dell'Unione europea non appartenenti all'"area dell'Euro", vi sarà l'inevitabile coesistenza tra Eurosistema e SEBC.
Dunque, l’introduzione dell’Euro come moneta comune non ha cambiato e non cambia il significato di “integrazione economica”. Essa permette “accordi economici di settore”, ovvero “limitazioni delle produzioni” per evitare sovrapproduzioni in campo agricolo e industriale, “regolazione dei cambi” per impedire svalutazioni competitive e accordi monetari. L’Euro, come moneta comune, riconosce a ogni Stato appartenente alla comunità europea il mantenimento della propria sovranità di “azienda-nazione" nei rapporti di forza con gli altri Stati. Non c’è dubbio, però, che, con l’attuale crisi di sovrapproduzione, la “rete di interessi e di contrasti” diventerà causa del suo tracollo, da mezzo di sviluppo si trasformerà in una pesante catena. Il protezionismo americano, di cui tanto si parla a causa dei “dazi di Trump”, è oggi un aspetto derivato dalle stesse contraddizioni del capitale.
La storia delle crisi che il capitalismo attraversa sul piano internazionale mostra la natura imperialistica del sistema: economia reale ed economia finanziaria sono “perfettamente integrate”. Gli accordi di Maastricht rimangono semplici artifici che alimentano l’instabilità, invece di attenuarla. I suoi parametri (Pil, Deficit, Debito, deflazione/inflazione, tassi d’interesse), con cui si pensa di dare un “equilibrio stabile”, sono e saranno in balia dell’intero sistema capitalistico globale: cioè di quella “valanga finanziaria” che, scendendo a valle, si alimenterà sempre più, poiché la sua “dinamica reale” nasce dalla sovrapproduzione. Nessuna BCE e i suoi Quantitative Easing serviranno all’UE per stabilizzare e attenuare le immense sofferenze bancarie prodotte dalla crisi. L’incertezza nutre il mercato, alimenta la sua entropia e porta alla disgregazione l’economia reale. I “trattati”, pura cartaccia, in quanto sovrastrutture affonderanno, trascinati dalle correnti e dalle maree. La rappresentazione del ciclo economico-finanziario a tre fasi (speculazione, dinamica automatica della crisi e crisi distruttiva) è la forma che condurrà alla catastrofe l’economia borghese. Solo il proletariato rivoluzionario, riprendendo un processo che porti ad abbattere il modo di produzione capitalistico, potrà salvare l’umanità da una prossima guerra che ci farà sprofondare all’inferno,
L’Unione Europea e l’illusione della stabilità
L’illusione europeista si manifesta con la ricerca affannosa della crescita economica. Per rispondere alla concorrenza, gli Stati europei tentano, in primo tempo, di sviluppare nel territorio nazionale poli produttivi omogenei (aree, distretti, filiere, etc.). La scelta economica più razionale, dal punto di vista nazionale, non è quella di incrementare i rapporti di scambio interni all’Unione Europea, ma quello di incrementare, soprattutto in periodi di crisi, le esportazioni verso i paesi esteri emergenti, che permettono a ciascun paese di estendere i propri affari. All’estero, le aziende nazionali tentano infatti di ottenere, con lo sfruttamento intensivo della classe operaia locale, un maggiore sviluppo produttivo in spazi industriali a bassa composizione organica (costi ridotti delle materie prime, bassi salari, etc.). Lo sviluppo economico si accompagna alla crescita della produttività e alla maggiore accumulazione di plusvalore. I differenziali di crescita dei diversi paesi, a questo punto, si risolvono in un’accresciuta competitività e gli scarti tra l’uno e l’altro si allargano, creando quindi maggiore instabilità.
D’altra parte, i crediti alle economie più deboli da parte di quelle più forti conducono di fatto all’indebitamento pubblico e privato delle prime, soprattutto dal momento in cui gli indicatori economici (saggi di interesse, tassi di inflazione) vengono “governati” dalle grandi unità nazionali, le quali lasciano credere, ad esempio, che la moneta unica sia un veicolo equilibrante. Lo scarto economico è creato, per la teoria del valore di Marx, dalla differenza di produttività tra i vari sistemi nazionali, che alimenta un maggiore afflusso di proletari dell’esercito industriale di riserva, liberando nello stesso tempo, con lo sviluppo dell’automazione, enormi masse di forza lavoro. La produttività del paese più avanzato impone la sua velocità ai diversi sistemi produttivi e, quindi, i suoi prezzi di produzione. La moneta unica impedisce una reale lettura dei differenziali produttivi tra i vari paesi, come avverrebbe attraverso la ragione di scambio tra valute differenti. Inevitabilmente, le corsie di sviluppo cresceranno di numero e così le velocità relative. La svalutazione della moneta nel paese più debole (come la rivalutazione della moneta più forte) renderebbe visibile lo scarto di produttività, e darebbe modo al sistema, temporaneamente, di riparare alla contraddizione agendo sulle esportazioni: ma questo non è permesso dalla moneta unica. Nuova illusione: i differenziali di produttività non lasciano scampo, perché la situazione di debolezza (e di forza) continuerà ad ampliarsi. Ciò che la crisi di sovrapproduzione rende evidente è la divaricazione, ovvero la crescita di quello scarto che è scarto di produttività, cui non si può portare alcun rimedio se non quello di accettare le pesanti condizioni imposte dai paesi più forti, rovesciando sul proletariato il peso di un accresciuto sfruttamento. La vitalità dei periodi di prosperità, di espansione e di sovrapproduzione si converte in mortalità accentuata alla fine del ciclo: poli industriali, piccole e medie industrie, saranno spazzati via nel corso delle crisi, se non viene in soccorso una nuova e accresciuta capacità produttiva.
La cosiddetta integrazione non porterà dunque alla stabilità politica ed economica. Il processo determinerà al contrario, con la concentrazione e centralizzazione produttiva, una crescente disomogeneità economica nel territorio nazionale ed europeo, lo sviluppo di aree ad alta concentrazione capitalistica e l'impoverimento di altre. Da qui l’instabilità: la disomogeneità creerà fratture di natura economica e quindi politica. La classe dominante, a questo punto, registrerà crepe nella propria compattezza politica per la divaricazione degli interessi regionali e territoriali.
La disgregazione ulteriore dei territori nazionali diventerà catastrofica, quando gli equilibri saranno scossi da più profonde crisi economiche. La tendenza alla recessione diventerà inevitabile, là dove esistano le premesse storiche (unità territoriali forti in confronto ad aree marginali o annesse con la forza, popolazioni o etnie a debole coesione interna, imposte da precedenti guerre o zone cuscinetto, che vengono sentite come freni e pesi allo sviluppo delle più grandi).
Il rapporto Stato-territorio non è solo economico ma anche politico (la politica degli Stati è una sovrastruttura di forza, che affronta processi determinati, economici e sociali, sotto la direzione della classe dominante), per cui un’Europa diversa dall’attuale è possibile come conseguenza di nuove guerre che creino ancora una divisione del territorio nazionale o europeo, con una nuova ripartizione del bottino da parte delle borghesie vincitrici.
Sembra capitalisticamente ragionevole mettersi d'accordo per proteggere l’economia comunitaria. Ma ciò stride inevitabilmente con la natura stessa del capitale, che abbatte presto o tardi ogni vincolo o accordo. Il Capitale ha forma nazionale, ma il suo contenuto è internazionale. I mercati stessi s’incaricano, attraverso le crisi di sovrapproduzione, di distruggere qualsiasi controllo e accordo. La necessità di costituire “grandi aree omogenee” è dovuta ai grandi Capitali non controllabili da alcun organismo statale, finanziario, bancario nazionale o internazionale. Capitali che, in forme diverse, viaggiano intorno al mondo in cerca di valorizzazione, capitali che per la gran parte si valorizzano nel gioco “d’azzardo” della compravendita di titoli di vario genere, di crediti, di azioni, di monete, in ricerca affannosa di un plusvalore sempre più ridotto in rapporto alla massa del capitale globale.
La dinamica di valorizzazione spinge, a causa della sovrapposizione dei cicli economici, inesorabilmente in avanti. La dinamica parassitaria dell’imperialismo, che ha preso il sopravvento già da un secolo sull’economia reale con i suoi tassi medi di profitto, sempre più insufficienti all’accumulazione allargata del Capitale, mostra che l’immensa massa di “capitali fittizi” è capace di distruggere intere nazioni di prim’ordine portandole alla bancarotta. Tutto ciò è un segno inequivocabile della dominazione reale del Capitale sullo Stato e sugli Stati.
La" giungla” di nazionalismi, le politiche di difesa e il proletariato nell’Unione Europea
Dal fatto che la potenza economica tedesca sia il baricentro materiale della realtà europea, e che l’integrazione economica attuale sia giunta a richiedere la fondazione di un’unità monetaria e di una Banca centrale europea, non discende che “l’unificazione politica europea” sia possibile. Noi non stiamo assistendo a una qualche svolta nel panorama geopolitico della cosiddetta “Europa unita”. La lettura in chiave politica dell’integrazione “economica e monetaria” come transizione verso l’unità politica manca di realtà e di prospettiva storica. La tempesta valutaria che si ebbe nel 1992, ad esempio, non può essere letta come “crisi di fiducia verso la prospettiva politica”, perché quella fiducia non è mai stata all’ordine del giorno di una borghesia sovranazionale: semmai è di casa nelle illusioni della piccola borghesia, che attraversa fasi di ubriacatura ottimista e di negazione pessimista. Il fatto che lo scontro fra monete manifestava, allora, su scala continentale, la contraddizione tra il sempre più pronunciato carattere internazionale dell’economia capitalista e l’involucro nazionale, in cui essa è inesorabilmente costretta a muoversi, non significava la necessità che essa si traducesse sul piano reale e concreto nella strategia volta a mettere la Germania al centro dell’unificazione europea.
Tra potenzialità e necessità c’è uno scarto che non si colma con la logica formale. Il fatto che gli accordi monetari e commerciali non garantiscono stabilità e coesione nel Vecchio Continente discende proprio dalla realtà dell’economia capitalistica e dalla sua anarchia; la contraddizione tra carattere internazionale e involucro nazionale è il risultato della dinamica intrinseca e originaria dell’economia capitalistica. La Germania non ha raggiunto né raggiungerà questo traguardo unitario per la stessa ragione per cui non l’ha raggiunto neppure dopo i due conflitti mondiali. Chi potrebbe contestare la tendenza storica verso quella possibilità? Ma non basta la tendenza, occorre la forza materiale. Solo la forza e la vittoria nazional-socialista avrebbero dato senso a un obiettivo di tale portata, ovvero all’unificazione europea. Ma la storia è stata un’altra: la vittoria-pacificazione imperialista russo-americana del secondo dopoguerra ha consentito di “recintare” quella tendenza e di depotenziarla in un lunghissimo spazio di tempo, imponendo il controllo politico e militare russo-atlantico. L’obiettivo necessario e vitale di annodare legami politici irreversibili non potrà realizzarsi proprio per il fatto che l’Europa non può produrre tali legami motu proprio (non si tratta solo della presenza di “nazioni senza storia”, ma anche di forti aggregazioni politico-economici, dentro e fuori d’Europa), neppure se l’integrazione economica e monetaria raggiungesse livelli straordinari.
Una pesante illusione economica è quella di credere che le economie capitalistiche europee porteranno alla scomparsa dei nazionalismi. L'Europa ha vissuto storicamente sempre sotto pressione dei grandi nazionalismi (da Napoleone III a Bismarck, da Versailles a Yalta), tanto più virulenti quanto più dal seno dell'Europa sono partorite con la violenza nuove nazionalità e nazioni, prima tenute strette dentro contenitori imperiali (impero ottomano, impero austro-ungarico, impero russo). Duecento anni di storia europea hanno mostrato il divampare di nuove guerre dietro la spinta delle nazionalità vecchie e nuove, reali e fittizie. La divisione della Germania dopo la seconda guerra mondiale, subita a opera degli imperialismi vincitori, e la sottomissione dei paesi dell'Est europeo sotto la Russia hanno solo spostato nel tempo lo scatenarsi delle guerre. Il crollo della Russia ha esaltato i nazionalismi tenuti sotto chiave e ha generato anche la disgregazione dell'area balcanica. Dal 1989, anno della frantumazione russa, il territorio europeo è percorso da nuovi processi nazionalistici. La potenza economica tedesca alla lunga sarà spinta a fare i conti con gli Stati vincitori di ieri, Usa e Russia, scalzandoli dall'Europa orientale e balcanica. Dire Germania significa, tuttavia, nei fatti, la rinascita del Grande Nazionalismo, che risveglierà nuove guerre in Europa.
Dopo la caduta del muro di Berlino, è scattato un vero festival del “principio di autodeterminazione dei popoli”. In nome del cosiddetto “diritto dei popoli”, sono state spinte e messe in scena presunte nazioni e comunità tenute prima sotto controllo e si sono alimentate antiche nostalgie nazionaliste dietro le quali si nascondono i grandi interessi economici. Un quadro d’insieme mostra il carattere sistemico della instabilità politica generale.
La Mitteleuropa si è risvegliata con le sue nazioni storiche e le sue entità nazionali, dall’Austria alla Slovenia, dalla Slovacchia fino all’Ungheria e alla Polonia (Area Visegrad). Nei Balcani, si è scatenato l’inferno: Serbia, Croazia, Bosnia, Erzegovina, Kossovo, Macedonia, Albania, Montenegro. Nell’Area Baltica, si sono riaffacciate vecchie alleanze e vecchi odi: Polonia, Lettonia, Estonia e Lituania, nutrite di russofobia, la prima molto antica per formazione, capace di accrescersi come un’idra e le altre inventate di sana pianta – piccole pedine poste di traverso alla Russia. Sul fronte nord d’Europa, nel Regno Unito (vera colonia americana), premono tradizionali spinte autonomiste (Scozia, Galles, Nord Irlanda), nutrite di atlantismo. In Spagna, agiscono spinte autonomiste catalane e basche. Anche il baricentro dell’Unione Europea, imperniato sull’area franco-tedesca, si va trasformando. Alcuni contrasti sono venuti in superficie: la bocciatura franco-olandese del Referendum europeo, la crisi politica in Belgio e la sua divisione interna, la rapida conversione all’europeismo di Polonia e Repubblica Ceca pronto a mutare il proprio volto nel mezzo della bufera economica, il decisionismo imperialista di Sarkosì, di Hollande e di Macron in Africa (Mali, Libia) e il duro no della troika finanziaria europea e atlantica all’intervento in sostegno della Grecia, Portogallo, Spagna, Italia, Irlanda, sono tutte manifestazioni di tempeste in arrivo.
A queste contraddizioni vanno connesse la “posizione non interventista” della Germania nella II guerra anti-irakena, lo “stop” allo scudo missilistico americano in Polonia e nella Repubblica ceca, lo sviluppo dei rapporti di scambio con i paesi est europei (che poi non sono altro che i vecchi satelliti di Mosca) e l’intrecciarsi degli interessi con la Russia, rapporti legati all’energia e alle materie prime (gas e petrolio). Se aggiungiamo il non intervento tedesco in Libia e la sua posizione defilata in Siria, la resistenza a un intervento chiaro in Ucraina (Donbass e Crimea) contro la Russia, si comprenderà che gli interessi comuni europei e le tradizionali alleanze occidentali non sono affatto più convergenti, ma è giocoforza che le intese durino fino a quando le alleanze di guerra non si saranno ben definite. Forze centrifughe agiscono di concerto a quelle centripete, svuotando di senso quegli stessi Stati, creando un vuoto di legittimità politica e di centralità. Uno Stato centrale non ha un surrogato nella somma di regioni o in una qualsiasi altra architettura comunitaria. Il “federalismo funzionalista” con cui è stata messa in piedi la Grande Illusione dell’Unione Europea si va sgretolando sotto l’incalzare della crisi economica, mentre i particolarismi nazionali e regionali e i populismi prevalgono sulla cosiddetta “solidarietà comunitaria”, e verrà tempo in cui per nutrire la classe media, alla piccola borghesia regionalista che starnazza per colpa della crisi si dovrà offrire in cambio una guerra nazionalista e un proletariato in ginocchio.
Non basta. Le politiche nazionali dei singoli paesi dipendono dalle contraddizioni economiche interne ed estere che il processo capitalistico porta avanti. Esse non sono dirette a integrarsi a un livello sovranazionale. Tutte le politiche “europee” sono semplici supporti alle politiche nazionali, oppure rispondono a esigenze di natura particolare e contingente. Per essere tale, l'unità politica interna richiede, come dati centrali “la sicurezza e la difesa”, che hanno un carattere puramente nazionale. Non c'è unità senza forza coercitiva e l'unità politica non può non essere uno Stato politico, uno strumento di repressione e di violenza: quindi, la difesa degli interessi nazionali e l’unità politica sono la premessa essenziale dell’esistenza politica dell’Unione Europea. Il fallimento della CED (Commissione europea di difesa) degli anni '50 fu determinato dalla mancanza dell'unità politica. Ad assestarle il colpo decisivo fu la Francia, il cui ruolo di "grandeur" volle sempre essere riconosciuto anche all'interno della stessa Alleanza Atlantica, da cui poi si allontanò, per riavvicinarsi oggi mentre l’odore della polvere da sparo si fa più forte. Tutti i tentativi di costruire una struttura unitaria di natura militare senza unità politica sono falliti. Il tentativo di mettere in piedi un “Esercito comune europeo”, per iniziativa franco-tedesca, è andato in fumo…
Esistono alleanze temporanee ed estemporanee: ma non “unità politiche sovranazionali”. Non esiste un “processo graduale” che dall'integrazione economica porti all'Unità politica e da qui alla Difesa militare comune, perché non esiste in realtà un tale processo, se non nelle fantasie piccolo-borghesi. Un’unità (a meno che si tratti di alleanza prebellica, sempre provvisoria, o di integrazione politica coatta) è impossibile nel quadro dei rapporti borghesi. A maggior ragione lo è una struttura militare che significhi sicurezza e difesa comuni.
Se mai vi si giungesse, un’“Europa democratica dei popoli” come la si sognava nel secolo scorso sarebbe la più alta manifestazione della potenza economica degli Stati borghesi, espressione della forza militare che precede la guerra per una nuova spartizione continentale. Sarebbe un'Europa reazionaria antiproletaria sottoposta al grande Capitale, centralizzata su alcuni Stati che non temono di confrontarsi sul continente europeo. Nel caso auspicato dalla piccola borghesia di sinistra, non avrebbe bisogno di esibire nell’immediato la sua faccia dittatoriale, perché essa potrebbe servirsi del “consenso socialdemocratico”, nel senso dell’attuale miserabile “stato sociale”. Per rispondere colpo su colpo alle lotte economiche di difesa della classe operaia, questo metterebbe in campo il suo potente apparato di controllo, i sindacati di regime pienamente integrati in un tale corpo reazionario, allo scopo di reprimere il proletariato, premessa al pugno di ferro della potenza economica borghese egemone verso l'esterno e verso l'interno. La sua energia potenziale si esprimerebbe al massimo grado, pronta a trasformarsi in energia cinetica. Nella sua versione socialdemocratica, essa non sarebbe altro che il massimo involucro controrivoluzionario per resistere alla rivoluzione comunista.
Al contrario, l’Europa della dittatura continentale proletaria è l’unica potenza rivoluzionaria che può decidere il futuro dell’umanità. Essa porterebbe l’umanità fuori dalla catastrofe bellica, spezzerebbe definitivamente i vincoli nazionali e spingerebbe alle estreme conseguenze lo sviluppo internazionale delle forze produttive di classe. Poiché sarebbe impossibile una coesistenza tra paesi capitalisti e paesi a dittatura proletaria, lo scontro tra le due forme di dittatura di classe, che rappresentano forme economiche di produzione antitetiche, se non risolta dalla vittoria di una sola delle due classi, dissolverebbe in modo cruento entrambe le classi in lotta. La morte della forma capitalista di produzione dimostrerà il carattere transitorio del suo modo di produzione alla scala storica. L'Europa politicamente unita sotto la dittatura proletaria internazionale, rotti i vincoli continentali, si appresterebbe allo smantellamento internazionale del capitalismo.
La vittoria russo-americana, la riunificazione tedesca, la disgregazione della Russia e la stabilità
Solo a partire dalla fondazione della nazione tedesca nella guerra franco-prussiana, i problemi dell'Europa coincidono con quelli della Germania moderna. “Germania” significa, dal 1871, grande potenza economica nel cuore dell'Europa e primo tentativo della classe operaia di costituirsi in classe dominante nel corso della Comune di Parigi. La classe dominante borghese, allora, ha fondato il suo Stato nazionale (passando sopra i tanti staterelli con moneta propria) con la sua moneta, con la sua banca centrale. Successivamente, si è dotata di un'organizzazione politica federale, a matrice prussiana: quindi, a struttura economica centralizzata militarmente e burocraticamente, arricchendosi di esperienze aggressive sia contro i vicini (Danimarca, Svezia, Austria, Polonia, Cechia, Francia) sia contro il proletariato. Spinta dalle sue grandi forze produttive e dotata di una forte organizzazione sindacale (“aristocrazia operaia” fortemente centralizzata sullo Stato), si trova da allora a condividere il continente europeo con altre unità statali incapaci tuttavia di reggere il confronto dal punto di vista politico ed economico, condizione squilibrante per l'Europa. Tutte le componenti politiche, articolazioni della borghesia tedesca, hanno concorso all'affermazione della Grande Germania.
Il Terzo Reich, dal 1933, con la centralizzazione del potere politico, economico e finanziario, con il superamento della vecchia struttura federale, si è permesso una crescita economica superiore a quella della Germania bismarckiana, divenendo il più avanzato strumento di una unificazione europea, sotto il maglio della violenza centralizzatrice della borghesia più avanzata d’Europa. Sia nella prima guerra mondiale che nella seconda, la Germania ha manifestato la volontà di raggiungere quest’obiettivo. Una tale unificazione, asservendo gli Stati confinanti, avrebbe permesso la nascita di un solo grande Stato Europeo, del quale avrebbero potuto far parte la Repubblica Ceca, parte della Polonia, l’Austria, il Belgio, il Lussemburgo, la Danimarca, l’Olanda, l’Alsazia e la Lorena. Questa “Grande Germania” si sarebbe presentata come una gigantesca forza economica a forte dimensione demografica. L’unificazione del 1990 ha inaugurato un lungo periodo di recessione, dimostrando con ciò quanto necessaria e vitale fosse quella unificazione e duro il controllo russo-americano sull’Europa e in particolare sulla Germania. Il periodo della cosiddetta “Guerra fredda” aveva congelato la realtà tedesca da occidente ad oriente. La disgregazione della Russia e la pesantissima crisi economica e sociale che ne è seguita hanno messo a dura prova il territorio est europeo e le relazioni con la Germania. Dalla Polonia alla Cecoslovacchia, dalla Romania all’Ucraina, dalle minute entità nazionali del cosiddetto Mediterraneo baltico alla Moldovia, è stato tutto un agitarsi economico e politico di debolissime entità nazionali.
Solo tenendo conto della dinamica (molto più complessa di quella del secolo XX) che agita in profondità la base economica della cosiddetta Europa tedesca, si potrà capire lo stato del prossimo conflitto mondiale, al cuore del quale ci sarà ancora la Neues Deutschland. La crisi recente di Portogallo, Grecia, Irlanda, Italia e la paura della dissoluzione dell’unità monetaria dimostrano la fragilità di tutta l’impalcatura economica europea.
L’affermazione delle potenze vincitrici (che la tutela russo-americana nel secondo dopoguerra avesse portato stabilità in Europa) era diventata un luogo comune che giustificava l’aggressione avvenuta sulla Germania e sull’Europa. Gli interventi politici, le interferenze della Nato o del Patto di Varsavia sui due fronti, erano diventati nel corso della “Guerra Fredda” i due grandi fattori di instabilità (muri, corridoi aerei, truppe dislocate, fughe, ricongiunzioni con le famiglie, ecc.). La spartizione russo-americana era arrivata, utilizzando una potente forza d’urto (occupazione militare di tutto il territorio tedesco, quello italiano ed est-orientale) e l'Europa aveva avuto la sua “sistemazione coatta” con gli accordi di Yalta. La divisione del proletariato tedesco era stata la soluzione finale della Santa Alleanza dei vincitori. “Guai ai vinti!”, era stato il loro grido di vittoria contro il proletariato. La finzione dell’“Unità Europea” nel secondo dopoguerra e la sua “stabilità” coincidevano, dunque, con la divisione territoriale (su base militare e politica) soprattutto della Germania (Repubblica federale da un lato e Repubblica democratica dall’altro, in due Stati separati) e con l’occupazione di tutto l’est europeo. Tratti di penna su pochi fogli erano serviti ai banditi convenuti a Yalta per delimitare i territori degli uni e degli altri, in cui la Yugoslavia di Tito e quindi dei Balcani faceva da cerniera. Sotto la cosiddetta “distensione”, si nascondeva la violenza sottesa alla divisione territoriale e alla normalizzazione generale europea. Le lotte (proletarie e nazional-borghesi) a Berlino nel 1953, a Budapest e Varsavia nel 1956, a Praga nel 1968, a Danzica nel 1980 furono anche i più importanti tentativi di uscire dalla realtà di occupazione militare, sia a est sia a ovest (truppe di occupazione, collocazione di sedi Nato, aree di controllo nei punti chiave produttivi del territorio, sia in Germania che in Italia, smilitarizzazione forzata, imposizione monetaria e finanziaria). La divisione era stata completata, da una parte dalle masse di crediti giunti dagli USA (Piano Marshall), com’era avvenuto nel primo dopoguerra, e dall’altra dal massiccio spostamento, dalla Germania democratica in Russia, di attrezzature, macchine, strutture produttive, più avanzate tecnologicamente di quelle russe: disarmo, quindi, economico e militare della “Germania democratica” a est e sottomissione finanziaria e militare a ovest. L’occupazione militare, politica e amministrativa aveva permesso di disarticolare la macchina produttiva e distruggere quella bellica della Germania da entrambi i lati. Con la disgregazione dell’impero russo e la diminuzione relativa del controllo americano sulla Germania riunificata, è cresciuto il grado di precarietà generale dell’Europa.
L'idea di stabilità nasce da considerazioni politiche piccolo-borghesi (nelle loro varianti pacifiste, europeiste e filotedesche). In regime capitalistico, lo status quo, ai fini della normalizzazione, può derivare o da un “equilibrio di forze” o dalla presenza di una “superpotenza” che controbilanci con la forza gli squilibri dinamici, adeguandosi rapidamente alla loro variazione. In realtà, l'Europa, uscita dalla disgregazione dell’impero russo e dalla riunificazione tedesca, dagli anni ’90 a oggi, mostra uno stato di provvisorietà economica e politica e fa presagire nuovi sommovimenti futuri. L'accelerazione verso l’aggregazione economica e politica europea e la spinta verso la Russia mostrano questa instabilità: le linee principali di frattura, infatti, si sono allargate a Est. Il piano inclinato ha fatto dilagare la macchina economico-industriale e quindi politica della Germania in quella direzione. Le sue tradizionali linee di straripamento sono oggi come in passato la Polonia e i paesi baltici a nord, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Ucraina al centro e i Balcani a sud attraverso l'Austria, la Slovenia, la Serbia e la Croazia verso l’Adriatico. Mentre si consolidava con l’unificazione la Germania e si disarticolava la Russia, si destabilizzava contemporaneamente oltre all’Est europeo anche tutta l’area balcanica. Non dunque il ricompattamento dei Balcani, di cui si filosofeggiava (la “libertà dei popoli balcanici”!), che il secondo conflitto bellico aveva faticosamente unificato con Tito, ma la disgregazione dietro le pipelines e i gasdotti che attraversavano i corridoi balcanici fino al cuore della Germania. Gli effetti della riunificazione tedesca, come uno tsunami, si sono propagati fino al punto di disgregare (in parallelo e in sincronia) l’impero russo di un tempo e i Paesi balcanici fino ai confini della Grecia. L’appoggio americano alla Russia nel periodo di transizione dopo la caduta del muro è stato necessario per la ripresa politica del paese: in particolare, l'appoggio a Gorbaciov e ad Eltsin ha evitato un’instabilità economica catastrofica, che si sarebbe scaricata sulla Polonia e sull'Ucraina agevolando il processo di straripamento tedesco.
Il posizionamento della Nato a Est ha oggi due facce: una rivolta alla Germania unificata, l’altra rivolta alla Russia, tendenzialmente destinata a ritrovare le vecchie posizioni imperialiste nell’Europa orientale e nell’Asia. Su un altro versante, incastrato tra l’Est europeo, la Turchia e il Medio Oriente, entra in crisi anche tutta l’area caucasica, ricca di gas naturale e petrolio: nasce il caos ceceno e georgiano, quello dell’Ossezia, dell’Azerbajan e soprattutto dell’Afghanistan, che ha visto sul suo terreno battersi i talebani, appoggiati dalle armi americane, contro i russi. Fallita la “casa europea" di Gorbaciov (filotedesca), il territorio est-europeo è e sarà attraversato sempre più da trasformazioni destabilizzanti. Una “via solitaria” della Germania verso Est o in stretto legame con la Russia (rapporti di scambio materie prime- tecnologia) fuori dall’accordo a Ovest, muterebbe lo scenario strategico del dopoguerra (il cosiddetto patto franco-tedesco, la rigida visione europeista e gli occhi puntati contro la Russia). Le linee-guida della politica non sono mai "vie libere": sono tracciati geopolitici che scorrono sulle linee-forza del capitale, che continua, nella sua “sostanza internazionale”, a essere imprigionato nella “forma nazionale”. Tagliarle significa sconnettere il sistema di “equilibri dinamici” (dettati dall’anarchia del sistema) presenti fino a questo momento.
La Germania europea e le nazioni antagoniste
Per la Germania, essere un’incontestabile potenza nella realtà continentale europea, tra tanti altri Stati vicini, è stata una grossa calamità, e non un segno di fortuna. Il co-dominio continentale nei due conflitti mondiali (GB, Germania, Francia) la spinse a “guerre lampo” con milioni di morti. La dinamica storica non ha consentito alla “volontà di potenza” di esercitare fino in fondo il proprio ruolo. La ferma volontà (di cui si esagerano i disegni politici, sia nel passato che nel presente) di giungere con Kohl all’unificazione è costata un decennio di staticità e di crisi di crescita.
La Gran Bretagna, l’insulare antagonista storico, ha visto nell’Unione monetaria l’occasione di un’area di libero scambio, un grande mercato. Rigettando ogni vincolo comunitario, essa ha visto con diffidenza la prospettiva di una sovranità tedesca in Europa, ratificata e rafforzata da un’effettiva politica-monetaria e, tuttavia, non è rimasta fuori dalla storia europea. E’ rimasta, come ha fatto in passato, appoggiandosi agli Usa, in attesa di nuove occasioni per entrare ancora in scena, perché voglia o non voglia, la Gran Bretagna è parte centrale della storia europea. L’uscita dal contesto comunitario con la Brexit lo ha ampiamente dimostrato.
La Francia, continuando al contrario con la vecchia politica coloniale in Africa, non ha rinunciato alla grandeur e non ha accettato né accetterà una politica subordinata ai suoi antagonisti storici, Gran Bretagna e Germania. Ha tenuto per lungo tempo in piedi un’alleanza politico-economica con la Germania, spingendosi fino a comuni esercitazioni militari. Non è stata un caso la condivisione pacifista a fianco della Germania nella Seconda guerra irakena. L’asse franco-tedesco con cui è stata ricostruita nei due paesi l’economia del dopoguerra, e si è condiviso il percorso di integrazione economica a partire dalla fine degli anni ’70, si è concluso con il cambiamento delle ragioni storiche della stessa riunificazione tedesca. La funzione di tutori storici della stabilità europea, assegnato loro nel primo e secondo dopoguerra, alleati scomodi ma necessari l’una all’altra per avallare la collocazione a occidente e il controllo delle spinte politiche a est, ha inteso quel legame come strategico. La direzione delle alleanze e contemporaneamente delle spinte antagoniste non nasce e vive in eterno, dipende sempre dagli eventi economici e da fattori di forza determinati dallo sviluppo del capitale. Pur costrette a integrarsi, Francia e Germania saranno indotte, in futuro, a far sentire maggiormente la loro diversità: saranno costrette ad allargare il loro raggio d’azione, a favorire l’allargamento della loro massa economico-demografica (che per nulla può dirsi unitaria dal punto di vista politico), a spingersi verso gli altri paesi dell’Est Europa, contrastandosi nel rapporto “organico” russo-tedesco, soprattutto nelle aree cuscinetto e in quelle baltiche. Non servono forzature d’ordine politico ad est per la ragione che i “paesi cuscinetto” hanno una loro storia di integrazione economica e politica con la Russia, che tenta di recuperarle allo spazio economico perduto, sottoposte alla trazione politico militare americana della Nato. La dinamica economica del Capitale agisce comunque fortemente dal versante russo con le sue connessioni energetiche – gasdotti e oleodotti.
La Germania è stata e rimane ancora l’unica nazione non euroscettica (è l’unica in assoluto che economicamente ha tratto il vantaggio di competitività), mentre gli altri Stati, di fronte alle sfide politiche o economiche, di volta in volta si sono defilati, soprattutto nel corso delle crisi. Il progetto “tedesco” di unione monetaria è concepito e sostenuto in nome della propria stabilità economica e della definizione migliore della propria area di influenza: perciò l’Unione monetaria europea è una pura integrazione attorno al marco-bis, chiamato euro. Se aggiungiamo che il capitalismo mondiale impone, per uscire dalla crisi rapidamente, un’immensa massa di capitali, la quale si risolverà inevitabilmente in una maggiore spinta nazionalistica e protezionistica, si comprende che le decisioni della Merkel, per salvare l’impalcatura europea “sovradimensionata”, sono legittime. Sono legittime, perché quell’impalcatura che si chiama Unione europea poggia su poche strutture solide, e pesa su quel centro di forza che è la Germania stessa, che oltre ad accrescere la propria massa di profitti, e in presenza di una manodopera indigena coesa, affonda le radici su una massa immigrata fortemente controllata e controllabile, capace di allargare il consumo produttivo di una massa accresciuta di popolazione attiva e di riserva e insieme improduttiva (classi medie e aristocrazia operaia), capace di delocalizzare produzioni e di esportare merci e capitali ovunque. Sono fondate, quelle decisioni, perché, al crescere della crisi, la realtà che si stringe loro attorno entrerà presto in stato di decomposizione con l’emergere dei contrasti della triade Usa, Germania e Cina.
La forza militare ed economica esercitata dal capitalismo più forte, quello tedesco, alla lunga non ha retto alle grandi sfide del secolo scorso nel contesto capitalistico mondiale e non reggerà neppure oggi, sia nei confronti delle grandi potenze industriali ormai “invecchiate”, sia nei confronti delle nuove giovani forze capitaliste d’Asia. Il che può voler dire che l’asse delle contraddizioni della vecchia Europa, schiacciata da Occidente e da Oriente, potrebbe divenire, ancora come in passato, ma per determinazioni di più ampia portata, la zona delle tempeste future. Questa direzione di marcia verso Est e a massa demografica rafforzata (83 milioni) è condizionata “negativamente” dal processo comunitario, che istituisce a suo detrimento un insieme di vincoli. E tuttavia, senza di essi, si scatenerebbero le più grandi chiusure protezionistiche e svendite politiche; perciò si può capire che la Germania, esportatrice assoluta, resterà inchiodata a questa necessità di allargamento continuo, lento ma significante, a meno che eventi di grande portata la inseriscano in una grande alleanza strategica, evitando quella via solitaria o la subordinazione a questa “comunità economica”, che rappresenta oltre che una necessità, una trappola.
Nel frattempo, andrà a perdersi l’unità politica, fondata su nulla di comune, se non sui parametri econometrici. I paesi più deboli saranno in vendita al maggior offerente (economico politico e militare), piuttosto che avere come unica direttrice di marcia l’Europa felix. La subordinazione dei paesi deboli si “vince” nel frattempo nel compromesso economico da giocare giorno per giorno, crisi dopo crisi, non nell’alleanza coatta all’interno di un’unità fittizia. Per questo la questione tedesca s’identificherà sempre più con la questione europea solo in chiave nazionale e nazionalistica. Pensare che il Parlamento europeo, il Consiglio d’Europa (una sorta di Camera alta degli Stati) siano i presupposti politici dell’Europa unita (su modello istituzionale dello Stato tedesco esteso alla scala continentale), di cui l’unione monetaria sia il collante, il nocciolo duro che, una volta allargato, sia data la direzione verso l’Unità europea, significa non capire la relazione tra economia e politica, che si risolverebbe come una semplice equazione di primo grado. Affermare che l’impegno politico-economico degli Stati, soprattutto di quello tedesco, sia la svolta strategica verso l’Europa unita, che questa strategia stia forzando i tempi verso la convergenza, che le difese (salvare il salvabile!) delle proprie industrie nazionali siano solo stonature estemporanee in attesa che la realtà della moneta unica bandisca ogni protezionismo dallo scenario comunitario e internazionale, significa non capire nulla di questa realtà fragile e inverosimile.
L’Europa tra globalizzazione e protezionismo
La paura dei protezionismi, la difesa a oltranza della produzione nazionale, la chiusura alle importazioni rilevano i segni di un cambiamento generale in corso. Le frequenti considerazioni sul risanamento economico, sulla necessità di abbassare i deficit di bilancio e il debito pubblico, l’attenzione sulle politiche anti-deflattive per contrastare la tendenza al rallentamento dell’economia e per rimettere in forma nuova il cosiddetto welfare, il “benesserismo” (ovvero il potere d’acquisto crescente dei salari, l’occupazione di massa con la rimodulazione della flessibilità e della precarizzazione del lavoro), mostrano che l’economia reale è sempre più dipendente dalla struttura finanziaria e dalla condizione sempre più miserabile della classe operaia. Oggi, nel pieno della crisi, tutto si trasforma: i bilanci in rosso si generalizzano, la deflazione si congiunge alla precarizzazione del lavoro e alla più acuta miseria crescente, l’economia reale sprofonda e gli ammortizzatori sociali si impongono per evitare lo scontro sociale. Si esaltano gabbie salariali regionali, si promettono “utili” aziendali al posto dei “salari”, legandoli alla produttività, si allungano i tempi di lavoro nei contratti, si fanno più frequenti ma meno intense le agitazioni e gli scioperi. Mentre si liberano capitali “svalorizzati”, crediti inesigibili, “titoli spazzatura” per investimenti e per attività finanziarie (in realtà, capitale morto), si attaccano i salari e l’occupazione, chiudono grandi e piccoli complessi industriali, cade il saggio di profitto e con esso si riducono i sostegni economici all’industria e all’agricoltura. Un mercato non condizionato da protezionismi (senza dazi, senza barriere) è solo un’illusione, sarebbe un mercato “libero in assoluto”. Pensare le forze produttive libere dal controllo dello Stato e nello stesso tempo pensare lo Stato come il vero architetto dell’economia capitalistica, significa non comprendere il rapporto dialettico che esiste tra economia capitalistica e Stato. E’ economicismo (e quindi materialismo volgare) ritenere, d’altro lato, che la creazione di moneta (in quanto prerogativa dello Stato nazionale), demandata a un organismo sovranazionale come la Banca centrale europea, che ha comunque il suo limite nelle banche nazionali, possa portare la realtà capitalistica europea a un livello politico superiore.
La vecchia politica di sostegno agricolo (le liti furibonde del nazionalismo agricolo francese, inglese, italiano e oggi polacco), il superamento dei parametri di Maastricht da parte di Francia, Germania e Italia (flessibili come gomma – a causa della crisi economica – ma non flessibili per gli altri paesi più deboli) e l’azione di difesa delle proprie industrie energetiche da parte degli Stati francese e italiano (vedi l’affare Enel contro Edf in Egitto), non vanno verso l’equilibrio, ma verso lo scontro. Se inseriamo tutto questo in un quadro internazionale, quello che ha visto Germania e Giappone sottomettersi (accordo all’Hotel Plaza di New York sui tassi di cambio sottoscritto il 22 settembre 1985) alla politica economica americana, prima con la svalutazione del dollaro e poi con la sua rivalutazione, e se aggiungiamo che da questa ultima crisi 2007-8 Germania e Giappone potrebbero uscire sconfitte politicamente ed economicamente, strette nella morsa Usa-Cina per effetto anche delle economie emergenti d’Asia, allora si capirà che all’ordine del giorno c’è una sola via d’uscita per le due nazioni imperialiste: la ripresa della loro politica di potenza.
Il protezionismo all’interno di un’area di cosiddetto libero scambio non muore, così come non muore all’interno di uno Stato (le sovvenzioni in casa non sono altro che forme di protezionismo della grande industria). Le differenze di prezzi fra regioni industrializzate e aree depresse, che nessun istituto statistico può nascondere, tra prodotti agricoli e industriali, tra salari e stipendi, non sono che forme di protezionismo, che non fanno che creare divaricazione crescente tra ricchezza e povertà e quindi tra centralizzazione e concentrazione del Capitale. Se questo protezionismo si amplia sempre di più a livello internazionale con dazi sulle materie prime, sui beni alimentari ed energetici e sulle tecnologie, se blocca le importazioni straniere e allarga le esportazioni, il mercato finisce con il negare se stesso. Il modo capitalistico di produzione determina, poco alla volta, fratture tra nazioni, tra paesi, tra aree, tra regioni, tra continenti, tra aziende a basso saggio di profitto (più moderne) e altre ad alto tasso di profitto (aziende più arretrate). La tendenza allo sviluppo sempre più spinto di monopoli, che non possono più essere contenuti entro confini nazionali, non è una scoperta della cosiddetta globalizzazione, una sorta di confine tra il vecchio capitalismo e quello nuovo. La concorrenza su scala planetaria è cresciuta, ma non è un prodotto recente del capitalismo. La crescita di gruppi industriali dalle dimensioni sempre più colossali, in grado di controllare il mercato continentale da posizioni di netto vantaggio, non per questo elimina il protezionismo nazionale, intraeuropeo o continentale. Un protezionismo comunitario forte nei confronti dei concorrenti implicherebbe un’avvenuta “unità economica” che si autoflagella e un’unità politica che si autoesclude.
L’effetto sarà la nascita nei prossimi anni di conflitti commerciali tra aree comunitarie e a maggior ragione tra aree continentali, e quindi di contrasti politico-militari. Un tale scenario si accompagnerà all’oggettivo fallimento politico monetario europeo. Che questi eventi possano dar luogo a nuovi scenari non c’è alcun dubbio: ma pensare che l’imperialismo americano o quello cinese siano quei “fattori soggettivi” che sconvolgeranno l’assetto europeo e, con esso, anche le vecchie potenze imperialiste e in particolare la Germania, muovendosi “liberamente” sullo scenario mondiale, significa credere a un’onnipotenza del Super-imperialismo, che va al contrario sgretolandosi. La realtà storica mostra, all’analisi dei fatti, maggiore complessità di quella costituita razionalmente: non dipende solo dalla volontà dei concorrenti, ma dalle gigantesche forze economiche che entrano in conflitto.
La dipendenza politico-militare della Germania nel contesto internazionale
La forza politica e militare della borghesia è connessa sempre alla sua forza economica. La Germania parrebbe fare un’eccezione: economicamente forte ma politicamente debole, la borghesia tedesca ha una potente struttura industriale capace di conversione bellica (non a caso, l’acciaio e l’alluminio sono al centro del contrasto sui dazi americani). L'asse franco-tedesco, il legame militare con gli Usa (basi militari nella cosiddetta Unione europea), tuttavia, non sono mezzi di affrancamento della sovranità tedesca, ma piuttosto segni di tutela, quindi di dipendenza. Tutti i programmi di natura politica e militare (presenza all'ONU, aderenza alla Nato, politica di intervento fuori area, partecipazione diretta e indiretta a imprese cosiddette pacifiche, collaborazione militare con la Francia) sono aspetti di condizionamento e nello stesso tempo segnali della necessità che la Germania assuma nel futuro un deciso ruolo politico nel mondo e particolarmente in Europa. L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea è stato un segnale di “via libera” da un vecchio legame, che lega la Germania non solo alla GB, ma indirettamente agli Usa. Una maggiore spinta americana perché il Paese, tramite la Nato, assuma responsabilità dirette nell’Europa orientale potrebbe significare una decisiva svolta antirussa. La Germania, a struttura economica fortemente omogenea, è capace di affrontare le esigenze della globalizzazione in ogni direzione, dagli Usa alla Cina. Il secolo scorso ha "messo in libertà" a Est vecchie e deboli nazionalità, che si sono poi subordinate alle economie più forti, da cui ricevono i mezzi di sopravvivenza (sussistenza e armamenti). Le assi su cui poggia l'Europa sono da sempre instabili: quello nord-sud, ai cui estremi si situano il vecchio capitalismo inglese e quello italiano, con al centro la Germania, spinge fuori area il primo (verso gli Usa) e fa scivolare al centro il secondo (verso la Germania), soprattutto il Nord più avanzato economicamente; quello ovest-est, anch'esso centrato sulla Germania, non ha mai retto nei periodi di forti crisi economico-sociali, troppo vicina la Francia e troppo decentrata la Russia.
La forza del capitalismo tedesco non può non costituire il vero problema dell'Europa. L’instabilità europea cresce con lo sviluppo economico-politico della Germania: più la dimensione della sua potenza emerge più si fa strada la necessità del suo ridimensionamento. La partecipazione della Germania alla guerra dei Balcani l’ha spinta a divenire, in modo assoluto, il vero partner economico e finanziario degli Stati dell’area balcanica. Il marco è divenuto moneta corrente nell’area: e questo ha preoccupato non poco gli Stati dell’Unione Europea. La crisi russa ha trascinato dietro di sé la Serbia e il Kossovo in guerra devastando la penisola balcanica. L’accettazione nella Nato della Polonia, dell’Ungheria e dei Paesi baltici ha ridisegnato l’intera area anche dal punto di vista delle alleanze militari. La guerra ha avuto come finalità anche la conquista dei corridoi energetici (gas naturale proveniente dal Caucaso) che attraversano l’intera area balcanica. Il vecchio progetto ferroviario che, alla fine del XIX secolo, portava da Berlino a Damasco e a Bagdad si è riaffacciato nel primo e nel secondo conflitto mondiale, anche negli obiettivi recenti, spingendo la Germania a intervenire.
La centralità tedesca traballa di fronte alla dimensione gigantesca e imprevedibile che ha preso l’imperialismo finanziario mondiale a cui tutti i paesi sono connessi. All’inizio di questo nuovo secolo, su cui si è abbattuta la più grande crisi dopo quella del 1929, la rete globale del sistema finanziario è divenuta sempre più vischiosa e potente. La globalizzazione ha preso il carattere di un’immensa forza centripeta, nello stesso tempo in cui emerge come un’immensa forza centrifuga. Le transazioni finanziarie raggiungono valori in migliaia di miliardi di dollari che rappresentano l’intero prodotto lordo di un anno d’un paese come l’Italia e una piccolissima percentuale di esse è capace di creare effetti catastrofici anche nei paesi relativamente forti.
Da questa dinamica di “guerra finanziaria” non si sfugge. Il centro-massa del Capitale non si trova in una singola nazione o in un continente, anche se nazioni e continenti possiedono masse gravitazionali enormi. La Germania è in Europa questo centro gravitazionale (masse immense di merci e di capitali). La scienza della dinamica delle masse individua, in economia (e in fisica) il baricentro in prossimità del nucleo, anche se gli “effetti dinamici” possono manifestarsi lontani dal baricentro stesso, magari nell’anello più debole della catena gravitazionale. L’illusione diffusa è che l’economia abbia in sé virtù intrinseche di pace e benessere: lascia intendere che, sotto il controllo della democrazia, gli “spiriti selvaggi del capitale” possano essere domati e incanalati nella direzione che si vuole; che la tecnologia avrebbe in se stessa gli anticorpi per sconfiggere gli spiriti selvaggi del liberismo; che alle sfide economiche si possa con altrettante sfide economiche, ai tassi di incremento con superiori tassi, alla produttività con una superiore produttività. E infine appare logico e sensato che le armi, nate sul terreno economico, siano bandite dai conflitti (?!). Ma la “buona volontà” non distruggerà gli “spiriti selvaggi del capitale”, l’anarchia dei mercati e il vulcano della produzione, la legge dello sviluppo diseguale, l’immiserimento crescente che accompagna il carro funebre: la grande economia, gli alti ritmi di sviluppo, viaggiano in carro armato, devastano e distruggono i territori attraversati dalle merci e dal denaro. Cresceranno quindi le sfide militari. Le armate del capitale sono le merci supportate dai carri armati. I paesi vincitori e vinti delle due guerre passate vantavano alti indici di produzione e rapporti di produzione avanzati: si trattava dei nuovi cavalieri dell’Apocalisse (Usa, Urss, Germania, Giappone), con potenzialità di sviluppo gigantesche, armati fino ai denti e con una struttura logistica e di consenso storico enorme.
L'integrazione economica, l’unione monetaria e l’unità politica
Non esiste un processo diretto che porti dall'integrazione economica all'unità politica dell’Europa. L'unità politica implicherebbe la formazione, in processo o in atto, di uno “Stato unitario”: richiederebbe dunque uno Stato politico, retto da una “borghesia sovranazionale”, che abbia coscienza del suo ruolo storico, soprattutto contro il proletariato, il suo reale avversario, chiuso nelle gabbie dei singoli Stati. Oggi, quello che è chiamato “progetto unitario europeo” si scrive giorno per giorno sulla carta.
L'unità politica degli Stati europei sarebbe ovviamente più dell'integrazione economica (o di un’area di libero scambio) e più dell’unità monetaria: sarebbe espressione della forza del “grande capitale sovranazionale”, che ha sottomesso la gran parte dei capitali nazionali (agrari, industriali, commerciali e soprattutto finanziari). Il tutto, però, non è concepibile come uno "sviluppo naturale". Il passaggio dall’integrazione economica all’unità politica è qualitativo non quantitativo. Il che significa che, se esiste una vera e reale unità, ciò è perché preesiste a essa un’unità politica. Un’unità economica tra unità nazionali alla lunga è destinata a crollare, perché può sussistere solo sotto la forma dell'assorbimento coatto di uno Stato nell’altro o della loro “spontanea” subordinazione, o infine per effetto di una guerra che abbia sancito con la violenza la vittoria di una di esse. Deve preesistere un'unità politica: infatti, lo Stato nazionale è il rappresentante politico, la sovrastruttura di forza dell'intera classe borghese (non la sommatoria dei vari settori economici della stessa classe). L'unità politica, sempre in continuo cambiamento, viene allo Stato borghese dal fatto che la borghesia, come classe, rappresenta il capitale nella sua realtà, storicamente ed economicamente data, necessaria per la sua accumulazione allargata. A scala europea, le tante borghesie nazionali, formatesi storicamente, sono in lotta fra loro sul piano economico come su quello politico.
La creazione di una Banca centrale europea può certamente migliorare l’integrazione economica, in quanto rappresenta il sistema delle banche centrali nazionali. Agendo su un campo più ampio di quello delle singole banche centrali nazionali, la Banca centrale europea possiede funzioni e responsabilità maggiori, che garantiscono l’indipendenza delle singole banche. La sua prerogativa è quella di gestire, non la “politica economica”, ma la “politica monetaria”, che rappresenta insieme sia l’economia reale che quella finanziaria: ovvero, è la prerogativa di prendere le decisioni che influenzano sia i tassi di cambio sia i tassi di interesse, in nome della stabilità dei prezzi. La cooperazione, cosiddetta sovranazionale e nazionale, vive il rischio del conflitto, pur avendo fissato regole comuni su alcuni parametri fondamentali in un’area particolarmente soggetta alle contraddizioni profonde dell’economia capitalistica. La produzione nazionale innanzitutto – le importazioni ed esportazioni di merci e di capitali, la gestione del credito delle banche centrali nazionali, le politiche fiscali, quelle di bilancio, le politiche industriali – non può uscire dal quadro nazionale a cui la borghesia è assoggettata.
Il denaro non regola la grandezza del valore (questa è l’illusione della borghesia e della piccola borghesia): il denaro è misura del valore, è mezzo di scambio, è mezzo di pagamento ed è forza attiva solo quando è Capitale, ovvero quando permette la creazione di plusvalore. Quando è una grandezza costante (grande quanto si voglia) la sua variazione è nulla. Il denaro, quando è reddito, è solo un prodotto sterile del capitale. Quando è capitale esso determina il modulo, la direzione e la velocità e dell’accumulazione; quando è denaro non determina affatto la dinamica dei processi di circolazione, sviluppo dei mercati e crescita dell’economia capitalistica. Solo il capitale variabile, applicato ai mezzi di produzione, produce plusvalore. Fin dal suo apparire, il denaro con la sua grandezza è comunque un vettore costante di instabilità, mentre il Capitale è la vera causa di quella instabilità. Il Capitale accresce la concorrenza interna tra i produttori di merci: tutti i settori produttivi rendono manifesto ciò che loro è intrinseco, il valore medio sociale (il tempo di lavoro socialmente necessario alla produzione delle merci) sempre variabile nel tempo. La produttività non diminuisce lo squilibrio fra settore e settore produttivo: al contrario, spinge i settori l’uno contro l'altro. Il modo in cui si accresce la fusione, la centralizzazione, la concentrazione, la produttività, altera il processo produttivo, crea la concorrenza, la guerra fra industria e agricoltura e quella fra piccoli, medi e grandi comparti industriali e agricoli.
L'unione monetaria non porta, con la moneta unica, alla stabilità del “sistema Europa”. Essa segnala anzitutto che nell'economia è presente un'instabilità reale, la quale ha necessità di un Ordine, di un Diktat sui cambi, sui saggi di interesse, sui prezzi. La regolamentazione dei flussi di capitale-denaro è richiesta dalla produzione reale, dalla sovrapproduzione di capitali e di merci, dalla caduta del saggio medio di profitto. Le contraddizioni nella produzione e nella circolazione, la valorizzazione-svalorizzazione e la velocità sono segnalate dai flussi di denaro allo stesso modo in cui la febbre segna la presenza di una malattia.
L'unione monetaria significa anche la lenta e irreversibile “perdita tendenziale di sovranità” dei singoli Stati nazionali, a causa della socializzazione crescente dei tanti settori produttivi nazionali e delle gigantesche unità produttive non nazionali – socializzazione che è realizzabile in maniera concreta solo con il socialismo (e che tuttavia non può nascere senza quel periodo di transizione che ha nome “dittatura proletaria”, destinato a rivoluzionare in forma non più mercantile il modo di produzione e di distribuzione sociale). L’unione monetaria è certamente anche un atto politico, che segnala la maturazione di profondi squilibri economici e politici (svalorizzazione di intere aziende-nazioni, contrasti economici e politici sempre più ampi all’interno della classe dominante, delle mezze classi e del proletariato), dovuti alla dinamica del capitale cui porre rimedio.
Nel medio periodo, lo sviluppo economico capitalistico sta producendo e produrrà in Europa effetti catastrofici. La dinamica del profitto richiede concentrazioni e centralizzazioni sempre più spinte e più ampie per vincere un grado di concorrenzialità accresciuta, che ha come base non singole nazioni, ma aggregati di nazioni, accordi continentali, accordi di settori monopolistici di varia grandezza, accordi che si dimostreranno fondati sulla sabbia, sulla carta, pronti ad esplodere e saltare con le prossime crisi economiche.
Essendo il denaro la misura del valore, una moneta valida per tutti deve basarsi su criteri unitari di produzione del valore e di plusvalore universali (teoria del valore). Ora la moneta nazionale è in ultima analisi, come spiega Marx, il riflesso dello sfruttamento interno della forza-lavoro e questo crea saggi di plusvalore differenti, così come saggi di profitto differenti. Il capitalismo funziona se internamente esistono differenti saggi di sfruttamento, se esistono differenziali di profitto, sia nazionali che internazionali – differenze che, tuttavia, devono inevitabilmente livellarsi in un saggio medio di profitto che tende a zero. Se ciò accade, anzi nell’atto stesso del suo appiattirsi, l’economia capitalistica entra in crisi. Eliminare le differenze di saggi di profitto nazionali o internazionali significa, tuttavia, eliminare la stessa dinamica del capitale, i flussi e riflussi reali del capitale. Non è possibile la formazione di un’area di uniformità della produzione capitalistica: le linee di forza del campo economico capitalistico non hanno mai regolarità-linearità-simmetria; pretendere di eliminare la concorrenza in un gruppo o coalizione fra Stati, come quella europea, è come pretendere di averla eliminata fra industrie nazionali. La vitalità del capitale è fondata sulla nascita e sullo sviluppo di unità produttive sempre più grandi, esse stesse determinate dal precedente sviluppo generale dell’economia. Queste unità possiedono un’energia potenziale, data dal rapporto organico tra capitale fisso e capitale variabile. La dinamica energetica fa sì che queste unità tendano a diminuire non la loro crescita, ma il loro tasso di crescita, cioè la velocità di crescita, a mano a mano che aumenta in modo assoluto l’accumulazione, sicché la sua vecchiaia e morte sono assicurate e pertanto molte di esse sono trascinate alla fusione, alla concentrazione, altrimenti la loro morte economica è certa.
Noi comunisti neghiamo la possibilità della formazione in regime capitalistico di un supercapitalismo (nazionale e/o internazionale), di un unico monopolio nazionale o internazionale che superi l’anarchia del mercato e la sua palude. La tendenza alla formazione di poli giganteschi esiste ed è inevitabile, ma è escluso che si possa avere sul piano planetario uno e un solo polo capitalistico, così come è impossibile che si abbia un unico polo magnetico. Così come le grandi unità capitalistiche nazionali non annullano del tutto gli altri settori nazionali, benché “tenda” dal punto di vista contabile a formarsi un unico capitale nazionale, allo stesso modo è esclusa la formazione di un’unica azienda capitalistica globale. La tendenza reale mondiale verso questa monade segnala proprio la morte del capitale.
L'Unione monetaria europea “non è solo un fattore tecnico”
L'Unione monetaria non è semplicemente un fattore tecnico e non riguarda unicamente aspetti di sola “integrazione economica”; nell’Unione monetaria sono coinvolte molte questioni politiche e istituti politici, creati appositamente, ma ciò non basta a sostenere il passaggio verso un’unità politica, per di più sovranazionale.
All'interno di uno Stato nazionale, la moneta segnala la presenza di una classe dominante, la borghesia, che ha imposto il proprio dominio a tutte le altre classi, alla piccola e media borghesia, alle classi medie e al proletariato, presenti nel territorio nazionale. Nel caso europeo, l'affermarsi in regime permanente, e non in un periodo transitorio, della “moneta unica” mostrerebbe che i tanti settori deboli delle borghesie nazionali (piccole e medie borghesie europee), battute sul piano economico e politico, hanno di fatto accettato un ruolo subordinato nei confronti di una borghesia “a dominante non nazionale”, che abbia costretto quelle nazionali a sottomettersi.
Il dominio di una borghesia “a dominante non nazionale” sulle altre (nazionali), tuttavia, non si manifesterebbe sul piano economico senza manifestarsi anche sul piano politico e soprattutto militare. L’unione monetaria, riflesso della forza politico- economica dominante, dovrebbe disporre di una direzione politico-economica: cioè di uno Stato unitario, di una rigida centralizzazione bancaria ed economica nel senso più ampio del termine, e di capacità sanzionatorie (per definizione di Stato). Ma proprio qui sta la contraddizione: solo attraverso lacrime e sangue questo processo può compiersi e non può farlo una borghesia nazionale, o chi per essa. Può farlo solo una forza che sia svincolata dalla “nazione”: il proletariato. L'imposizione del dollaro sulle economie vinte nella seconda guerra mondiale ne è un esempio. Pur in presenza di monete nazionali, il dollaro è riuscito a determinare tutta la storia europea (e la determina tuttora), anche dal momento in cui le borghesie hanno cominciato a marciare senza la precedente tutela economica (vedi inconvertibilità del dollaro in oro all’inizio degli anni ‘70) e in presenza di un indebolimento della stessa economia americana e del progressivo assottigliarsi della loro distanza economica. Il dollaro ha potuto dominare senza per questo annullare le monete nazionali europee: ha circolato in tale quantità da imporre un regime quasi forzoso della sua moneta conservata nelle banche nazionali accanto all’oro, e così ha sottomesso quelle monete alla forza del dollaro: cioè, all’economia americana. L’area latino-americana fu ugualmente sottomessa alla forza del dollaro senza che fossero annullate le varie monete nazionali.
La Federal Reserve nazionale (la Banca centrale americana), il Fondo monetario internazionale, ovvero poi sostanzialmente il capitalismo americano, hanno dato al dollaro la funzione che un tempo era dell’oro (moneta mondiale). La smaterializzazione dell’equivalente generale a favore del dollaro è avvenuta nel 1944 a Bretton Woods a ridosso della fine del II conflitto bellico. Il sistema aureo era crollato perché non avrebbe potuto più sostenere le contraddizioni dello sviluppo economico del dopoguerra, la sua fine era matura e la forza di una decisione d’imperio ha dato solo il colpo finale. A sua volta, non la crisi ha generato il tramonto del dollaro (l’inconvertibilità), ma lo stesso sviluppo capitalistico, essendo il dollaro ormai incapace di porre spontaneamente le premesse di un'altra stagione di cicli di sopravvivenza: la crisi economica del 1974-75 era solo alle porte. La decisione politica del 1970-71 fu il riflesso di un dopoguerra “straordinario”, che lasciava sul terreno contraddizioni preannuncianti catastrofi, alimentato da una lunga e massiccia accumulazione produttiva. Il Gold Standard della seconda metà dell’Ottocento, dal 1873 fino al 1914, aveva operato alla stessa maniera del dollaro, ma non aveva “potuto impedire” che scoppiasse il primo conflitto mondiale e le crisi successive. Un regime monetario può veicolare un processo, ma non può impedire che il sistema entri in crisi. Furono le due guerre, fu la crisi del 1929, a decretare, fra decisioni contraddittorie, la morte di un sistema a parità aurea, a mostrare la fragilità e l’instabilità, per sua intrinseca natura, del sistema capitalistico borghese; furono dunque strumenti di forza e di violenza a decretare anche la fine della sterlina e del marco, che si era lanciato insieme al dollaro nell’impresa economico-monetaria. Ma la transizione fu decisa da un atto d’imperio politico, non da un accordo: che i diversi burattini nazionali fossero presenti appesi ai loro fili a Bretton Woods è solo un dato scenografico.
Quali furono gli obiettivi che si era proposto il sistema monetario internazionale a Bretton Woods? Ma proprio ciò che si propone oggi la Banca centrale europea: ovvero, la stabilità in un’ottica continentale e con il concorso delle nazioni capitalistiche dominanti. Con quali mezzi? Al solito: il controllo sui cambi, l’impedimento delle svalutazioni competitive, il congelamento dei crediti, il sistema delle compensazioni bilaterali, i fondi di equalizzazione, il commercio internazionale, i cambi multipli. Il suo “crollo formale” non avvenne a causa di eventi bellici, in cui la potenza americana fosse stata sconfitta, ma di dinamiche economiche intrinseche sempre più critiche, che dall’inizio degli anni ’60 avevano cominciavano a far sentire i propri effetti (la prima crisi americana è del 1958). Nel caso dell'Europa, il passaggio dalla moneta nazionale a quella sovranazionale certamente partirebbe da una coordinazione maggiore del passato tra le economie (d'altronde sempre più integrate): ma ciò non basterebbe, se non venissero imposte condizioni di natura politica (di potenza) da parte del capitalismo (e quindi delle borghesie più forti). Ma la borghesia, quella dominante, non può svincolarsi dalla sua nazione e dalla “sua” economia e non può non imporre il suo diktat bellico. La Costituzione americana, pur essendo federale, è basata su una forza politica unitaria, economica e militare: non può costituire un esempio di mitologica “unione volontaria” (basta esaminare la storia degli Usa e la sua brutale “guerra di annessione”, chiamata “Guerra di secessione”). I margini di operatività non sono dati tecnici, ma politici: non sono sufficienti i semplici parametri di Maastricht (debito pubblico/Pil=60%, deficit/pil=3%) a sbarrare le porte all’anarchia capitalistica. Non bastano né il riconoscimento ideale, né la forma giuridica, nessun sistema politico costituente e costituzionale. Occorrerebbero “sistemi sanzionatori brutali” contro le borghesie recalcitranti per ottenere quell’unità politica, e questo determinerebbe sempre di più uno scollamento degli equilibri precari tra le forze borghesi, lotte interne sempre più acute, fino a divenire “guerre civili” o guerre imperialiste. Lo stesso proletariato, nelle condizioni contingenti di “classe per il capitale”, non potrebbe allora non essere spinto, in presenza del suo partito comunista internazionale, a battersi non solo per difesa delle proprie condizioni di vita e di lavoro, ma soprattutto per la distruzione del modo di produzione capitalistico, attraverso la dittatura di classe.
Partito comunista internazionale
(il programma comunista)