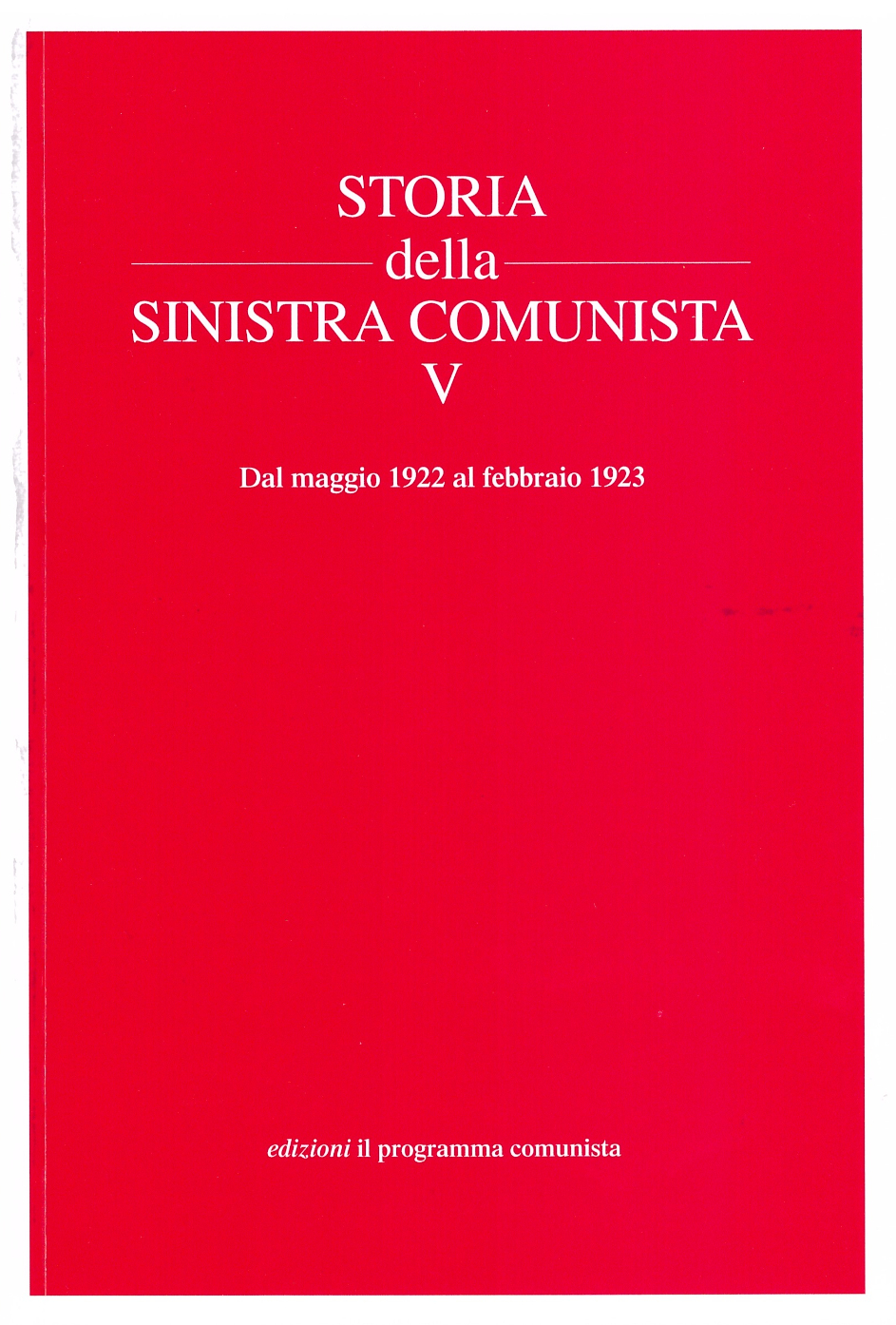I miti economici, come i miti in generale, sono duri a morire. Ma lo scorrere del tempo, lo svolgersi della storia del Capitale e la stessa dinamica del processo di produzione capitalistica li sgretolano fino a farli crollare.
Crollato miseramente il mito del “Socialismo in un solo paese”, generato dalla controrivoluzione politica staliniana e dal processo di industrializzazione capitalista dell’URSS, un altro mito borghese, quello del welfare (la società del benessere, della prosperità e del progresso continui), si sgretola sotto l’incalzare della stessa inesorabile legge della caduta tendenziale del saggio medio di profitto. Si estende infatti, in vastità e in profondità, nella società del welfare, la miseria dei salariati in rapporto alla ricchezza che questa stessa classe produce per il Capitale. Si allarga il divario tra borghesia e proletariato: a un polo si accumula la ricchezza, al polo opposto la miseria.
Da quando, a metà ‘800, è sorta la dottrina del proletariato rivoluzionario, un esercito di scribi (ideologi) e preti della borghesia (così Lenin definiva gli “economisti”) si è messo al lavoro per tentare di confutare la dottrina comunista e di dimostrare l’assurdità della legge della miseria crescente, portando come prove l’aumento del reddito degli operai (il prezzo pagato per l’uso della forza lavoro: prezzo che, come il prezzo di tutte le merci, storicamente diminuisce) e dunque la possibilità per la classe operaia di disporre di merci divenute tipiche delle classi medie: automobili, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, telefonini, computer, vacanze, ecc. ecc.
A confutazione di queste “prove”, riportiamo alcuni dati tratti da pubblicazioni borghesi, che mostrano in maniera limpida il peggioramento delle condizioni di vita e di salario per un lungo periodo storico, dai primi anni ’70 del XX secolo fino ad oggi, periodo di pieno sviluppo dello Stato sociale e della società del benessere. E passeremo poi a esporre ancora una volta quella che nella dottrina marxista è la “legge della miseria crescente”.
Leggiamo dunque su Il Sole-24Ore dell’11/3/2007 un articolo dal titolo “Prove di equilibrio globalizzato”, e vi troviamo scritto:
“Negli USA due tendenze importanti hanno implicazioni per il ruolo dell’America nel mondo […]. La prima è il deterioramento nella distribuzione del reddito […] la sperequazione è cresciuta in modo pressoché continuo dal 1973 a oggi. Negli ultimi 15 anni la posizione relativa dei lavoratori non qualificati si è stabilizzata (a un livello molto più basso di un tempo), ma il reddito delle fasce medie continua a diminuire rispetto alle fasce più ricche”.
In un altro articolo, dal titolo “La povertà globalizzata” (La Repubblica del 22/3/2007), leggiamo:
“anche nella società della piena occupazione degli inizi del XXI secolo in Europa si accende il dibattito sulla povertà senza vie d’uscita. Tutti […] danno per scontato che la povertà sempre più diffusa e sempre più dura sia un problema nazionale […]. Ma […] per capire il problema della povertà del XXI secolo e per cercare risposte politiche abbiamo invece bisogno di uno sguardo cosmopolita, che superi la rigidità del ‘nazionalismo metodologico’ […], l’economia dell’insicurezza rivoluziona le condizioni di lavoro e di vita in tutte le società occidentali evolute. Detto in malo modo, viviamo una brasilianizzazione delle società del benessere: le forme variopinte e fragili di occupazione […] sostituiscono sempre più il lavoro sicuro […] lo si può anche celebrare come ‘flessibilità’, ma tutto ciò significa: ‘Renditi più facilmente licenziabile’ […]. Il nesso stretto tra povertà e disperazione […] è di tipo ‘nuovo’ perché nella cultura capitalista […] a fronte dei poderosi progressi nella produttività questi soggetti scartati – è amaro dirlo – non vengono più ‘usati’ […] lo shock che colpisce […] è legato alla consapevolezza […] che questa povertà è la conseguenza di tutti i tentativi per vincerla […] La disoccupazione di massa e la povertà non sono segno della sconfitta, ma della vittoria delle società del lavoro moderne, poiché il lavoro diventa sempre più produttivo” 1.
Ma passiamo all’Italia, e riportiamo, da un volume del sociologo Luciano Gallino (Italia in frantumi, Laterza), una lunga citazione:
“I metodi utilizzati da centri di ricerca universitari, uffici studi sindacali e istituzioni quali la Banca d’Italia e il Cnel per valutare l’incidenza dei redditi da lavoro dipendente sul Pil sono assai differenti, e producono cifre diverse. Peraltro essi convergono nel valutare intorno al 6-7 per cento la diminuzione di tale incidenza a partire dagli anni ’90. Se si va più indietro nel tempo il dato peggiora […]; secondo il rapporto Cnel 2002 sulla distribuzione del reddito in Europa, la quota dei redditi da lavoro dipendente sul Pil è scesa in Italia, dal 1972 al 2000, di 10 punti esatti, scendendo dal 50,6 al 40,6 per cento” (p.35). Una ricerca pubblicata a metà 2003 dall’Ires-Cgil stima inoltre che la quota del monte retribuzioni lorde sul Pil abbia perso negli ultimi due decenni oltre sei punti percentuali scendendo dal 36,1 al 30 per cento (p.125). Continua ancora il Gallino: “L’Italia condivide con il Regno Unito e gli USA il primato di essere, tra i grandi paesi sviluppati, uno dei più diseguali al mondo, in termini sia di reddito sia di ricchezza. Nel 2004, il 10 per cento delle famiglie italiane con i redditi più elevati ha percepito il 26,7 per cento dei redditi prodotti, al netto delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali e assistenziali; al 10 per cento delle famiglie con il reddito più basso è toccato solamente il 2,6 per cento ossia oltre dieci volte meno. La ricchezza netta totale […] appare ancora più concentrata verso l’alto. Il 10 per cento delle famiglie più ricche risulta infatti possedere il 43 per cento dell’intera ricchezza netta delle famiglie italiane; meno del 1 per cento di questa risulta posseduto del 10 per cento più povero (fonte Banca d’Italia). Si noti che sia il reddito sia, in maggior misura, la ricchezza degli strati superiori risultano in genere sottostimati […]; le disuguaglianze di reddito si sono fortemente approfondite in Italia non da ieri, bensì tra la metà degli anni ’80 e la metà degli anni ‘90. In seguito sono rimaste relativamente stabili. Anche le disuguaglianze di ricchezza sono esplose in tale periodo, ma anziché stabilizzarsi hanno continuato a inasprirsi sino a oggi, con una concentrazione crescente di essa non solo nelle mani del 10 per cento delle famigli più ricche, ma addirittura del 5 per cento, che già nel 2000 disponeva di oltre il 36 per cento della ricchezza familiare netta […]. Tra il 1995 e il 2005 le retribuzioni reali dei dipendenti del settore manifatturiero, calcolate cioè al netto dell’inflazione, sono aumentate di oltre il 25 per cento nel Regno Unito, di oltre il 14 in Francia, e di oltre il 9 in Germania. In Italia, l’aumento è stato di un misero 1,15 per cento (dati Ocse). Ciò significa che un operaio che guadagnava l’equivalente di 1.000 euro mensili nel 1995 ne guadagna oggi 1.250 se è inglese, 1.140 se è francese, 1.090 se è tedesco. Se è italiano, si deve accontentare di 15 euro di aumento (cioè guadagna 1.015 euro). […] Oltre che dall’andamento dei redditi e della ricchezza rilevate dalle indagini dirette sui bilanci familiari, l’ampliamento del fossato tra chi ha e chi non ha trova perentorio riscontro in un dato macroeconomico. Tra metà degli anni ’70 e i primi anni 2000, la quota di reddito da lavoro dipendente in rapporto al valore aggiunto è scesa di ben 10 punti dal 48 al 38 per cento, mentre la quota dei profitti nel settore privato saliva di sei-sette punti già a metà degli anni ’90 e si manteneva stabile dopo di allora (dati Ocse e Fmi)” (p.193-195).
Queste lunghe citazioni ci servono sia per rispondere ai critici del comunismo, sia per mostrare, con gli stessi dati forniti dalla borghesia, che la tanto decantata (da parte delle “sinistre” borghese e piccolo-borghese) società del welfare e dello Stato sociale non solo non ha diminuito le disuguaglianze sociali (“tra chi ha e chi non ha”, nel loro linguaggio mistificatorio, purgato da qualsiasi riferimento alla classi sociali; in termini scientifici: tra borghesia e proletariato), ma li ha accentuati e inaspriti. Non solo non ha ridistribuito la ricchezza sociale prodotta, come i suoi apologeti sostengono o promettono, ma ha concentrato la ricchezza in strati sempre più piccoli della stessa borghesia. Non solo non è diminuita la miseria e la disoccupazione, ma in virtù dello stesso successo del welfare queste sono aumentate. Tutti dati, questi, che confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, la critica comunista alla società del Capitale.
Dopo tanti “successi” della società del welfare, il rallentamento dei tassi di crescita dell’economia (il famigerato Pil) determinato dalla caduta tendenziale del saggio medio del profitto impone allo Stato del welfare di riformarsi, cioè di ridurre o di ritirarsi da alcuni impegni sociali prima considerati sacri, inviolabili e intangibili (e per il cretinismo di “sinistra” acquisiti per sempre). Quindi, attraverso le nuove riforme non si vuole smantellare lo Stato-spendaccione, lo Stato-sciupone, ma lo Stato costretto ad accollarsi le spese crescenti di una politica di salvaguardia dell’ordine costituito, intesa a favorire la “propensione al consumo” di coloro stessi che, per l’economia classica di Smith e Ricardo, erano dei “senza riserve”, di null’altro in possesso che della propria forza lavoro, costretti a venderla per sopravvivere, e che per l’economia volgare dovevano diventare dei “consumatori”. Ciò che si deplora e si vuole “snellire” è lo Stato scialacquatore, non in generale, ma nello specifico campo dell’assistenza e previdenza sociale, i cui costi erano un tempo benedetti perché servivano a mantenere una rete di “garanzie” ed “automatismi” e ad attenuare e smorzare i più stridenti contrasti di classe. Nuove riforme, queste, che preoccupano molto tutto quel mondo variopinto della “sinistra” politica, sociale e sindacale, per le ripercussioni che possono avere sulla coesione sociale e sulla pace sociale, preludio possibile al riaccendersi della lotta di classe – che invece i comunisti degni di questo nome si augurano e auspicano.
Tra i tanti critici della marxista legge della miseria crescente, prendiamo come esempio un esponente dell’intellighenzia borghese, progressista e socialisteggiante: quel Sylos Labini, morto di recente, che passò tutta la vita (poveretto!) a cercare di confutare le “tesi” di Marx. Il metodo di quest’intellettuale era tipico della sua categoria: inventarsi teorie, attribuirle a Marx, e poi confutare questi parti del suo stesso cervello e sostenere di aver così... confutato il marxismo. In un libro dal titolo Torniamo ai classici, egli scriveva:
“L’intervento dello Stato è fortemente cresciuto in tutti i paesi, specialmente in quelli avanzati. […] Nei paesi europei più avanzati la quota delle spese pubbliche si aggira sul 40-45% e oltre; si tratta in gran parte di spese sociali, che […] hanno contribuito a sradicare la miseria, […] ciò mostra che è possibile abolire la miseria in un paese capitalistico, in contrasto con le idee dei marxisti…” (p.84).
In un altro articolo, scritto anni prima sul giornalaccio L’Unità (28-12-2002), foglio storico della controrivoluzione staliniana e della falsificazione del comunismo in Italia, sempre lo stesso Sylos Labini elencava una serie di critiche rivolte a Marx. Ne riportiamo solamente due, perché fanno al caso nostro. Scriveva dunque il “nostro” intellettuale:
“Le mie critiche a Marx riguardano: la tesi che i proletari – gli operai salariati – sarebbero diventati l’immensa maggioranza della popolazione e la miseria crescente. Prima critica: la tesi che il proletariato sarebbe diventato l’immensa maggioranza della popolazione si fondava su una rozza estrapolazione, che risultò poi gravemente errata. La tesi era rilevante perché, se vera, avrebbe sdrammatizzato la questione della dittatura del proletariato, la quale avrebbe colpito una sparuta minoranza di sfruttatori, non meritevoli né di considerazione né di compassione. Seconda critica: alla tesi della miseria crescente del proletariato Marx teneva molto e per sostenerla non ha esitato a forzare dati e citazioni – la mia accusa è grave, ma nessuno ha mai cercato di confutarla. Il fatto è che se Marx avesse accettato la tesi, sostenuta dal suo contemporaneo John Stuart Mill, del lento miglioramento economico e culturale, avrebbe aperto la porta al riformismo e chiuso quello della rivoluzione”. No comment!
Del “nostro” intellettuale ci eravamo già occupati anni fa, quando con la sicumera del dotto ignorante pronosticava la “scomparsa della classe operaia” (cfr. Il programma comunista, nn.4-5-6/1986). Scrivemmo allora, a confutazione delle tesi del prete borghese e dei suoi emuli contemporanei e futuri:
“Non si può pretendere di ‘seppellire’ il marxismo ignorando i termini nei quali esso pone, fra gli altri, il problema delle classi, nell’individuare e contrapporre le quali Marx non parte dal reddito rispettivo di capitalisti e proletari, cioè dalla distribuzione delle risorse esistenti fra i gruppi più o meno definiti della popolazione, ma dalla loro collocazione rispetto ai rapporti di produzione, di cui la disparità di reddito è, caso mai, un semplice e neppure decisivo riflesso. Capitalisti non sono, per il marxismo, i ricchi in quanto tali, o i percettori di alti redditi, ma i detentori dei mezzi di produzione che dispongono, nello stesso tempo, dell’intero prodotto del lavoro altrui ad esso applicato; proletari non sono i poveri in senso lato, o i percettori di bassi redditi, ma coloro i quali non detengono i mezzi di produzione né dispongono dei prodotti del lavoro sociale […] non possiedono altro che la propria forza lavoro, e si trovano quindi in totale dipendenza del capitale e delle sue leggi di sviluppo, delle fasi alterne del suo ciclo. Questa antitesi (fra capitale e lavoro salariato) è tanto più totale quanto più il Capitale si accumula, anche se e quando, in dati periodi o in date contingenze, la retribuzione del lavoro (il salario) cresce, come Marx non ha mai escluso che cresca”.
Il “nostro” intellettuale, poi, nella critica alla “tesi” della miseria crescente, accusa Marx di aver forzato i dati, perché se avesse accettato la tesi sostenuta da Mill (del lento miglioramento economico) avrebbe aperto la porta al riformismo e chiuso quella della rivoluzione. Come, anni addietro, abbiamo confutato la tesi della “scomparsa della classe operaia”, dimostrando che il materialismo dialettico individua le classi sociali in base al rapporto che intrattengono con i mezzi di produzione e con il prodotto del loro lavoro, e sulla base degli stessi dati portati dal “nostro” abbiamo dimostrato l’estendersi della classe proletaria e la proletarizzazione delle classi medie, così oggi, con gli stessi dati che ci forniscono le fonti borghesi e utilizzando la stessa categoria economica usata dai borghesi, quella del reddito, dimostriamo che lo Stato sociale, il welfare, massimo punto d’arrivo di tutti i riformisti, invece di eliminare la miseria (come doveva fare) l’ha accentuata ed estesa, in virtù non del suo fallimento, ma del suo successo. Ma se anche la miseria dopo più di sessanta anni di Stato sociale non fosse aumentata, bensì diminuita (cioè fosse aumentato il reddito della classe operaia: possibilità che il socialismo scientifico non ha mai negato), la legge formulata da Marx sarebbe rimasta lo stesso inconfutata. La miseria di cui parla Marx, che è impossibile eliminare finché rimane in piedi il capitalismo, è frutto di una legge storica del processo di produzione capitalista e riguarda il fatto che “il salario non cresce proporzionalmente alla produttività del lavoro” e quindi alla massa del prodotto sociale. E’ la produttività crescente del lavoro che fa crescere la miseria relativa della classe dei salariati. E’ nel rapporto tra pluslavoro e lavoro necessario che sta l’arcano della miseria crescente, e la fame incessante di pluslavoro è l’anima che muove il Capitale.
Scrive un altro prete della borghesia:
“Vi sono solo due obiettivi economici intelligenti: un alto livello di produttività e l’aumento della medesima (ossia un’elevata e crescente produzione per ora lavorata) che offra un alto reddito [in termini comunisti, “profitto” – NdR] per ora lavorata” (A. Turner, Just Capital, Laterza, pp.45-46).
E’ in questo obiettivo di far crescere sempre più la produttività del lavoro (cioè nel diminuire nel capitale variabile la parte che va alla riproduzione della forza lavoro, il salario, e nell’aumentare la parte che va al pluslavoro, il profitto) che si cela la crescente miseria relativa dei salariati.
Scrive infatti Marx: “Qual è ora la legge generale che determina l’aumento o la diminuzione del salario e del profitto nel loro rapporto reciproco? Essi stanno in rapporto inverso. La quota del capitale, il profitto, sale nello stesso rapporto in cui cade la quota del lavoro, il salario viceversa. Il profitto sale nella misura in cui il salario cade, esso cade nella misura in cui il salario sale”. E ancora: “Un rapido aumento del capitale è parimenti un rapido aumento del profitto.Il profitto può crescere rapidamente solo se il prezzo del lavoro, il salario relativo, diminuisce con la stessa rapidità. Il salario relativo può diminuire, anche se il salario reale sale insieme al salario nominale, al valore in denaro del lavoro; ma non nello stesso rapporto in cui sale il profitto. Se, per esempio, il salario cresce, in un buon periodo d’affari, del 5 per cento, mentre il profitto aumenta del 30 per cento, il salario relativo, proporzionale, non è aumentato, bensì diminuito” (Lavoro salariato e capitale).
La crisi e il rallentamento della crescita economica, del Pil, che dagli anni ’70 del XX secolo fra alti e bassi si prolungano fino ai giorni nostri, hanno avuto riflessi anche sul Welfare. La borghesia lo considera particolarmente costoso, ed ecco allora farsi avanti i nuovi riformisti, epigoni dei vecchi, che a colpi di “riforme” vogliono alleggerirlo. Se i vecchi riformisti, avendo davanti lo spettro della rivoluzione comunista, prospettavano attraverso la “programmazione economica” l’“estensione della legislazione sociale” e le “riforme di struttura” (cioè la lenta e graduale abolizione della miseria e l’accorciamento delle distanze sociali), i nuovi riformisti, facendosi forti dell’opera di smantellamento di qualsiasi tradizione e organizzazione di classe operata dai loro predecessori, promettono “solo” la riduzione del costo del lavoro (aumento della produttività) e delle pensioni, l’allungamento del periodo di attività lavorativa, la flessibilità nell’impiego della forza lavoro; inoltre, dedicano una particolare attenzione a quelli che con il loro linguaggio mistificatorio chiamano “ceti deboli”. “Ceti deboli”, che “deboli” debbono rimanere: nel senso che, per difendere le loro condizioni di vita, debbono restare sul terreno elettorale, non debbono riconoscersi come proletari (cioè come classe sociale con interessi contrapposti alla borghesia al capitale e al suo Stato), non debbono scendere sul solo terreno che può realmente offrire le uniche possibilità di difesa – quello dell’aperta lotta di classe.
Il nostro augurio (ed è per questo che noi lavoriamo) è che il “ritirarsi dello Stato sociale”, non per la cattiveria di questo o quel settore della borghesia o di qualche partito politico, ma per necessità dettata da leggi materiali, e al contempo l’avanzare della crisi economica, mettano in moto la classe operaia, che i contrasti di classe che la società del welfare era riuscita in parte ad attenuare incanalandoli nell’alveo democratico tornino a esplodere con violenza, permettendo così al partito rivoluzionario di far penetrare nella classe in lotta il programma comunista e, nell’immediato, quelle rivendicazioni (abbassare la produttività del lavoro, diminuire l’orario della giornata lavorativa e quello notturno in particolare, imporre forti aumenti salariali), che sono le uniche che possono permettere, oggi, di “vendere cara la pelle”.
E’ in queste lotte di difesa immediata, vera scuola di guerra sociale, che la classe operaia incomincia a dotarsi di propri organismi di difesa e organizzazione e impara così a prepararsi, quando le condizioni si presenteranno (e si presenteranno!), per l’assalto allo Stato borghese, per distruggere la società il cui fine fondamentale è l’estorsione del pluslavoro-profitto, e per passare infine a una società, il comunismo, dove il lavoro salariato sarà abolito e la società sarà fondata sul lavoro gratuito dei suoi membri.
1 Per “brasilianizzazione” s’intende una società dove il lavoro salariato è privo di protezione giuridica e sociale. Quanto alle forme “variopinte”, “atipiche”, di contratti di lavoro “usa e getta”, riconosciuti giuridicamente, in Italia esse superano le quaranta tipologie!
Partito Comunista Internazionale
(il programma comunista n°04 - 2007)