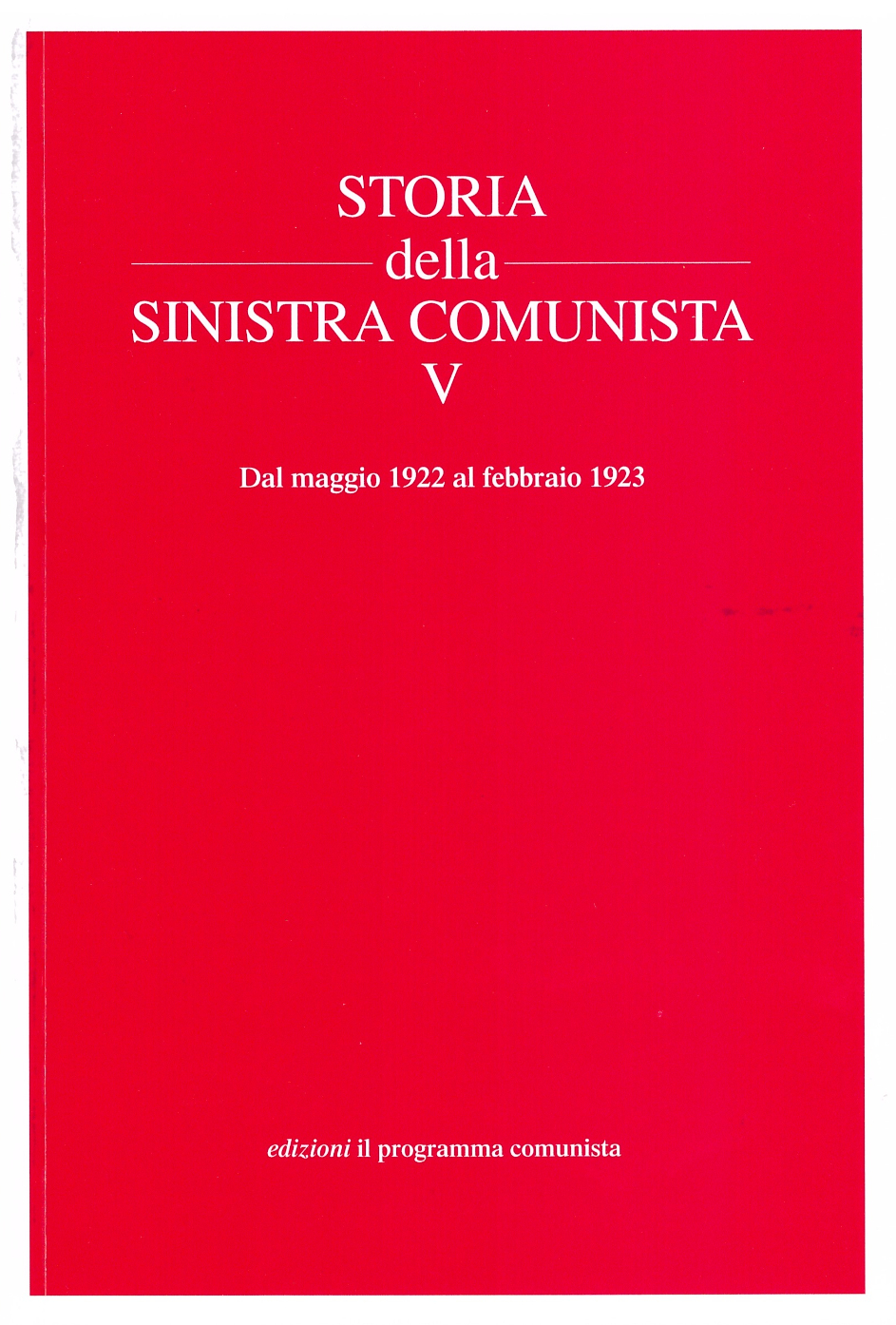In questi ultimi decenni, il periodo di crisi di accumulazione del capitale, seguito alla fase espansiva figlia del secondo massacrante conflitto inter-imperialistico, ha proseguito il suo sincopato alternarsi di pseudo-riprese e ben più concreti tonfi. Si sono così rafforzate le cause profonde degli scontri imperialisti, che si preparano a generare un nuovo conflitto inter-imperialistico, necessario alla sopravvivenza del modo di produzione capitalistico.
Altri nostri lavori hanno seguito e analizzato l’evoluzione di questi scontri, il rafforzamento e l’indebolimento dei protagonisti: ma le dorsali dell’analisi critica di questa marcia verso il conflitto rimangono costanti. Così come necessariamente immutabile rimane l’unica strategia per contrastare o interrompere le guerre degli Stati imperialisti; e necessariamente immutabile rimane la faticosa via dell’organizzazione di un’opposizione proletaria antagonista, rivoluzionaria, diffusa in tutto il mondo, netta e decisa, coagulata intorno alla teoria, ai principi, al programma, alla tattica del partito comunista – e in aperto contrasto con tutte le tendenze politiche riformiste, demagogiche e pseudorivoluzionarie, impersonate da intellettuali di ogni colore, ordine e grado che, come tanti inutili parassiti, succhiano le energie della stragrande maggioranza di noi venditori di forza-lavoro per costruirsi carriere di funzionari della classe dominante. Ciò vuol dire: non un soldo, non un soldato per le guerre del capitale, disfattismo e nessuna concordia con le nazioni borghesi, trasformare la guerra imperialista tra gli Stati borghesi in guerra rivoluzionaria dentro gli Stati borghesi.
***
La definizione che von Klausewitz diede della guerra come “continuazione su un altro piano, e con mezzi diversi, della politica”, esprime e riflette così bene la società borghese che si può tranquillamente capovolgere: la politica è proiezione, su un piano e con mezzi diversi, di quello stato di conflitto permanente, spesso sotterraneo e non necessariamente armato, che è il modo reale d’essere e di divenire del modo di produzione capitalistico. Vale a dire: concorrenza economica fra capitali “giovani ed emergenti”; guerra commerciale fra monopoli per il possesso di mercati e per il predominio in settori vitali della produzione o nell’approvvigionamento di materie prime; guerra diplomatica prima, guerreggiata poi, quando gli antagonismi tra gli Stati (che, nell'epoca non ancora tramontata dell'imperialismo, non sono altro che l'espressione di un “capitalista collettivo nazionale”) raggiungono un livello di tensione estrema e cercano la “soluzione” nello scontro armato organizzato, nella guerra tout court…
Ovviamente, è necessario il concorso di molteplici fattori perché il legame fra gli stadi successivi di un unico processo appaia evidente e crollino miseramente al suolo le teorie costruite e propagandate a sostegno della vantata possibilità che gli equilibri raggiunti in uno di essi si consolidino in una sorta di sia pure irrequieta “pace perpetua”.
È accaduto così che, prima dello scoppio della crisi del Golfo, la guerra sembrasse ormai divenuta “cosa di altri tempi”: illusione alla quale dava un certo credito la fine del bipolarismo Usa-Urss [1]. È tuttavia bastato che un’area di vitale importanza per il capitalismo, sia per gli approvvigionamenti energetici sia per il controllo e la ripartizione della rendita petrolifera e della gigantesca rete di interessi cresciuta sulla sua base, diventasse un nodo di contrasti insolubili sul puro piano economico o diplomatico, perché lo spettro di scontri militari di cui si era appena celebrata la definitiva scomparsa tornasse prepotentemente in scena e un conflitto in origine apparentemente periferico assurgesse a conflitto quasi planetario. Quel conflitto, insieme con quelli seguiti alla dissoluzione della Repubblica jugoslava, indipendentemente dalle dinamiche contingenti, ha aperto la prospettiva sia pure lontana di una terza carneficina mondiale – protagoniste da un lato le vecchie potenze economiche e dall'altro le potenze emerse ed emergenti, con nuove potenziali alleanze e riconoscimento dell'avvenuta rottura degli equilibri nati tra le macerie del “secondo dopoguerra”.
Da quel momento, due illusorie risposte alle prospettive di guerra si sono fatte sentire di nuovo.
Una è quella di un generico quanto inconcludente pacifismo, fatto di petizioni, proteste, manifestazioni (naturalmente pacifiche) coinvolgenti e convoglianti le forze sociali più disparate: un pacifismo incapace di comprendere e quindi di affrontare anche solo in minima parte la sostanza della questione, e pronto infine a capovolgersi nel suo opposto non appena siano o sembrino lesi o anche soltanto minacciati, non tanto e non solo i “valori” (gli interessi!!) della “nazione”, quanto le astrazioni idealiste, più o meno umanitarie, della libertà, della democrazia, dei diritti civili… Convinto più che mai, perfino dopo gli ultimi due macelli inter-imperialistici, dell'idea che la difesa di quelle astrazioni si possa tradurre in una o più guerre giuste, questo pacifismo si può infatti convertire nel più bieco interventismo nel giro di un amen.
L’altra illusoria risposta consiste nell’appellarsi a istituti sedicentemente investiti di ruoli e poteri “sovranazionali”, in grado quindi di imporre il riconoscimento di un ordine internazionale e di risolvere per vie diplomatiche gli eventuali contenziosi. A parte l’assurdo di una visione della storia in generale e di quella del capitalismo in particolare regolata o regolabile in base a diritti, leggi e convenzioni, ci si dimentica così che di organi cosiddetti sovranazionali ne esistono più di uno, ciascuno rispondente agli interessi di questa o quella potenza o gruppi di potenze: i sette Paesi più industrializzati, i famosi G7, agiscono come una sorta di comitato economico mondiale, più o meno concorde al suo interno, ma in genere unito verso l’esterno; il Consiglio di sicurezza dell’ONU agisce come braccio destro di cinque membri permanenti della stessa organizzazione, il cui parere, omogeneo o disomogeneo, determina a sua volta quelle che passano per decisioni autonome dei componenti l’Assemblea; un numero imprecisato di organismi regionali e interregionali difende, nei limiti del possibile, gli interessi tutt’altro che “ideali” di gruppi di potenze appartenenti ad aree specifiche, ecc. L’intero meccanismo funziona sulla base non di codici internazionali di buona condotta, ma di rapporti di forza economica, politica, militare, e la sua capacità non tanto di garantire, quanto di sanzionare un certo “ordine” o, come si dice, un sistema di “diritto internazionale”, dipende dal grado in cui una o più potenze fra le maggiori riescono a far valere il loro diritto, cioè il diritto del più forte: frutto di precedenti rapine e spartizioni di bottino, esse mirano ad assicurarne la conservazione. E, proprio quando quei rapporti di forza cambiano e stanno per cambiare, questi organismi dimostrano la propria ipocrisia e inutilità.
La critica comunista ha mostrato che le guerre sono un prodotto necessario e ineliminabile del modo di produzione capitalistico e che solo la rivoluzione proletaria potrebbe impedirne lo scoppio o interromperne violentemente il decorso. È anche vero che, nei momenti di crisi del meccanismo di accumulazione del capitale, la guerra è il rimedio estremo al quale la borghesia non può non ricorrere per perpetuare il proprio dominio con la distruzione in massa di capitali, merci e forza-lavoro, insomma di esseri umani e di prodotti delle loro mani. Ciò non significa però che la borghesia entri in guerra in base a calcoli ponderati o a più arbitrarie che libere decisioni dei suoi organi legislativi od esecutivi: sono le dinamiche connaturate al modo di produzione capitalistico, le sue esigenze di vita, a mettere in moto il meccanismo del conflitto, a cominciare dai preliminari economici, ideologici, diplomatici, per concludersi con la mobilitazione bellica vera e propria. La guerra non scoppia né “per caso” né “per volontà” di singoli o gruppi: è lo sbocco ultimo di una situazione oggettiva, maturatasi in tutta una varietà di settori ed esplosa nel punto di rottura verificatosi nei rapporti di forza fra le economie dei paesi candidati al ruolo di belligeranti.
Scopo primo del capitale, una volta investito, è di riprodursi con un profitto. È quindi l’accumulazione che muove l’intero ciclo di funzionamento del capitalismo, imponendo di allargare oltre ogni limite la produzione. È la concorrenza, in ogni fase del processo di accumulazione, a selezionare e mettere in urto prima i capitali individuali (o, detto alla spiccia, i capitalisti singoli); poi, man mano che le esigenze dell’accumulazione si fanno più serrate, gli enti collettivi di produzione, le società per azioni, i trust, le multinazionali, insomma le imprese tendenzialmente o effettivamente monopolistiche, i cui interessi, in genere, superano i confini nazionali, e che nello Stato imperialista nazionale trovano la loro espressione politica, il garante dei loro interessi – e soprattutto la grande macchina di forza organizzata in loro difesa.
Ora, mentre – sotto il profilo tecnico – il processo produttivo cresce senza soste né limitazioni, traendo impulso dallo stesso carattere vulcanico della produzione di merci, tende invece a ridursi la possibilità di collocare i prodotti alle condizioni di “redditibilità” indispensabili perché, nelle condizioni date, il processo di accumulazione non si interrompa [2]: al “vulcano della produzione” tende a contrapporsi la “palude” di un mercato che, invece di allargarsi, ristagna. Allora, esplode la più violenta delle contraddizioni: e la crisi del sistema impone il ricorso a soluzioni estreme di forza.
Nei Paesi industrialmente più avanzati, la classe imprenditrice incontra seri limiti all’investimento del capitale accumulato o nella mancanza (o insufficienza) di materie prime di origine locale, o di manodopera indigena, o di mercati di acquisto delle merci prodotte. Oggi, l’approvvigionamento in materie prime non locali, l’ingaggio di manodopera straniera, la conquista di mercati esteri, sono processi che, lungi dal poter essere condotti a termine in maniera soddisfacente con mezzi puramente economici o col mero gioco della concorrenza, implicano lo sforzo costante di regolare e controllare i prezzi di vendita e di acquisto, e i privilegi via via ottenuti, attraverso provvedimenti di Stato o “convenzioni” tra Stati. L’espansionismo economico si è trasformato fin dalla fine del XIX secolo da concorrenziale in monopolistico, e trova espressione, appoggiata da potenti mezzi militari, nella sua forma finanziaria. Si tratti di controllare i grandi giacimenti minerari o le masse da proletarizzare o i mercati di sbocco o aree dove esportare capitali, è la forza a decidere l’esito della corsa all’accaparramento, al controllo o al dominio diretto di settori sempre più vasti dell’economia mondiale. Manifestazione globale degli urti e delle crisi che ne derivano è l’imperialismo, che sul piano economico si manifesta nel processo di accentramento e il cui punto di approdo è l’organizzazione monopolistica della produzione e degli scambi, il dominio della finanza, l'esportazione dei capitali...
Attraverso il capitale finanziario, le potenze vecchie e nuove lottano sullo scenario economico mondiale, pronte a gettarsi in questa o in quell’avventura, a stringere questa o quella forma di alleanza, o a minacciarsi e aggredirsi l’una l’altra, nel disperato tentativo di reagire alla caduta tendenziale (che nella crisi si rende manifesta) del saggio medio di profitto. Ma a ciò si arriva solo assicurandosi e sforzandosi di mantenere posizioni di forza contro i concorrenti su scala nazionale e internazionale. E, quando entrano in collisione, ecco mettersi necessariamente in moto quel meccanismo tipico del capitalismo, e per esso inevitabile, che è il conflitto armato, con il suo prologo di dissoluzioni di vecchie alleanze e nascita di nuove. E questo non ha soltanto per obiettivo il superamento almeno temporaneo della crisi a spese dell’avversario e grazie alla conquista di posizioni più vantaggiose nello sfruttamento delle risorse e del lavoro del Paese o dei Pesi sconfitti, ma anche il rilancio del ciclo di accumulazione del capitale attraverso la distruzione su vasta scala di merci e forze-lavoro e la successiva orgia di ricostruzione – obiettivo comune ad amici e nemici, belligeranti e non belligeranti, vincitori e vinti.
In questi ultimi anni, sono giunte a maturazione le dinamiche messe in moto a metà degli anni ‘70 del ‘900, quando, nell'intero pianeta ormai completamente conquistato dal modo di produzione capitalistico, si è conclusa la fase espansiva della ricostruzione economica del secondo dopoguerra. La prognosi formulata dalla critica comunista si è dimostrata esatta: il Capitale non può sopravvivere alle proprie crisi se non riproponendo le condizioni di una nuova e ben più profonda crisi.
Dal 1975 a oggi, in una sintetica carrellata di eventi, mentre il processo di centralizzazione dei capitali faceva passi da gigante e le grandi industrie ristrutturavano e licenziavano (segno inequivocabile della caduta tendenziale del saggio medio di profitto), e mentre la finanziarizzazione dell'economia procedeva al gran galoppo, i rapporti di forza comunemente noti come “Accordi di Yalta” entravano a loro volta in crisi.
Nel giro di cinquant’anni, tra sussulti e sincopi, tra nuove tecnologie e bolle speculative, tra nuovi insediamenti industriali e drammatiche ristrutturazioni, l'espressione politico-diplomatica internazionale del “dramma” economico ha messo in discussione il peso e quindi la forza delle potenze a più antico sviluppo capitalistico. Per di più, il processo di decolonizzazione dei vecchi carrozzoni imperiali ha fatto nascere e crescere, sempre nel quadro generale della fase imperialista, nuove potenze industriali che reclamano una nuova potenza politica imperialistica, come la Repubblica Popolare Cinese. La conclusione della cosiddetta “guerra fredda” tra USA e Russia mette a nudo la fragilità economica di quest'ultima: nonostante il gigantesco processo di industrializzazione del periodo staliniano, con tanto di bombe atomiche e avventure spaziali, e l'invenzione di un sedicente “socialismo reale” contrapposto e supposto migliore al “capitalismo dell'Occidente”, la Russia si rivela una potenza reggentesi prevalentemente sull'esportazione di materie prime, in misura minore di merci e quasi per niente di capitali. L'URSS addirittura si dissolve per la penetrazione delle promesse e dei capitali occidentali, e ai russi non resta che la nostalgia e lo sciovinismo della Santa Grande Madre Russia: nella sua ferocia, l'Operazione Militare Speciale in Ukraina è solo un disperato tentativo di consolidare i confini occidentali. Le vecchie cariatidi europee, divise tra quelle che si sono rilanciate nel boom del dopoguerra e quelle che vincendo han fatto più fatica a riprendersi, hanno cercato di costruirsi un mercato comune di capitali, merci e forza-lavoro, tendenzialmente protetto e proiettato verso l'esterno: ma, essendo incatenate in una NATO che si sta rivelando sempre di più uno strumento di vassallaggio degli USA e rispecchiando comunque gli interessi conflittuali di una ventina di Capitalisti Collettivi, non hanno né la forza né la possibilità di costituire un’autonoma aggregazione di potenza. Quanto agli USA, vivono l'agonia della potenza grande e decadente: protezionismo e dazi, basi militari, aggressioni per “esportare libertà e democrazia” e precipitosi abbandoni (Afghanistan!), senza dimenticare le guerre imposte agli alleati.
In questo riassunto forzatamente sintetico, abbiamo certamente dimenticato qualcosa: fors’anche qualcosa di importante; e così rimandiamo i nostri lettori, vecchi e nuovi, alla lettura o rilettura di quanto abbiamo pubblicato in questi cinquant’anni di altalenante crisi del modo di produzione capitalistico nella sua fase imperialista. Ma la dinamica e le linee di fondo rimangono quelle. Come rimangono quelle le zone del pianeta dove le forze dei conflitti si scatenano, quasi fossero altrettante zone geologiche in cui si scaricano, con terremoti più o meno intensi, le energie degli scontri tra le faglie continentali: Medioriente, Africa subsahariana, la stessa Europa dei Balcani e del Caucaso. In guerre sanguinose che si trascinano di tregua in tregua, tra scontri indiretti e interventi diretti, tra cambi di regime e definizioni di fragili alleanze, milioni di esseri umani subiscono gli aspetti più feroci del dominio imperialista. Ma attenzione! Non di un astratto impersonale dominio o del dominio di una malvagia potenza imperialista si tratta, ma del dominio particolare del sistema conflittuale degli Stati più o meno fittizi che compongono e scompongono le cosiddette nazionalità dei più giovani Stati borghesi, eredità che il domino coloniale ha lasciato, esportando e impiantando il modo di produzione capitalistico.
Di guerra imperialista in guerra imperialista, si prepara dunque una terza guerra inter-imperialista. Non sarà la sommatoria di tutti questi conflitti che mantengono ancora particolarità locali e interessi specifici, e sbaglia di grosso chi pensa, come il defunto papa Francesco, che si stia già combattendo “una terza guerra mondiale a pezzettini”! Ci dobbiamo aspettare ancora (anche se non possiamo sapere con quali intensità e velocità) che si entri nel vortice dell'economia di guerra (caratterizzata non dal solo aumento delle spese militari e di riarmo) e che gli scontri e incontri diplomatici consolidino nuovi aggregati di potenza e sconvolgano i vecchi.
Ma la nostra scienza del divenire sociale, basata sulla critica dell'economia politica e sull'analisi materialista della storia della nostra specie, non si limita a una più precisa descrizione dei fatti. È soprattutto l'espressione militante e combattente che trasforma l'immensa schiera dei proletari da vittime e strumenti del modo di produzione capitalistico in classe protagonista del movimento che cambia lo stato delle cose esistenti.i8..ò
La via per combattere contro le guerre del capitale comincia mentre ci si batte contro la pace del Capitale e nella mappa della lotta di classe le sue tappe sono ben segnate, così come è noto il punto di arrivo: attraverso lo sviluppo del disfattismo proletario (auspicare che il proprio Stato e i suoi alleati siano sconfitti, disobbedire in maniera organizzata alle gerarchie militari e politiche, disertare e fraternizzare con i nostri fratelli di classe, tenere ben strette le armi per difendersi prima e liberarsi poi dai tentacoli delle istituzioni borghesi), trasformare la guerra tra gli Stati in guerra sociale e civile dentro gli Stati e aprire il processo della rivoluzione comunista, della costituzione del proletariato in classe dominante.
settembre 2025
Note
[1] Si noti che questo stesso bipolarismo era stato per anni presentato come garanzia di “pace generale” (a parte lo scoppio occasionale di conflitti di periferia), sotto la specie di un “equilibrio del terrore”!
[2] “Periodicamente si producono troppi mezzi di lavoro e mezzi di sussistenza per farli funzionare come mezzi di sfruttamento dei lavoratori a un saggio di profitto dato; si producono troppe merci per poter realizzare nelle condizioni di distribuzione e nei rapporti di consumo dati dalla produzione capitalistica il valore in esse contenuto e il plusvalore ivi racchiuso, e riconvertibili in nuovo capitale, cioè per poter compiere questo processo senza esplosioni perennemente ricorrenti. Non è che si produca troppa ricchezza [in assoluto]; è che si produce periodicamente troppa ricchezza nella sua contraddittoria forma capitalistica”. (Marx, Il Capitale, Libro III, sezione III, cap. XV, “Sviluppo delle contraddizioni della legge [della caduta tendenziale del saggio di profitto])”.