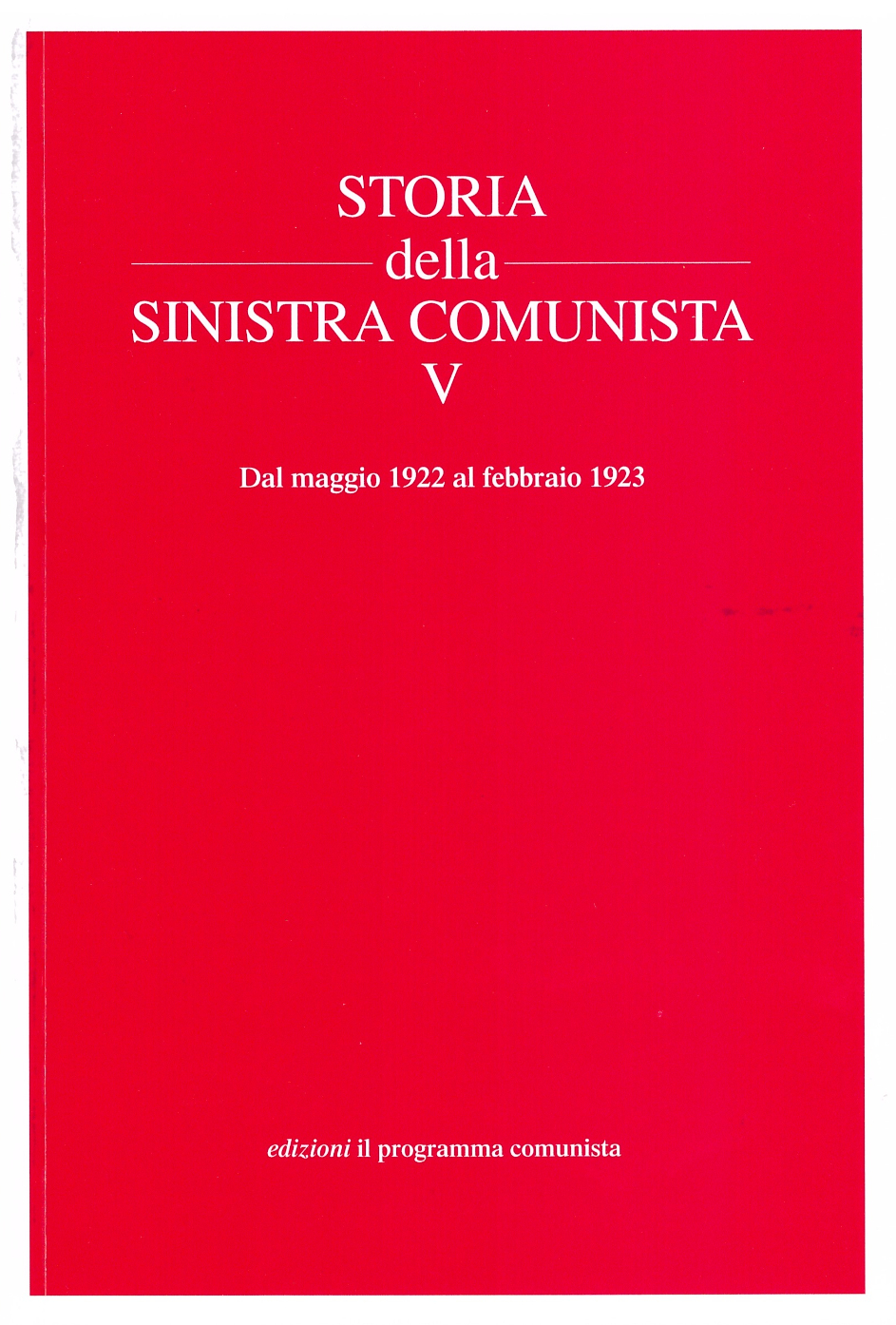Naturalmente, questo è un discorso che, trattato per esteso, occuperebbe pagine e pagine. Si tratterebbe infatti, in pratica, di riassumere il "programma" del comunismo e dunque dovremmo rinviare a tutti i nostri testi e alla nostra tradizione, esperienza e attività di partito il lettore sinceramente interessato a capire e desideroso di ritrovare la via della rivoluzione. E qui, per motivi evidenti, non si può fare. Esistono però alcuni punti-fissi che contraddistinguono nettamente i comunisti rivoluzionari. Proviamo a vederli.
Essere comunisti significa essere anti-democratici. La democrazia è la forma della rivoluzione e del dominio borghesi. Rivendicare l'uguaglianza di tutti gli individui è stata un'arma potente per combattere la chiusura, rigidità e gerarchia tipiche della società feudale. Ma la nuova società uscita dalla rivoluzione borghese non ha mai conosciuto l'uguaglianza, per il semplice motivo che si trattava ancora di una società divisa in classi e dominata dall'imperativo delle leggi economiche capitalistiche. L'uguaglianza era per i borghesi, i proletari conoscevano solo la necessità.
Le cose non sono cambiate con il passare dei secoli. La democrazia resta anzi il miglior involucro per il dominio borghese: quello che meglio illude i singoli individui d'essere liberi e padroni del proprio destino, mentre forze materiali enormi li schiacciano nell'obbedienza a leggi, ritmi, sviluppi e imprevisti che sfuggono loro totalmente. Inoltre, da quando il capitalismo mondiale ha raggiunto la fase imperialista (dominata dal capitale finanziario e dai grandi blocchi di paesi dominanti), questa democrazia si è sempre più svuotata – è diventata una figura retorica che nasconde un'evoluzione sostanziale di stampo sempre più centralizzato, autoritario, fascista.
Democrazia e fascismo non sono infatti in reciproca opposizione, ma dialogano fra loro con l'unica finalità di mantenere saldo il dominio del capitale. È evidente che i comunisti non sanno che cosa farsene d'un concetto come quello di democrazia, che d'altra parte, fin nell'origine del termine, dimostra la propria fondamentale ipocrisia. In greco, "democrazia" significa infatti "potere del popolo, potere di tutti": ma, proprio nella classica democrazia greca, da questo "potere di tutti" erano poi esclusi gli schiavi, gli iloti, gli stranieri. La democrazia non ha dunque nulla a che vedere con il comunismo che, abolendo le classi, sarà la prima vera attuazione dell'uguaglianza: non più per alcuni, ma per l'intera specie umana.
La democrazia non serve ai comunisti né come prassi interna di partito né come strumento di cui servirsi per accrescere l'influenza del partito, né come strumento del proprio Potere una volta sconfitta la borghesia. Il partito comunista è un partito disciplinato, fondato sul centralismo organico: vale a dire, il processo attraverso cui, esattamente come in un organismo vivente, centro e periferia, organi direttivi e organi esecutivi, sono strettamente e dialetticamente collegati, perché agiscono tutti sulla base della conoscenza integrale della teoria, del programma, della strategia, della tattica di partito. E non hanno bisogno di accidenti democratici interni per definire la propria gerarchia, che è frutto della selezione naturale di compagni che lavorano tutti a un comune obiettivo finale, senza privilegi, senza mire carrieristiche, senza riconoscimenti formali o materiali.
D'altra parte, i comunisti dichiarano apertamente i propri fini. Non nascondono a nessuno che, un volta conquistato il potere, essi lo eserciteranno in maniera dittatoriale, perché questo è l'unico modo per compiere quell'operazione chirurgica consistente nel farla finita con la vecchia società - un'operazione chirurgica che sarà lunga, dolorosa e complessa, perché secoli e secoli di dominio di classe non scompaiono in un batter d'occhio. La resistenza della classe vinta sarà feroce e le stesse abitudini e mentalità alimentate da tutta la storia dell'individualismo e localismo borghesi, della competizione e sopraffazione capitalistica, eserciteranno un'inerzia tremenda. Solo quindi un partito fondato su un sicuro programma e strettamente collegato alle grandi masse operaie e di senza-riserve che per la prima volta si risvegliano realmente alla politica potrà realizzare in pieno la dittatura del proletariato – questa fase storica di trapasso senza la quale per il comunismo (come nuova storia della specie, e non di una classe privilegiata o di un manipolo di sfruttatori) non c'è possibilità di vittoria.
Il discorso sulla democrazia porta con sé una conseguenza inevitabile. Essere comunisti significa essere antiparlamentari. Per tutta una prima fase d'esistenza della società borghese, il parlamento ha costituito una delle arene di lotta per i comunisti. Di certo, non la più importante: fin dagli inizi, ai comunisti era chiaro (si vedano le “Tesi sul Parlamentarismo” della III Internazionale, 1920) 1 che il parlamento era soprattutto il luogo dell'illusione democratica, mentre le vere, sostanziali decisioni relative alla vita economica-sociale venivano prese fuori del parlamento. E credere che la classe dominante (pronta a reprimere con la forza qualunque espressione di classe organizzata dei lavoratori) fosse tanto ingenua da affidare la propria sopravvivenza al responso dell'urna era non solo un'ingenuità, ma un vero suicidio politico.
Ciò non toglie che per tutta una prima fase i comunisti abbiano giudicato utile usare il parlamento, esclusivamente come tribuna da cui far sentire la propria voce e dimostrando nei fatti l'antitesi tra lotta di classe e forme del potere borghese, non importa quanto democratiche. Era una tattica che poteva servire, non dimenticando che la reale arena di scontro fra borghesia e lavoratori era fuori del parlamento: nelle fabbriche, nelle strade, nelle piazze.
Utile per i paesi di giovanissima democrazia o per quei paesi in cui stava verificandosi il trapasso da feudalesimo a capitalismo, questa tattica diventava però del tutto inutile e anzi dannosa in quei paesi abituati da secoli alla democrazia, in cui il parlamentarismo era ormai solo una droga potentissima per addormentare la volontà di lotta delle grandi masse. Nella fase imperialistica, si è poi completato il processo per cui le vere decisioni economico-sociali vengono discusse e decise da organismi del tutto separati da quelli della politica rappresentativa: le banche, la Confindustria, il Fondo Monetario Internazionale, ecc. - sono questi i veli organi del dominio borghese, che rappresentano gli interessi generali e internazionali del capitale, assoggettando a sé i singoli Stati e, via via, i singoli governi e parlamenti nazionali e parlamentini locali.
A questo punto, la parola d'ordine dei comunisti può solo essere, ancor più nettamente, antiparlamentarista e anti-elezionista. D'altra parte, le modalità stesse delle elezioni (la loro frequenza ormai ossessiva. il costo mostruoso di ogni tornata elettorale, il polverone televisivo che sollevano, la paralisi di ogni attività rivendicativa e politica che esse impongono) sono la dimostrazione migliore della loro funzione: ingabbiare le energie proletarie, sviarle dal terreno della lotta di classe, illuderle di poter contare una volta ogni tanto. Noi diciamo invece: fuori da queste illusioni, per tornare a una visione ampia della lotta politica, fuori dalle secche frustranti di appuntamenti inutili per i lavoratori, ma utilissimi per la classe che li sfrutta!
Essere comunisti significa essere anti-localisti e anti-federalisti. Localismo e federalismo sono due concetti squisitamente borghesi (se non addirittura pre-borghesi, feudali). Appartengono a una fase storica circoscritta nel tempo, in cui la struttura economica era ancora organizzata a isole, con soggetti economici separati e indipendenti, ancora in grado - visto il limitato sviluppo delle forze produttive - di interagire entro cerchie ristrette. Ma, da quando il capitalismo s'è affermato su larga scala (e in particolare da quando ha imboccato la via senza ritorno dell'imperialismo), questa fase è stata definitivamente superata. E localismo e federalismo sono diventati altre tremende illusioni, autentici miti paralizzanti.
In economia e in politica, la scena mondiale è dominata dai grandi colossi, spinti tendenzialmente a divorare i piccoli e a invadere ogni angolo del pianeta. Il capitale è penetrato ovunque e la globalizzazione del mercato è ormai una realtà decennale. Pensare di tornare ad aprire sentieri di indipendenza e autonomia appartiene alla cecità del piccolo borghese terrorizzato da quanto gli succede intorno, che non capisce e preferisce non capire e lasciarsi cullare dall'illusione di poter condurre, in gelosa autonomia, la propria bottega, i propri affari. Significa credere di poter far girare all'indietro la ruota della storia, con l'accordo passivo di tutte quelle mostruose forze economiche che spingono invece verso la globalizzazione e la centralizzazione. Significa credere, per esempio, che un Meridione fiscalmente ed economicamente autonomo (ma come?) dal Settentrione non sia destinato inevitabilmente a dipendere, fiscalmente ed economicamente, dal Settentrione. Significa immaginare, per esempio, che quella del "piccolo è bello" possa essere una situazione statica, mentre è il continuo movimento e sommovimento a caratterizzare il capitale, la cui legge fondamentale è quella di crescere, non di rimanere piccolo. Siamo, qui davvero, nel campo della totale utopia!
Essere comunisti significa essere antinazionali. La sistemazione in nazioni ha costituito la forma storica dell'avvento al potere della classe borghese. Entro confini disegnati da lunghe e complesse vicende, la classe dominante nazionale poteva svolgere il proprio ruolo economico-politico, in un rapporto dialettico (di volta in volta, pacifico commercio o scontro armato) con altre classi dominanti nazionali. Facendo leva sul mito della "nazione una e indivisibile", la classe dominante ha alimentato l'inganno che missione storica dei proletari fosse quella di identificarsi con la nazione (il suo Stato, la sua economia), difendendola a spada tratta ogni volta che fosse minacciata.
Fin dal 1848, i comunisti hanno messo a nudo quest'inganno. La sistemazione nazionale era un importante passo avanti rispetto allo spezzettamento feudale, ma aveva tutte le stimmate del dominio borghese. Una volta esaurita la fase delle lotte rivoluzionarie nazionali contro i vecchi regimi, i proletari non avevano più nulla da spartire con essa. Essi erano (e a maggior ragione sono nell'epoca dell'imperialismo, dell'ormai completa penetrazione del capitalismo in ogni area del pianeta, dell'emigrazione di massa) senza patria.
D'altra parte, non solo il comunismo come sistema economico-sociale è per sua essenza (l'abbiamo già dimostrato) internazionale, insofferente di ogni limitazione geografica; ma lo stesso capitalismo come sistema economico-sociale, pur esaltando di continuo i miti della nazione e facendo leva su di essi ogni volta che sia necessario al fine di guerre e contrasti inter-imperialistici, è ormai giunto a uno sviluppo sovranazionale: proprio questa contraddizione fra livello internazionale raggiunto dalle forze produttive capitalistiche e orizzonte nazionale del discorso ideologico borghese è uno dei limiti invalicabili che rendono necessaria la morte storica del capitalismo.
Ma essere anti-nazionali non significa solo essere anti-patriottici, rifiutare cioè di cadere nell'equivoco dell'esaltazione e difesa di una "patria nazionale" che per i proletari non esiste. Significa anche riconoscere apertamente che lo Stato, che su quei confini nazionali è stato costruito, non è altro che la macchina che difende gli interessi della classe dominante. non dunque un organismo al di sopra delle classi, una sorta di "buon padre" che amministra imparzialmente la vita sociale ed economica della collettività, ma – come avvenne storicamente per ogni Stato (e come sarà anche per lo "Stato della dittatura proletaria") – uno strumento di coercizione di classe. Solo con il comunismo, e dunque con l'abolizione delle classi, scomparirà l'esigenza di tale strumento di coercizione, perché allora l'umanità non ne avrà più bisogno.
Ma essere anti-nazionali significa anche non cadere nell'inganno, oggi particolarmente insidioso e diffuso, secondo cui l'economia nazionale sarebbe "l'economia di tutti" L'economia nazionale è l'economia del capitale e non esistono interessi comuni fra capitale e lavoro. Se aumentano produzione ed esportazione, a goderne è il capitale, e certo non il lavoratore, che paga quegli aumenti con pena e fatica accresciute. Se aumentano il PNL o la competitività delle merci nazionali, ciò non si traduce in un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della massa proletaria, perché i profitti non vengono graziosamente distribuiti, ma reinvestiti nel processo produttivo a esclusivo vantaggio del capitale. Inchinarsi alle "esigenze superiori dell'economia nazionale" e accettare di compiere sacrifici in suo nome significa insomma ammettere passivamente la propria subordinazione alle necessità della classe al potere. Non solo: significa anche, un domani in cui quelle esigenze lo richiedano, accettare di schierarsi in guerra contro proletari di un altro paese, ingannati allo stesso modo.
La posizione anti-nazionale dei comunisti implica infatti anche una posizione netta e decisa nei confronti di tutte quelle guerre che scaturiscono inevitabilmente dalla fase imperialistica del capitalismo. In questa fase, le guerre (non importa se combattute in nome della Nazione e della Patria, della Libertà e dell'Umanità) non hanno più l'obiettivo di spazzar via residui di sistemi economico-sociali superati o di affermare un ideale etico-politico su un altro. Punto d'arrivo inevitabile di tutto un ciclo economico (boom, saturazione, crisi), esse hanno l'unico obiettivo di distruggere quanto si è prodotto in eccesso (merci ed esseri umani), perché quel ciclo infernale possa riprendere da capo. I comunisti sono dunque contro di esse perché rappresentano l'espressione più cruda della putrefazione che s'è ormai impadronita d'un sistema economico e sociale moribondo.
Ma i comunisti non sono contro le guerre in nome di un generico pacifismo: il pacifismo è (ed è sempre stato) impotente a fermarle e, proprio perché fondato su una “opzione morale”, s'è sempre trasformato in "interventismo" ogniqualvolta la propaganda bellicista di uno Stato o dell'altro abbia sufficientemente suonato la grancassa della "barbarie del nemico" o del "cattivo" di turno. D'altra parte, i comunisti non possono essere pacifisti o non-violenti, perché sanno bene che il trapasso da un sistema economico-sociale all'altro non può avvenire pacificamente, dovrà essere un violento "assalto al cielo". E dunque combattono i miti paralizzanti del pacifismo e della non-violenza, ricordando ai proletari che non devono cadere nell'inganno di guerre combattute nell'interesse altrui, ma devono riservare le proprie energie e il proprio sangue per l'unica guerra che li interessi: quella rivoluzionaria per il comunismo.
Ci sembra di sentire l’ultima obiezione: "Ma allora per voi è necessario concentrare le energie del Partito nella preparazione politica, teorica, pratica della soluzione estrema, della rivoluzione e della dittatura proletarie... Intanto, però gli operai, i proletari, vanno abbandonati a se stessi nelle lotte quotidiane di difesa delle condizioni di vita e di lavoro? o addirittura queste lotte sono inutili?".
Nient'affatto! Non saremmo comunisti, se dicessimo che quelle lotte sono inutili o che non importano al Partito che lavora per la rivoluzione! È invece proprio in quelle lotte che la classe oppressa prende a poco a poco coscienza della necessità della finale battaglia rivoluzionaria. Dunque, l'intervento nelle lotte rivendicative e negli organismi nati dal loro seno (gli stessi sindacati ufficiali o altri organismi autonomi, di base) per imprimer loro un orientamento classista è parte essenziale del compito del Partito, è parte integrante del suo bagaglio storico, della sua mai interrotta tradizione.
1 Le Tesi si possono leggere, con ampio commento, nella nostra Storia della Sinistra Comunista. Vol II, 1919-1920, Edizioni Il programma comunista, Milano 1972.