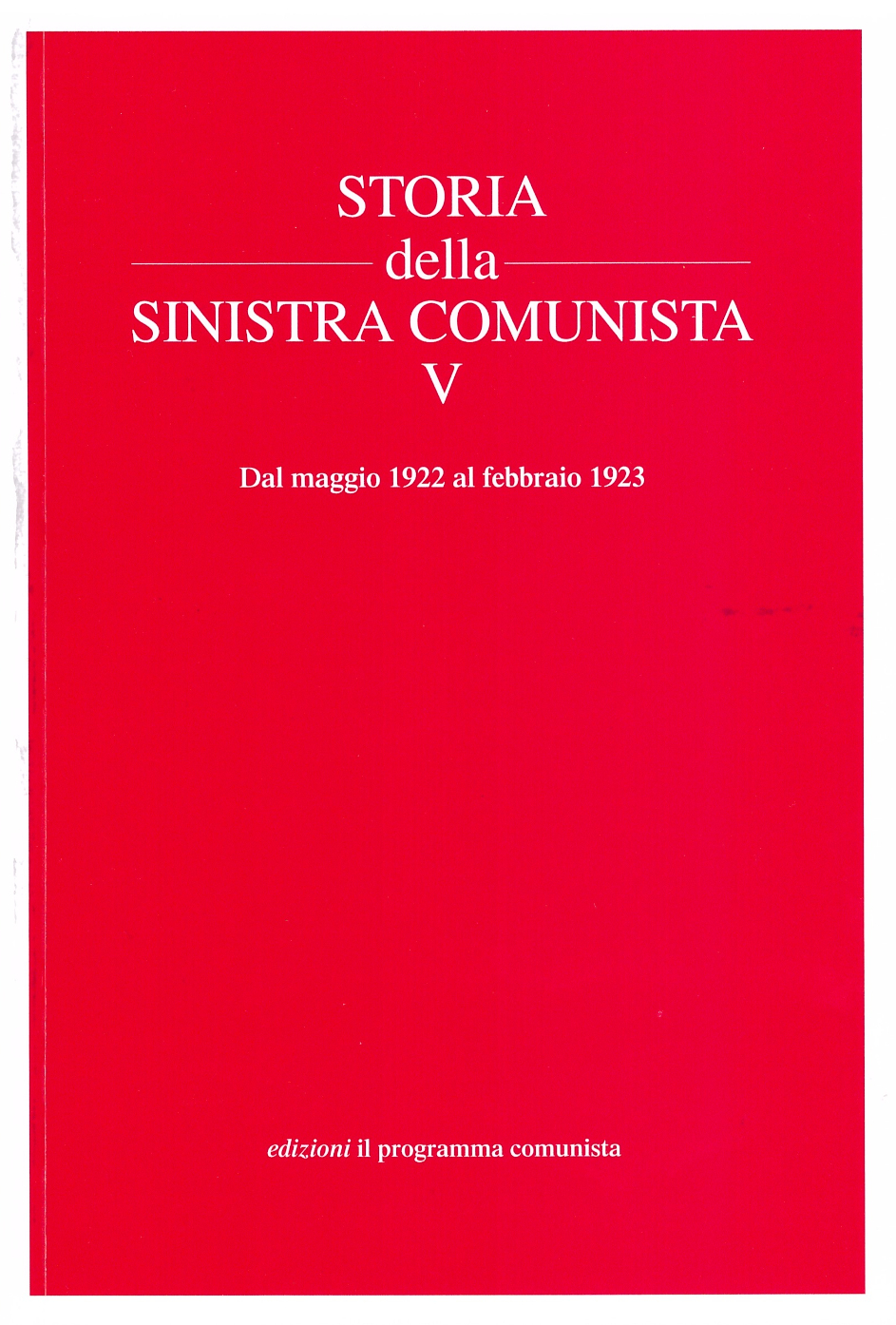Non passa giorno senza che gli organi di stampa di tutto il mondo pubblichino bollettini preoccupanti sullo stato di salute dell’economia. Nel loro universo rovesciato, i commentatori borghesi, gli “esperti” e gli “economisti” percepiscono il netto rallentamento dell’economia mondiale: ma, naturalmente, non possono ricondurlo alle sue cause reali, perché dovrebbero, così facendo, ammettere la caducità del proprio modo di produzione. Fanno dunque della metafisica.
In primo luogo, continuano a interrogarsi se si sia già o meno in piena recessione (la parola “crisi” è per loro troppo forte, poiché implica una frattura, un tracollo; la parola “recessione” è più soft, ed evoca la gradualità di una curva: come dire, “dopo una discesa c’è sempre una risalita”, “dopo un rallentamento, c’è sempre un’accelerazione”), rimandando ogni volta a un domani minaccioso ma appena più in là il pieno riconoscimento del fatto nudo e crudo – cioè, in termini marxisti, che, a partire dalla metà degli anni ’70, attraverso fasi alterne, ma soprattutto con crolli sempre più vertiginosi, il capitale non è più riuscito (non riesce più) ad autovalorizzarsi con la necessaria velocità.
In secondo luogo, attribuiscono il rallentamento dell’economia a quelli che ne sono in realtà gli effetti: i “cattivi” del momento sono allora la flessione del mercato immobiliare, il caso dei “subprime”, la fibrillazione dei mercati finanziari, l’esplodere di questa o quella bolla, l’aumento di prezzo delle materie prime e degli alimentari. E s’interrogano se tutto ciò non rischi di avere conseguenze sull’economia reale... quando è proprio la crisi dell’economia reale a innescare quei processi.
Inoltre, credono di ravvisare nelle manovre della FED, della BCE e di altri organismi centrali una strategia di contenimento della crisi, quando si tratta, in maniera sempre più evidente, dell’affannosa rincorsa di qualcosa che sta già accadendo: così, il taglio dei tassi (dal quale essi si attendono una “miracolosa” inversione di tendenza) non fa che esprimere una realtà già in atto, di cui il ripetuto ricorso al taglio è semmai l’epifenomeno – e questa realtà già in atto è per l’appunto la condizione sempre più asfittica dell’economia mondiale.
Ancora: nell’atto stesso in cui, nei fatti, smentiscono la retorica ideologica liberista (condannata ormai da quasi un secolo dallo svolgimento stesso del capitalismo in senso imperialista, ma sempre risorgente per annebbiare le idee ai gonzi di turno) con appelli sempre più frequenti a decisi e “autorevoli” interventi centrali, essi non possono poi far altro che riconoscere anche l’impotenza di ogni prospettiva di effettiva e praticabile pianificazione e gestione del mercato capitalistico, in grado di attenuarne e controllarne instabilità e vulnerabilità.
Non basta: la preoccupazione degli economisti borghesi si accompagna, da un lato, alla necessità di esorcizzare lo spettro della catastrofe, “rassicurando i mercati” con miraggi di “atterraggi morbidi”, di risalite e di riprese, ecc., e allontanando ogni possibilità di sospetto che sia la struttura stessa del modo di produzione capitalistico a cedere clamorosamente; e, dall’altro, alla necessità di “dipingere il diavolo più brutto di quel che è”, di essere “più catastrofici del dovuto”, di “usare le tinte forti”, e questo per paralizzare attraverso la preoccupazione e la paura e richiedere così altri sacrifici “se si vuole uscire dal tunnel”, ed esigere a gran voce ulteriori giri di vite nel senso della disciplina del lavoro, dell’aumento della produttività, della pace sociale imposta a suon di bastonate se non è sufficiente l’esortazione.
Di fronte a questa plateale incapacità degli economisti, politici ed esperti borghesi (e dei loro reggicoda riformisti di tutte le specie) di fare i conti con la propria crisi strutturale, vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo e quale debba essere la prospettiva dei comunisti.
Vent’anni fa
Quando, nel maggio 1987, i capi delle sette principali economie mondiali si incontrarono a Venezia, la loro agenda prevedeva la discussione sul fosco quadro che si profilava. Tutti gli indici puntavano al basso, qualche cedimento di Borsa induceva a interventi statali, le previsioni statistiche indicavano allarmanti riduzioni dei tassi di crescita per tutti i paesi, fermi intorno al 2,5% (un tasso che oggi farebbe gola a molti!). La crisi e il successivo crollo di Wall Street, durato per settimane nell’autunno 1987, che allarmarono tutto il mondo della finanza, appaiono ormai solo come un piccolo segno premonitore di quanto sta per scatenarsi sul capitalismo mondiale.
Il lungo periodo precedente aveva illuso gli economisti borghesi che i mercati azionari si aprissero a massicce trasfusioni di denaro fresco, da parte dei minuscoli investitori “popolari”, in nome della democratizzazione dei mercati: grandi masse di illusi si precipitarono sulla speculazione in borsa, attirati dai facili guadagni nel campo della ricchezza fittizia. Si fecero allora sempre più forti la corsa alla finanziarizzazione della produzione e la ricerca di ulteriori masse di capitale finanziario. L’“azionariato del lavoro”, benedetto dai sindacati di tutti i paesi industrializzati già dagli anni ‘60, impose che parte degli aumenti salariali fossero trattenuti per legge e investiti nell’azienda. Comparvero i fondi pensione, i fondi di investimento, le assicurazioni, gestiti da grandi gruppi transnazionali la cui attività diventò praticamente incontrollabile. Nell’euforia della massiccia drogatura dell’economia di quegli anni ‘80, la speculazione invase tutti i settori della finanza e quindi della produzione e del commercio; da qui, come era naturale, si trasferì alla politica, con gli spettacolari scandali che investirono governi e multinazionali (tanto per fare un nome, la Enron).
Che si trattasse di pura speculazione, al di fuori di qualsiasi aderenza con la produzione reale, fu dimostrato dal brusco crollo di Wall Street e dalla forsennata corsa alla vendita di titoli ormai diventati carta straccia.
Che cosa aveva determinato quegli sconquassi, dopo i decenni postbellici di corsa al rialzo?
Qualsiasi capitale, grande o piccolo, ha necessità di valorizzarsi. Nei periodi prosperi, ciò è ottenuto attraverso un’estrazione crescente di plusvalore dalle masse proletarie. Nei periodi di crisi, ciò avviene ovunque sia possibile, apparentemente anche “fuori dal processo produttivo”: l’investimento finanziario, sotto le vesti di capitale fittizio creato dalla speculazione, è la forma alla quale i capitali hanno fatto sempre più volentieri ricorso negli ultimi decenni. I piccoli “successi” economici che qua e là alcuni Stati sono riusciti a ottenere per brevi o brevissimi periodi sono stati pilotati in questo modo, e solo i ciechi possono fingere di non accorgersi che questo frequente alternarsi di crisi e fasi di euforia speculativa non fa altro che avvicinare la catastrofe.
Ovunque, la speculazione – che si basa sul credito, e sempre più su un credito gigantesco (a livello di Stati, imprese e famiglie) divenuto ormai inesigibile – cerca di rivitalizzare un’economia asfittica, sorretta da Stati indebitati fino al collo e dalle loro banche centrali: ma in un tale contesto il minimo ostacolo può diventare la scintilla dell’esplosione. Minacciose nubi si addensano dietro l’irruzione della Cina sui mercati delle merci e su quelli della finanza, e ciò cui si aggrappano le malate economie dei paesi occidentali è ormai solo più la speranza che il ruspante capitale cinese non debba dettare fino in fondo le proprie leggi rapaci, poiché il suo crollo conseguente trascinerebbe inesorabilmente con sé il capitale mondiale. Naturalmente, non vi sarà alcuna possibilità di scelta, né per gli uni né per gli altri. Ciò che detta le manovre nel campo economico, e quindi in quello politico, sono le necessità ineludibili della produzione capitalistica, cioè della produzione di plusvalore e della corsa al profitto.
Novità? Sorpresa?
Si è verificato ciò che Marx e Lenin avevano individuato come un meccanismo tipico del modo di produzione capitalistico: giunge cioè il momento in cui “la società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio. Le forze produttive di cui essa dispone non giovano più a favorire lo sviluppo della civiltà borghese e dei rapporti della proprietà borghese; al contrario, esse sono divenute troppo potenti per tali rapporti, sicché ne vengono inceppate [...] I rapporti borghesi sono diventati troppo angusti per contenere le ricchezze prodotte” (Manifesto del partito comunista, Cap. I: Borghesi e proletari). E’ quanto è successo nel corso del secondo dopoguerra. La Seconda guerra mondiale (che fu – è bene ribadirlo ogni volta – uno scontro armato fra blocchi imperialisti concorrenti) fu un enorme bagno di sangue e una gigantesca distruzione di forze produttive, di merci, fra cui quella merce preziosa per il Capitale che è la merce forza-lavoro: era inevitabile che la ricostruzione post-bellica significasse uno straordinario ciclo di accumulazione del Capitale, che si è protratto in maniera travolgente per un trentennio – il boom, il miracolo economico, comunque lo si voglia chiamare, che caratterizzò tutte le economie mondiali uscite dalla guerra, vinte o vittoriose. E che fu pagato dai proletari di tutto il mondo (comprese le masse impoverite delle colonie ed ex-colonie) con uno sfruttamento impressionante sul luogo di lavoro e nella società in genere: si pensi anche solo ai giganteschi flussi migratori che da allora non hanno cessato di spostare manodopera da spremere da un angolo all’altro del globo terrestre. Questo ciclo di accumulazione post-bellico (che si accompagnò, a est come a ovest, a un’opera mai vista prima di costruzione ideologica del consenso) durò per un trentina d’anni. Poi, come il nostro Partito aveva previsto fin dagli anni ’50 sulla base di uno studio attento sul “corso del capitalismo mondiale”, indicando anche la metà degli anni’ 70 come momento di svolta [1], finirà per incepparsi, appunto intorno al 1975. Da allora, con fasi alterne di avanzata e arretramento, la crisi economica ha dominato la scena mondiale, creando i presupposti di ulteriori catastrofi future: perché, “con quale mezzo riesce la borghesia a superare le crisi? Per un verso, distruggendo forzatamente una grande quantità di forze produttive; per un altro verso, conquistando nuovi mercati e sfruttando più intensamente i mercati già esistenti. Con quale mezzo dunque? Preparando crisi più estese e più violente e riducendo i mezzi per prevenire le crisi” (Manifesto del partito comunista, Cap. I: Borghesi e proletari).
Oggi, le verginelle dell’economia borghese parlano della speculazione come di un elemento morale violato dai pescecani della finanza e dai lupi delle Borse, avidi e spietati rappresentanti di un capitalismo che improvvisamente diventa poco paterno, poco protettivo nei confronti del mondo del lavoro. Ciò significa o non voler capire nulla del processo storico che sta alla base, o nascondere i fatti. Significa voler far credere che il capitale finanziario nasca dal nulla e che, risolti gli accidentali problemi sorti misteriosamente e analizzati da questa o quella “teoria del caso”, qualsiasi crisi verrà superata. Noi sappiamo, al contrario, che il capitale finanziario deve la sua nascita e crescita esplosiva al lavoro forzato cui sono condannati milioni e milioni di proletari nel corso di un intero ciclo di accumulazione; e tanto più estese sono state le devastazioni belliche che hanno chiuso il ciclo precedente, tanto più elevata è la massa di profitto che verrà prodotto in quello successivo, tanto maggiore sarà il tasso di plusvalore e quindi la quantità di denaro in cerca di sistemazione. Poco importa, al capitale, se questo immenso mostro che divora lavoro vivo viene tenuto in vita , oltre che da denaro effettivo, da quote gigantesche di semplici “promesse di pagamento”, da scontare in non si sa quale anno a venire. Le vite di generazioni future di proletari sono state ipotecate dal meccanismo odierno del credito, leva potente con la quale il capitale lega a sé gli schiavi salariati, le classi medie, l’intera umanità.
Questa forsennata corsa all’aumento produttivo e la conseguente sovrapproduzione di mezzi di produzione (dunque, la difficoltà prima e l’impossibilità poi di investire produttivamente capitali) sono all’origine di tutte le crisi finanziarie che hanno caratterizzato il XX secolo, nonostante l’aspetto formale più appariscente che le contraddistingue, cioè la rovina delle banche e i crolli borsistici – ciò che induce gli economisti borghesi a trattarle come crisi finanziarie.
Nella fase di sviluppo giovanile, liberistico, del modo di produzione capitalistico, le crisi rovinavano un certo numero di capitalisti, favorendo in certo grado la concentrazione dei capitali. Ma da oltre un secolo il capitalista come figura autonoma e indipendente è sparito, la libertà è solo quella del Capitale come forza impersonale servita da una burocrazia in cui si organizzano gli Stati nazionali. Il capitale finanziario diventa allora lo strumento atto a favorire enormemente gli spostamenti sui mercati esteri. Esso tende così alla continua formazione di un tasso medio di profitto, costringendo alla lotta generale tutti gli Stati concorrenti.
Tutto ciò dimostra che mentivano i pennivendoli della borghesia che negli scorsi decenni ci hanno riempito le orecchie delle loro fantasie sulle panacee universali che avrebbero reso impossibile ogni crisi. Di volta in volta, si trattava del taylorismo, poi del toyotismo, poi della produzione just in time: tutto quello che, insomma, doveva coniugare ritmi forsennati di lavoro con la prosperità universale, all’interno di un mondo nel quale la circolazione delle merci era un processo limpido e tranquillo.
E’ dunque una pura menzogna propagandistica (cui aderiscono purtroppo grandi masse di illusi no global, pacifisti, adoratori di politiche delle riforme e simili) quella secondo cui le crisi siano superabili attraverso una politica di concorrenza e liberalizzazione dei mercati: è una menzogna che “nasconde ed elude più profondi e fondamentali antagonismi dell’imperialismo, cioè quelli esistenti tra i monopoli e la libera concorrenza ancora superstite, tra le gigantesche ‘operazioni’ (e i giganteschi profitti) del capitale finanziario e l’‘onesto’ commercio sul mercato libero, tra i cartelli e i trust da un lato e l’industria libera dall’altro”[2].
I nodi al pettine
Ma oggi molti dei nodi stanno venendo al pettine. L'aumento delle risorse tecniche e produttive e dei bisogni naturali e artificiali; la forbice crescente fra produzione agricola e industriale; lo sconvolgimento della rete di mercati ad ogni crisi, tutto dimostra che le leggi dell’economia sono lì a reclamare le proprie esigenze: sono la condanna storica del capitalismo.
Proprio a causa della sua inarrestabile tendenza allo sviluppo, della crescita gigantesca della produttività del lavoro e dell’enorme massa di mezzi di produzione, il capitalismo deve periodicamente distruggere l’eccesso di ricchezza prodotto. E le crisi del XX secolo si caratterizzano per un’ampiezza sconosciuta al capitalismo del secolo precedente.
La differenza tra le crisi classiche fino al 1929 e quelle seguenti sta nella politica del New Deal, cioè la fascistizzazione dell'economia, con cui lo Stato borghese fa pagare interamente alla classe operaia i costi delle crisi, laddove nel '29 furono i profitti industriali a cadere, in un anno, di oltre il 60%. Alcune caratteristiche di quella grande crisi, che oggi agita i sonni borghesi, furono il dimezzamento della produzione industriale, il forte aumento della disoccupazione, l’aumento del potere d'acquisto, la diminuzione del costo della vita con forte caduta dei prezzi, infine il crollo dei titoli azionari.
Le crisi successive al 1929 sembrano caratterizzate da un aumento dei prezzi e della richiesta di merci: sono gli Stati ad acquistare le eccedenze produttive, distruggendole nelle guerre imperialiste (oltre al macello della seconda guerra mondiale, si contano a centinaia quelle cosiddette “di bassa intensità”, scatenate in tutti i continenti nel secondo dopoguerra) e stimolando così la ripresa della produzione mondiale.
Lo sviluppo tecnologico capitalistico permette di mantenere basso il prezzo degli articoli manifatturati, mentre restano sempre alti i prezzi dei generi alimentari e delle materie prime. Questo fenomeno si è verificato fino al 2006: da allora, i prezzi hanno galoppato al di fuori di ogni controllo. I laminati spessi di acciaio erano venduti nel gennaio 2006 a $525/tonnellata, oggi a 750; nello stesso periodo, una tonnellata di alluminio è passata da $2000 a $2650; nel 2003, una tonnellata di rame era venduta a $1700, oggi addirittura a $8600. Se si aggiungono a questo breve elenco anche i prezzi del petrolio e derivati, si comprende come l’intera macchina produttiva mondiale stia entrando nella fase più critica del secondo dopoguerra.
Dopo la metà degli anni ’70 e a partire dagli anni ‘80, cioè al termine della fase di accumulazione postbellica, si ebbe una quasi generalizzata crisi del commercio estero, cui rispose, negli anni ‘90, la tendenza a un forte aumento nell’esportazione di capitali e negli investimenti diretti esteri. La curva della produzione industriale, in quello stesso periodo, proseguì la tendenza al ribasso relativamente ai paesi di antico capitalismo, mentre si impennò ulteriormente la curva dei paesi “emergenti”, Cina e Corea del Sud in testa [3].
In questo quadro ricco di tensioni e di contraddizioni, con crescenti appetiti imperialisti e feroci lotte concorrenziali su scala mondiale, si consumò il crollo russo all’inizio degli anni ‘90, cui seguirono nuove, forti pressioni speculative sul mercato valutario. Molte divise subirono ondate di vendita per acquistare marchi e, mentre la valuta tedesca si rafforzava, iniziava la parabola discendente del dollaro. Nel 1994, gli Usa aumentarono i tassi per cercare di contrastare la discesa del dollaro, ma questo provvedimento determinò il ritiro dei capitali, soprattutto dal Messico, precipitando il paese nella crisi. Nel 1997, crollarono le orgogliose “Tigri” asiatiche, cui seguiranno la Turchia, l’Albania, l’Argentina. Anche la vecchia Europa si troverà, non marginalmente, coinvolta nelle tensioni internazionali. La guerra nei Balcani fu, per certi aspetti, una prosecuzione di quella del Golfo: era coinvolta in Europa un’area dove per tradizione aveva pascolato il capitalismo tedesco, alla quale guardavano con rinnovato interesse gli Usa e dove erano da lungo tempo svaniti, per necessità più che per desiderio, gli appetiti russi. La campagna al riarmo, il rilancio dell’industria militare, la longa manus stesa sulle vie di trasporto degli idrocarburi caucasici verso il Mediterraneo: queste, e non i principi di “lesa democrazia”, furono le ragioni poste alla base di una guerra che doveva ridisegnare l’assetto geopolitico dell’Europa balcanica.
E’ questo il vero contesto in cui si è mossa l’economia mondiale negli ultimi vent’anni. Ed esso non poteva partorire altro che le due guerre del Golfo, l’intervento in Afghanistan, le continue tensioni nel continente africano, i contrasti alla periferia occidentale della Russia, le turbolenze nell’America latina, per non parlare dei Balcani e dell’intera area caucasica. Gradualmente, ma inesorabilmente, il mondo si va trasformando in una polveriera, alla quale da più parti si avvicinano micce incandescenti.
La crisi e il proletariato mondiale
A partire dunque dalla metà degli anni ’70, di pari passo con il delinearsi e poi approfondirsi della crisi economica mondiale, il Capitale ha condotto un attacco senza pari contro il proletariato, allo scopo di smantellare le “strutture assistenziali” e di riprendersi le “conquiste sociali” strappate con la quotidiana lotta di difesa dei decenni precedenti. Come scrivevamo nell’editoriale del numero scorso di questo giornale, “Se il ciclo di accumulazione apertosi dopo i tremendi disastri della seconda guerra mondiale aveva permesso che, dal banchetto mondiale della ricostruzione, cadessero briciole anche consistenti (e in ogni caso ciò era stato possibile solo perché, a più riprese, il proletariato mondiale aveva scosso con forza i tavoli di quel banchetto), ora, in presenza della crisi e in risposta a essa, la classe dominante di tutti i paesi è impegnata in un attacco violento per rimangiarsi tutto quanto era stato ottenuto. Ciò vale per ogni genere di ‘conquista sociale’, che abbia a che vedere on il salario e l’orario, con misure di ‘più civile convivenza’, o con i tanto sbandierati ‘diritti civili’” [4].
Quest’attacco è proceduto di pari passo in tutti i paesi, indipendentemente dal peso rispettivo sul mercato mondiale, e ha voluto dire: precarizzazione dei rapporti di lavoro, taglio dei salari, aumento dei ritmi e degli orari, progressivo smantellamento dello “stato sociale” (pensioni, assistenza sanitaria, ecc.), delocalizzazione produttiva al fine di abbassare il costo del lavoro sfruttando manodopera più a buon mercato, esasperazione dei flussi migratori come conseguenza degli effetti sociali della crisi sui paesi ai margini delle cittadelle imperialiste e creazione di un gigantesco “esercito industriale di riserva” di migranti con l’effetto di tener bassi i salari, creare divisioni interne alla classe proletaria, offrire una forza-lavoro misera e ricattabile e dunque pronta ad accettare qualunque condizione; e s’è accompagnato a misure sempre più estese di “controllo sociale” e di aperta repressione nei confronti dei proletari più refrattari ad accettare qualunque condizione di vita e di lavoro – in una parola, la “fascistizzazione della democrazia”, già ben evidente all’uscita dalla Seconda guerra mondiale, ha fatto passi da gigante, sotto l’incalzare della crisi economica mondiale [5]. Tutto ciò è avvenuto grazie all’attivo sostegno, teorico e pratico, del riformismo politico e sindacale, che ha offerto alla borghesia di tutti i paesi il proprio aiuto fattivo, illudendo e disorientando i proletari, castrando a più riprese le loro lotte, isolando e denunciando i lavoratori più combattivi e più in generale stendendo un cordone sanitario intorno a qualunque tentativo di organizzazione autonoma e spontanea.
Ciononostante, a livello nazionale e mondiale, le risposte proletarie non sono state poche, e alcune di esse, sia pure sconfitte, sono state anche clamorose: pensiamo ai 40 giorni della FIAT di Torino nel 1980 e, sempre nel 1980, al possente moto proletario in Polonia, allo sciopero dei controllori di volo americani nel 1981, all’ondata di agitazioni alla Renault, alla Citröen, alla Talbot e nelle miniere di carbone della Lorena in Francia nel 1981, ai grandi scioperi dei minatori inglesi nel 1984, ai violentissimi scioperi scoppiati in Corea del Sud nel 1997 e, sempre nel 1997, al lungo e combattivo sciopero all’UPS statunitense, alla situazione esplosiva dei ghetti americani e alle lotte degli immigrati (clandestini e non) negli stati americani del sud-ovest, all’endemica instabilità sociale di molti paesi dell’America Latina (dal Messico all’Argentina, passando per Brasile e Venezuela), all’autentica polveriera rappresentata dal Medio Oriente dove false “questioni nazionali” mascherano e sviano un aperto conflitto di classe...
In questi ultimi anni, poi, il progredire della crisi mondiale ha sprofondato masse sempre più numerose nella difficoltà di affrontare l’oggi e nell’angoscia per il domani: fiumi di ipocrisia si rovesciano a valanga ora per negare l’evidenza, poi per mascherarla con parole di compassione, infine per evitare che la scintilla della rivolta incendi tutto il pianeta. Mai come in questo periodo, nel secondo dopoguerra, le condizioni di miseria sono cresciute al limite della sopportazione, mai la tensione sociale si è diffusa così a macchia d’olio su tutti i continenti. Alla fase di produttività esasperata, all’enorme consumo di forza-lavoro, alla gigantesca dispersione di energie, di merci, di servizi, fa ora seguito il corollario della violenta distruzione del lavoro accumulato e della distruzione sistematica di ricchezza sociale. Non è il dato bruto della miseria, dell’insufficienza del salario, che caratterizza quest’epoca (in cui, quando non c’è lavoro per tutti, c’è per tutti elemosina), ma il generalizzarsi spaventoso dell’incertezza, il moltiplicarsi della distruzione, l’esaltarsi del caos, l’orgia di dissipazione di tutto ciò che sta fra il minimo per vivere e il massimo che si produce.
Ora è il momento nel quale la miseria costringe masse di affamati nelle piazze, per cercare di prendersi con la forza ciò che la loro condizione di salariati non concede più. Torna alla mente la limpida posizione del marxismo in tema di miseria sociale – una miseria sociale che consiste nel non possedere i mezzi di produzione e quindi nel non possedere la disponibilità del prodotto. Ciò significa che il produttore, cioè il lavoratore proletario salariato, resta senza difese nel momento in cui la crisi si sviluppa e la disponibilità di merci si riduce. Il sogno del gruzzolo faticosamente affidato alla gestione di una banca, l’appartamento di trenta metri quadri comperato per le vacanze, l’auto acquistata a rate che illude il felice proprietario su una raggiunta prosperità – dunque quelle poche miserie con le quali il capitale ha cercato di plasmare mente e volontà dei proletari sulla propria immagine – svaniscono presto nel nulla, e lasciano chi si credeva diventato “possidente” a riflettere sulla sua reale condizione di proletario senza risorse. Sono le leggi dell’accumulazione del capitale e della miseria crescente scoperte da Marx a reggere le sorti del sistema borghese; sono i trucchi borghesi del capitalismo democratico, dell’operaio-azionista, dell’assistenzialismo sociale a impedire ai miliardi di senza-risorse del pianeta di farla finita una volta per tutte con il capitalismo.
Le recenti rivolte per il pane in molti paesi d’Africa, d’Asia e d’America ne ricordano altre, caratteristiche di un passato che la borghesia e soprattutto gli appassionati di “riforme” e di “progresso” davano per morto e sepolto, e che annunciava le grandi lotte proletarie in Europa di cent’anni or sono.
Ma oggi la situazione si sta generalizzando a tutte le aree geografiche. I recenti scontri di piazza per il pane in Egitto, in Indonesia, nelle Filippine, in Senegal, in Camerun, in Etiopia, nei Carabi, in Pakistan, in Thailandia, spesso con l’intervento dell’esercito in difesa dei proprietari di magazzini, non fanno che preludere a quello che potrebbe succedere, fra non molto, anche nei principali paesi imperialisti. I falsari delle grandi organizzazioni “umanitarie”, gli sbirri che reggono le fila dei cartelli alimentari e finanziari mondiali, proclamano a gran voce che è tutta una “anomalia”, che tutto rientrerà “nella norma”, che è colpa di questo o quel “pazzo” che ha aumentato i prezzi dei prodotti alimentari. Li lasciamo volentieri alle loro vuote declamazioni, con la certezza che le loro elemosine non serviranno a nulla.
Ma tutte le tendenze dell’economia volgono a favore del movimento rivoluzionario comunista. La crisi dell’economia rivela al proletariato mondiale la sua vera natura, che è quella di produttore mondiale di plusvalore. Per definizione e necessità, esso deve essere organizzato su scala internazionale, e proprio questa è la strada che i movimenti nazionali, per ora ancora slegati, devono imparare a percorrere, riconoscendo che gli interessi locali sono gli interessi di tutti, e che tali interessi non parlano questa o quella lingua, ma l’unica lingua della lotta armata per il potere.
E tuttavia, tutto ciò non basterà per giungere alla resa dei conti. Non bastò ai popoli delle “Tigri” asiatiche, quando la sbornia finanziaria passò come un ciclone. Non bastò in Turchia, in Albania, in Italia, quando rimasero con un pugno di mosche milioni di illusi e di ingenui che pensavano di fare affari con le speculazioni in Borsa. Non bastò in Argentina, dove la rabbia proletaria non riuscì a trasformare i pur decisi picchetti operai in qualcosa che andasse al di là della “protesta delle casseruole”. Non basterà mai il giusto e sacrosanto odio proletario per il capitale, senza una direttiva comune di azione, senza un programma che non giunga a compromessi col nemico e che ponga come meta imprescindibile l’abbattimento violento del potere borghese. Questa direttiva, questo programma non si possono costruire nel fuoco della lotta, quando sono altri gli elementi che devono entrare in gioco (le modalità di conduzione dello scontro aperto, l’attacco contro questo o quel bastione del capitale, le esigenze tattiche immediate). Questa direttiva, questo programma non si possono costruire nel fuoco della lotta, quando sono altri gli elementi che devono entrare in gioco (le modalità dello scontro di classe, l’attacco contro questo o quel bastione del capitale, le esigenze tattiche immediate). Tutte le volte che le battaglie più aspre, condotte dal proletariato più deciso, hanno dovuto cercare al proprio interno, da sé, nell’immediato, la strategia e il programma, i soli capaci di trasformare la battaglia in conquiste durature, subito le sirene della socialdemocrazia, del riformismo, dell’opportunismo alleato alla borghesia hanno inoculato il proprio veleno, separando, smembrando, creando false illusioni e facendo naufragare la lotta più tenace, preparando la strada alla reazione e alla violenza antiproletaria.
La prospettiva comunista
Il modo di produzione capitalistico sta andando verso l’unico sbocco che la classe dominante conosca per risolvere la propria crisi strutturale: un nuovo conflitto interimperialistico. La Prima guerra mondiale vide il tracollo di tutti i partiti socialdemocratici, che – con l’unica eccezione del piccolo partito socialista serbo e con la posizione peraltro ambigua del partito socialista italiano (“Né aderire né sabotare”) – votarono i crediti di guerra, schierandosi al fianco delle rispettive borghesie, invece di lavorare alla trasformazione della guerra imperialista in guerra civile: solo pochi gruppi di coerenti comunisti seppero mantenere la giusta rotta di classe, presupposto per la Rivoluzione d’Ottobre e il dopoguerra illuminato ovunque da fermenti rivoluzionari. La Seconda guerra mondiale giunse dopo la violenta sconfitta del proletariato a opera della democrazia (che cullò i proletari nell’illusione di uno sviluppo pacifico del modo di produzione capitalistico), del nazifascismo (che colpì a morte un proletariato già disarmato e disorientato dall’imbelle pacifismo socialdemocratico) e dallo stalinismo (che ribaltò ogni prospettiva comunista, teorizzando la “costruzione del socialismo in un paese solo” e alleandosi prima con un blocco imperialista e poi con l’altro, in nome della “difesa della patria e della democrazia”). All’appuntamento con la Terza guerra mondiale che si sta preparando è necessario arrivare avendo fatto tesoro di tutte queste esperienze, sia quelle positive che quelle negative, e soprattutto con la chiarezza teorica e strategico-tattica, con la saldezza organizzativa, con il radicamento internazionale del partito rivoluzionario: se ciò non sarà, un nuovo macello si prepara, e sarà ancor più devastante degli altri due.
Da materialisti, sappiamo che la coscienza segue l’azione, e non viceversa. Sotto l’incalzare di questo vero e proprio attacco da parte del capitale, che nei prossimi anni non farà che estendersi e approfondirsi, il proletariato mondiale sarà costretto a battersi per difendere le proprie condizioni di vita e di lavoro. Sarà costretto a darsi organizzazioni autonome dallo Stato (che si rivelerà sempre più suo nemico spietato e accanito difensore degli interessi borghesi), oltre che da partiti politici e da sindacati che nel corso di tutti questi decenni non hanno fatto altro che ingannarlo con promesse riformiste, ingabbiando le sue lotte, boicottandole, disorganizzandole e tradendole, e denunciando apertamente i lavoratori più combattivi e generosi. Sarà costretto a superare tutte le divisioni e gli antagonismi che lo stesso modo di produzione capitalista alimenta nel suo seno (razzismo, localismo, nazionalismo), comprendendo nella lotta che solo un fronte unito proletario potrà rispondere efficacemente all’attacco del capitale. Sarà anche costretto a comprendere come la pura e semplice (sebbene necessaria) difesa delle proprie condizioni di vita e di lavoro non può bastare: che è necessario, anche solo per rendere efficace quella lotta di difesa, passare al contrattacco: dalla quotidiana guerriglia economica all’autentica guerra di classe, che è guerra politica per la conquista del potere.
Un’organizzazione mondiale di lotta richiede un’organizzazione mondiale di programma, e questo programma non può essere altro che quello che nasce da una forma sociale superiore, cioè il comunismo. Tutte le categorie economiche borghesi hanno da lungo tempo esaurito una qualsiasi funzione positiva nello sviluppo sociale, permettendo ormai solo più il prosperare di forme di parassitismo, di spreco e di distruzione. Tutto è pronto, da troppo tempo, per lo sviluppo di una società senza mercato, senza denaro, senza lavoro salariato e senza capitale, nella quale si sviluppino armonicamente le potenzialità dei singoli e della società.
Questo programma, a lungo conservato nella memoria delle grandi lotte del passato, esiste e non necessita di essere elaborato da particolari scienziati della sociologia (dei quali, al contrario, si deve diffidare in sommo grado!). Ma esso può essere spiegato e inserito nella classe solo da un organo specifico, che non si pone gli obiettivi di conquiste limitate, di rivendicazioni particolari, locali o aziendali. Questo organo specifico non si chiama sindacato, né circolo o club, né cenacolo di studio. Esso è il partito di classe, e non vi è proletario combattivo che non veda come esso sia rimasto troppo a lungo lontano dalla storia della classe.
Centrale e irrinunciabile è dunque il rafforzamento e radicamento internazionale del partito rivoluzionario, saldamente ancorato alla tradizione della Sinistra Comunista, l’unica che – sull’arco ormai di quasi un secolo – abbia saputo resistere e rispondere (teoricamente, politicamente, organizzativamente e praticamente) alle forze convergenti della controrivoluzione democratica, nazifascista e staliniana, mantenendo fermi i principi che da sempre distinguono i comunisti da ogni altra formazione, da ogni altro raggruppamento, da ogni altro partito: la lotta senza quartiere alla società del profitto e del capitale, l’internazionalismo, la necessità della violenta rottura rivoluzionaria, della presa del potere e dell’instaurazione della dittatura proletaria, sotto la guida del partito comunista. Al Congresso di Lione del 1926, mentre si consumava la grave sconfitta storica del movimento operaio e comunista internazionale ad opera dello stalinismo, la Sinistra Comunista, dopo essere stata allontanata dalla direzione del Partito Comunista d’Italia – Sezione dell’Internazionale Comunista, condusse la sua battaglia estrema, fissando nelle sue Tesi (contrapposte a quelle ultra-opportuniste di Gramsci e Togliatti) le basi necessarie per la rinascita futura del movimento comunista. In esse, si leggono anche quelli che sono i compiti vitali del partito rivoluzionario, nella lunga fase controrivoluzionaria che purtroppo fa ancora sentire il proprio peso nefasto sul proletariato mondiale:
“a) la difesa e la precisazione, in ordine ai nuovi gruppi di fatti che si presentano, dei postulati fondamentali programmatici, ossia della coscienza teorica del movimento della classe operaia;
b) l’assicurazione della continuità della compagine organizzativa del partito e della sua efficienza, e la sua difesa da inquinamenti con influenze estranee ed opposte all’interesse rivoluzionario del proletariato;
c) la partecipazione attiva a tutte le lotte della classe operaia anche suscitate da interessi parziali e limitati, per incoraggiarne lo sviluppo, ma costantemente apportandovi il fattore del loro raccordamento con gli scopi finali rivoluzionari e presentando le conquiste della lotta di classe come ponti di passaggio alle indispensabili lotte avvenire, denunziando il pericolo di adagiarsi sulle realizzazioni parziali come su posizioni di arrivo e di barattare con esse le condizioni della attività e della combattività classista del proletariato, come l’autonomia e l’indipendenza della sua ideologia e delle sue organizzazioni, primissimo tra queste il partito.
“Scopo supremo di questa complessa attività del partito è preparare le condizioni soggettive di preparazione del proletariato, nel senso che questo sia messo in grado di approfittare delle possibilità rivoluzionarie oggettive che presenterà la storia, non appena queste si affacceranno, ed in modo da uscire dalla lotta vincitore e non vinto” [6].
Dunque, difesa della teoria, continuità politico-organizzativa, intervento attivo nelle lotte di classe: da lì, noi – il Partito Comunista Internazionale (Il programma comunista) – siamo ripartiti, nella convinzione che la nostra è l’unica via per giungere alla presa del potere, all’instaurazione della dittatura del proletariato e infine, dopo secoli di sanguinoso dominio del capitale, alla società senza classi, alla società della specie umana, al comunismo.
Note:
1. Fra i tanti articoli sull’argomento usciti allora sulle pagine di questo giornale, cfr. "L'economia capitalistica in Occidente e il corso storico del suo svolgimento" (n.19/1956) e "Il corso del capitalismo mondiale nella esperienzastorica e nella dottrina di Marx" (pubblicato ininterrottamente dal n.16/1957 al n.7/1959).
(il programma comunista n°03 - 2008)