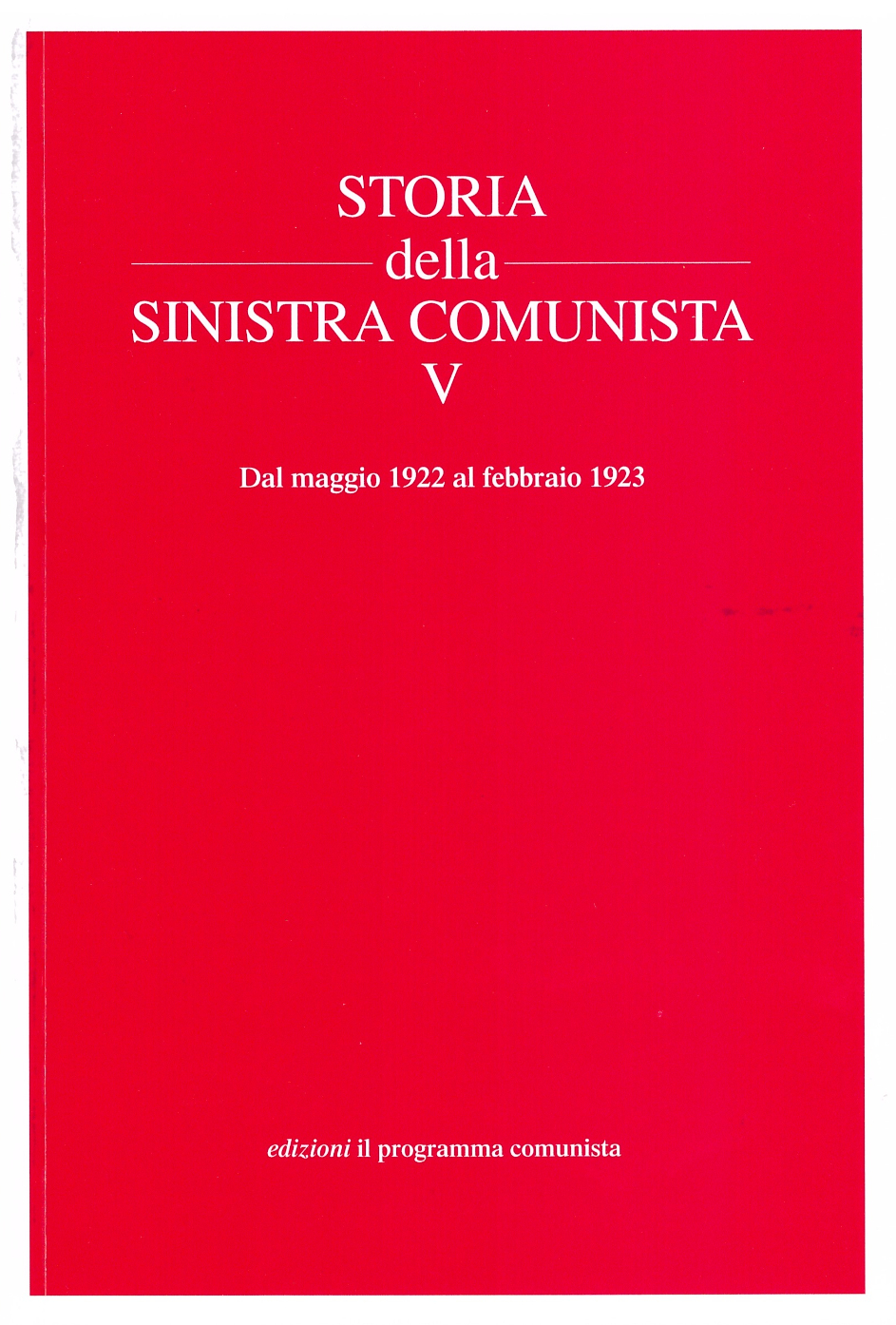8. Inizio della lotta al riformismo: appare la falsa sinistra sindacalista.
Il partito fu riconvocato a congresso nell'aprile 1904 a Bologna.
Era già avvenuta nel partito francese la scissione fra marxisti e possibilisti. Una grave tensione fra le due tendenze era avvertita pure nel partito italiano, ma si cominciò ad organizzare la tendenza dell'unità a tutti i costi; anche questa, una novità di mezzo secolo e più.
Fu un congresso movimentatissimo. In una prima votazione si affrontarono due ordini del giorno estremi che ebbero circa pari voti, 12 mila (iscritti) ognuno, mentre circa 7.000 furono gli astenuti. Seguì una seconda votazione su due ordini del giorno detti di centrosinistra (Ferri) e di centro-destra (Rigola) e prevalse il primo con 16.304 voti contro 14.844. Non vi fu scissione. L'ordine del giorno Bissolati era per l'aperta ammissione del possibilismo parlamentare, o voto di appoggio a ministeri; i due intermedi non meritano lungo esame; quello di sinistra afferma principi antimonarchici, sostiene l'uso della violenza, esclude che «nei parlamenti sia risoluta l'abolizione della proprietà capitalistica». Qualche rara formula è esatta, ma non si può dire che in questo testo sia tradotta la posizione marxista sulla questione dello Stato e della rivoluzione.
Dopo il 1904 la lotta di classe in Italia si sviluppa con scontri violenti: nelle campagne, sistematicamente, le forze dello Stato borghese reprimono in sanguinosi eccidi le ribellioni del proletariato rurale (che mal si definiscono azioni contadine), numeroso, diffuso, aggressivo ed istintivamente rivoluzionario: il proletariato dei grandi centri sempre più validamente organizzato nelle Camere del Lavoro sperimenta spesso con successo lo sciopero generale. Ma la grande Confederazione Generale del Lavoro cade poco dopo la sua fondazione nelle mani dei riformisti e ne costituisce la base più solida, sconfessando e stroncando le azioni di portata nazionale (come un grande sciopero dei ferrovieri) che naturalmente ponevano al proletariato il problema del potere.
In questo periodo di grande attività operaia la borghesia italiana tende a tornare alla maniera forte, e per il pericolo socialista la Chiesa allenta il non expedit di Pio IX (divieto agli elettori italiani di partecipare alla vita dello stato liberale). Giolitti è nel cuore di questa manovra. Entrano così alla Camera i primi cattolici, precursori dell'odierna democrazia cristiana con cui, magari al livello delle solite coglionatissime grandi masse, oggi 1963 i socialisti e comunisti amoreggiano.
Il proletariato reagisce anche con eroismo, ma la vigoria delle masse è tradita dalla deviazione del partito dalla linea rivoluzionaria. L'indignazione nelle file del partito stesso contro il destrismo parlamentare prende la forma errata del sindacalismo rivoluzionario, che dà allora una sua formula definitiva e una sua dottrina storica e attira sotto quella bandiera le forze di sinistra. Nel congresso di Roma del 1906 scoppia il conflitto tra le due potenti ali dei riformisti e dei sindacalisti; la voce della sinistra marxista vi sarà fioca e debolissima.
Facciamo tema di commento solo gli ordini del giorno, dopo aver detto che il riformismo si mimetizza, come ha sempre fatto, sotto le vesti del nuovo integralismo di Oddino Morgari (il cui solo merito fu di organizzare i fischi allo zar massacratore a Pietroburgo nel 1905, facendone disdire la visita ufficiale che, vedi ironia, era una tappa degli amori italici con la… democrazia europea dell'intesa franco-inglese e quindi della duplice franco-russa, in nome di quell'odio al tedesco che ancora nutre di sé la tendenza-carogna) e vince con ben 26.493 voti contro 5.278 dei sindacalisti e 1.161 all'o.d.g. Lerda (intransigente). Morgari aveva ottenuto da Turati e Treves molte concessioni, ammettendo una transigenza solo per eccezione ma regalando loro la disfatta dei sindacalisti.
L'o.d.g. sindacalista é questa volta più completo. Chi lo legga tutto a pag. 75 del 2° volumetto de Il Partito Socialista Italiano nei suoi Congressi, ed. Avanti!, Milano, 1959, potrà studiarvi un nostro rilievo: esso anticipa la costruzione propria di Gramsci, che noi sinistri combattiamo come ordinovismo e, come vedremo nel seguito, abbiamo denunziata appena sorta, nel 1919.
Gli scopi della rivoluzione sono qui due: espropriazione della classe capitalista; decomposizione del potere politico. È dunque non compreso che questo si può decomporre solo dopo di avere non solo spezzato lo Stato borghese (e sta bene) ma anche storicamente fondato sulle sue rovine la dittatura politica proletaria, che è uno Stato a sua volta. Seguiamo il testo: lo strumento è la potenza della classe operaia nel suo «organo sindacale». Si è delineato il processo al partito e alla sua funzione rivoluzionaria.
Gli organismi di mestiere devono evolvere fino a rappresentare la totalità degli interessi operai non solo per la finale azione rivoluzionaria ma anche per «i miglioramenti compatibili con la esistenza della società presente». Questo non è altri che il «controllo operaio» dei torinesi di 15 anni dopo.
Il compito del partito è ridotto alla funzione di «educare e promuovere la costituzione sindacale, cioè in classe, del proletariato».
L'azione rivoluzionaria si esplica con lo sciopero generale (questa è una verità storica), ma «mira a togliere alle classi capitalistiche le difese materiali dello Stato, trasferendone le funzioni agli organi sindacali o all'individuo». Era chiaro che gente del calibro di un Treves, Modigliani, Turati, Mondolfo e simili, destri politici ma anche validi studiosi, avevano buon gioco nel combattere questa che derisero come mitologia soreliana, e nel dire che si tornava alle aberrazioni bakuniniane per tema delle parole potere e partito.
Noi aggiungiamo oggi che questo non era se non un nuovo tipo di gradualismo dalle pose rivoluzionarie, che con i suoi decisi avversari del tempo aveva in comune di rendere graduale anche quella sola cosa che graduale non può essere, ossia il salto violento nel maneggio dello Stato, arma che l'umanità, per buttarla via, deve aver impugnata in direzione rovesciata. Lo stesso errore sta alle basi del gramscismo, che vede una serie pragmatica nel controllo dei consigli operai di azienda, nella loro gestione, e in un loro progressivo sostituirsi allo Stato capitalistico, concezione che ha fatto ricadere i suoi epigoni nello stesso errore comune ai due contendenti del 1906, e infine in forme indegnamente inferiori a quelle della destra di allora.
Non citeremo l'ordine del giorno degli intransigenti, che è scarno, educazionista per il compito del partito e agnostico sulle forme in cui si attuerà l'abolizione delle classi, che dice non potersi definire «scientificamente» facendo così gioco ai travisatori del marxismo. Migliore è il breve resoconto del discorso di Giovanni Lerda, i cui meriti, diciamo subito, non valsero ad evitare nel 1914 la sua eliminazione dal partito perché «massone» ostinato. Nella posizione del marxismo rivoluzionario autentico è sempre stato purtroppo difficile invecchiare!
Lerda ebbe i soliti cinque minuti dei congressi stanchi e non poté dire molto di più del testo che ne dà in forma riassuntiva il volumetto già citato (p. 72): «I socialisti rivoluzionari, mentre rifiutavano il sindacalismo come concezione teorica essa sola capace di condurre all'emancipazione del proletariato, accettavano alcuni punti dell'azione pratica dei compagni sindacalisti, specialmente quelli riguardanti una più salda integrazione della azione socialista col principio della lotta di classe. Per questo egli non poteva accettare né l'ordine del giorno sindacalista né quello integralista che lasciava aperta la possibilità a una collaborazione coi partiti borghesi».
Questa posizione del tutto chiara risponde pienamente alla linea storica, che qui andiamo ravvisando, della sinistra marxista rivoluzionaria.
In sostanza, al congresso di Roma vinse ancora la tendenza riformista, perché Prampolini annunziò l'adesione di quest'ultima agli integralisti dopo che per lunghe sedute la sua frazione li aveva combattuti: perfino il poco rettilineo Ferri poté allora deplorare che l'integralismo fosse divenuto l'ovile del riformismo, e che i riformisti non avessero nemmeno la sincerità di votare il proprio ordine del giorno.
Nel luglio 1907, in un loro congresso a Ferrara, i sindacalisti decidevano di uscire dal partito, sebbene vari gruppi, con Lazzari che a Roma aveva votato per il loro ordine del giorno, non per quello di Lerda, rifiutassero di seguirli.
Il biennio successivo fu contrassegnato da vivacissime agitazioni operaie, non senza conflitti violenti con la forza pubblica e vittime proletarie, fenomeno incessante della democratica Italia. I sindacalisti rivoluzionari (Michele Bianchi, poi fascista, a Bologna; Alceste de Ambris; poi interventista, a Parma) condussero anche vigorosi scioperi dei braccianti agricoli, che però ne uscirono sconfitti. I rifiuti della Confederazione del Lavoro allo sciopero generale in tutti questi casi acuirono l'urto fra le due correnti: i sindacalisti avevano fondato l'Unione Sindacale Italiana, e a Modena nel 1908 i riformisti si imponevano al congresso della C.G.L.
Ma l'urto era, oltre che fuori, dentro il partito. Il riformismo era in rapidissima ascesa, avendo come fulcri principali il Gruppo parlamentare e la Confederazione del Lavoro: a nome di entrambi, già a Roma, Rigola aveva propugnato l'«autonomia temperata» del primo e, quanto alla seconda, l'impegno della Direzione, «quando si tratti di cose interessanti non solo il Partito socialista ma anche e principalmente il proletariato», di «sentire anche le organizzazioni di mestiere»: il risultato si vide quando, nell'ottobre 1907, Direzione ed esecutivo confederale andarono a gara nel decidere di respingere la richiesta del Sindacato Ferrovieri di uno sciopero generale di protesta per l'uccisione di un operaio a Milano durante l'agitazione dei gasisti. All'autonomia sempre più accentuata del Gruppo parlamentare corrispondeva, d'altra parte, una tendenza all'autonomia delle sezioni: a Milano, contro lo statuto, se ne ebbero perfino due, sotto patrocinio turatiano.
In questa situazione si aprì a Firenze, nel settembre del 1908, il X congresso del Partito. La destra giocò a carte scoperte, forte della vittoria di Roma e della fragilità dell'ala sinistra intransigente. Turati proclamò, nel difendere apertamente la versione evoluzionistica del socialismo data dalla sua corrente contro gli attacchi dell'ala sinistra, per debole che fosse: «Ci si dica: voi dovete andare fuori; e ce ne andremo, senza ira e senza rancore; altrimenti, ci si accetti per quello che siamo, per le idee che rappresentiamo». Rigola svolse la tesi, infiorata di pseudo-richiami al marxismo, che «le organizzazioni economiche non possono essere più sotto la dipendenza del Partito Socialista» e propugnò in effetti una chiara preponderanza della Confederazione sul Partito, primo sintomo di quello che giustamente fu detto «sindacalismo riformista». La frazione intransigente espresse per bocca soprattutto di Lazzari e Ratti la sana, ma confusa, reazione di proletari e militanti non corrotti a questo andazzo; il primo dichiarando: «Dobbiamo avere tutto il rispetto per gli interessi immediati trattati dalla Confederazione del Lavoro, ma noi siamo Partito socialista e la visuale che dobbiamo avere per guida nella nostra azione deve essere tale da non lasciare possibilità di subordinare i nostri grandi interessi ideali alle diverse necessità transitorie che quotidianamente, per la difesa e tutela degli interessi immediati dei lavoratori, possono anche essere necessarie» e rivendicando di fronte ai milanesi la necessità di «un solo programma, un solo principio, un solo metodo, una sola disciplina, che ci deve legare tutti»; il secondo respingendo il mito sindacalista dello sciopero generale ma, nello stesso tempo, il pretesto che i confederali ne traevano per espellerlo definitivamente dall'armamentario di lotta del proletariato: «Noi diciamo:lo sciopero generale è un'arma potente: facciamo la propaganda perché diventi un utile strumento contro la borghesia. Ma se cominciamo prima a distruggere l'efficacia dello sciopero generale dicendo che non lo faremo né fra dieci, né fra venti, né fra cinquant'anni, non lo faremo più, e distruggeremo in mezzo alle masse il sentimento della sua utilità». Lo stesso Ratti doveva proclamare che «il sindacalismo riformista... è peggiore del sindacalismo rivoluzionario» e Longobardi accusare la Confederazione Generale del Lavoro d'essere un «movimento di aristocrazia» operaia. Come già a Roma, ma in forma più accentuata, si cominciava a lasciar intravedere la possibilità, sia pure remota, di una partecipazione al governo; la risposta degli intransigenti, se fu decisa, non si distinse altrettanto per chiarezza teorica.
Al congresso vinsero ancora i riformisti con 18 mila voti circa su un ordine del giorno detto concordato, mentre gli integralisti ne ottennero un po' meno di 6.000, e quasi 5.400 gli intransigenti su un ordine del giorno recante le firme di Lerda, Serrati, Musatti e altri. Questo testo non è il più esplicito, ma afferma l'unità di organizzazione sindacale, lo sciopero generale anche come «strumento poderoso della rivoluzione sociale, da adoperarsi soltanto quando lo richiedano gravi necessità», afferma l'intransigenza elettorale con eccezioni nei ballottaggi, e nega l'autonomia del Gruppo parlamentare e l'appoggio ai governi. Dalle votazioni per la Direzione i rivoluzionari si astennero giustamente, «riconoscendo l'utilità che la frazione vincente debba assumere esclusivamente la responsabilità delle funzioni direttive del Partito».
9. Si delinea la sinistra marxista.
La nostra rassegna di storia del partito socialista in Italia é giunta al congresso di Firenze del 1908, caratterizzato dal fatto che la tendenza riformista ebbe partita vinta sulla «falsa sinistra» dei militanti di scuola soreliana, anche perché questi, senza attendere altro congresso dopo quello di Roma 1906 in cui erano stati battuti, avevano preferito a Ferrara dichiarare che uscivano dal partito senza tuttavia fondame uno proprio, in quanto nella loro dottrina il movimento proletario non aveva bisogno di partito politico, e suo organo erano i sindacati, salvo ad esistere nelle varie località gruppi sindacalisti senza organizzazione centralizzata.
Il dilemma riformismo-sindacalismo che riempiva di sé il principio di questo secolo, e che non doveva resistere alla prima guerra mondiale, non avrebbe più fatto da sfondo ai congressi del partito, ma i riformisti, ossia la destra, ne conservarono il controllo, in quanto a Firenze 1908, contro i loro 26 mila voti (contandovi quelli dell'integralismo, inutile equivoco unitario che non cessa mai di risorgere sempre più pestifero), i rivoluzionari ne ebbero un numero superiore a quello di Roma ma pur sempre esiguo, e, assorbiti dal problema della delimitazione dai sindacalisti e della loro espulsione, non avevano elaborato a loro volta una chiara e solida piattaforma programmatica sul filo del marxismo.
Dal 1906 al 1912 durerà la lotta per battere nel partito i riformisti. Ma con questo non si sarà ancora formata e delineata bene la sinistra marxista cui qui ci richiamiamo nel tracciarne una linea storica riconoscibile nel lungo decorso. La lotta che stiamo per descrivere avrà purtroppo, secondo la maniera convenzionale di stendere le storie, un nome: quello di Mussolini. Siccome noi seguiamo maniera opposta, e anche senza poter ignorare i nomi, almeno dei morti, teniamo a mostrare le derivazioni sociali e collettive, ci permettiamo a questo livello storico 1910 una breve ricapitolazione dello sviluppo del movimento già ricordato in quanto precede.
Per la chiarezza dell'esposizione di un processo storico bisogna seguirne le tappe o le fasi distinguendole con qualche cosa di non tanto misero e banale quanto l'apparire, il vincere o l'essere sopraffatti di uomini coi loro nomi segnati da un alto grado di notorietà, tanto più che a noi preme di porre in evidenza non quello che le fasi hanno di diverso, ma proprio quello che hanno di comune e anche di costante nel tempo; nel che sta la sola ragione per cui a un movimento politico è necessario conoscerle. Un movimento politico è la «fabbrica del futuro» ma la nostra dottrina è che sarebbe vano impiantare questa strana fabbrica ignorando il passato, o solo maledicendolo, e, con la formula che distingue gli stolti di questo tempo borghese, proclamandolo di fase in fase e di tappa in tappa «superato».
Sembra quindi a noi che le tappe o fasi si possano segnare con buona approssimazione e tenendo a freno ogni fantasia inventiva (quando, o signori, verrete a regalarci la fantastoria?), seguendo lungo la non breve vita del movimento di una classe sociale ben stabilita (e per noi del proletariato) le separazioni o, per usare una parola che nel linguaggio comune si direbbe più tecnica, le scissioni tra ali, correnti, tendenze, che, prima unite o perfino confuse, divengono poi distinte e infine nemiche, prendendo vie diverse ed opposte. Un simile corso sarà stato felicemente descritto quando queste correnti, nel loro contenuto di forze reali (quello che più volte piacque chiamare con abuso di retorica le loro anime), saranno state ricondotte a figure costanti nel tempo e non ravvisate di accadimento in accadimento come novità o sorprese o parole nuove. In fondo il nostro movimento studia da quasi un secolo e mezzo il processo storico del modo capitalistico, e noi spingiamo il nostro candore fino a dichiarare che in tanto tempo, che scavalca vite di persone e generazioni, la nostra scuola non ha trovato da registrare nelle cronache nessuna sorpresa o novità: è una volta per sempre che abbiamo scoperto che il modo borghese è un modo transitorio, caduco, nemico ad una parte della specie umana, e che da una parte di essa deve venire combattuto ed ucciso. La catena delle scissioni va valutata e tenuta presente con gran cura, ma esse non sono venute perché si sia «scoperto», o peggio «inventato», che l'anima del modo capitalista e il suo ciclo superno ed infernale ricevevano una interpretazione e descrizione nuova rispetto a quella già meritata.
Chiediamo dunque scusa di questa dichiarazione, che ci si rinfaccerà, al solito, dogmatica o talmudica, e che starà in piedi solo se tutta la catena storica degli eventi, anteriori e posteriori al nostro conoscere e annotare, si lascerà incastrare soddisfacentemente nella trama che senza dubbi o incertezze premettiamo al nostro lavoro, che non è di un giudice ma di una parte nella storia. Checché sia di quella cretinata suprema che sono gli autori, è certo che la verifica sarà tanto più utile quanto più a lungo si avrà avuto lo stomaco di subordinarla e legarla allo stesso presupposto di metodo.
Da quando fu in maniera più o meno chiara ed evidente che l'inquadratura del movimento storico della classe proletaria si traccia nell'ambiente e nell'azione della classe stessa, ossia da quando la critica del capitalismo usci dalla fase utopistica, la dottrina fu rivoluzionaria nel senso iniziale che, se una rivoluzione nella società e nelle sue forme tutte aveva fatto vincere gli interessi e le pretese del terzo stato, della classe borghese, una rivoluzione storica avrebbe accompagnato il mutare delle condizioni di vita della classe proletaria.
La prima scissione a cui ci siamo riferiti fu quella della Prima Internazionale dopo la Comune di Parigi del 1871. La scissione da Bakunin e dagli anarchici è solo dagli ignoranti spiegata come il distacco dai violenti ed insurrezionisti di una corrente di socialismo evoluzionista e pacifista tra le classi, che (vivo ancora Carlo Marx) avrebbe abbandonato la dottrina della catastrofe rivoluzionaria, della guerra civile. Le note distintive furono altre, e, secondo queste, la tradizione di sinistra sta dalla parte di Marx, di Engels e del Consiglio Generale.
Circa la questione del centralismo, errore definitivo è quello dei libertari che, ovunque esistano un gruppo di lavoratori e un padrone o un ricco, sia possibile attaccare con l'azione violenta e vincere localmente, mentre la verità storica rivoluzionaria è che questi urti si svolgono all'altezza del centrale ed unico Stato borghese, che con tutto il suo peso tutela il diritto di ogni sfruttamento locale e parziale.
Circa poi la questione dello Stato, l'errore sta nel non intendere come per abbattere lo Stato borghese non solo occorre azione e organizzazione centrale, dunque partito politico, ma occorre prendere e tenere il potere tolto agli sfruttatori (dittatura di classe).
La scissione, che, come sempre, ha una forma momentanea che non sembra investire il fondo del dissenso, fu utile e necessaria. Tra le altre gravi posizioni, solo in apparenza estreme, degli anarchici, vi era quella di negare le leghe economiche per il miglioramento delle condizioni dei salariati. Essa derivava dal pregiudizio che non bisogni associarsi perché ogni organizzazione è una negazione della libertà del socio. Ma questo è vero, ed è perciò che il movimento proletario non ha bandiera di libertà, ma di distruzione della libertà di oppressione dei borghesi, e quindi la rivoluzione che vinca non può che essere autoritaria. Noi ci diciamo autoritari.
Seconda tappa. Passando all'Italia, abbiamo visto che le forze della Prima Internazionale vi seguirono tutte o quasi la scissione di Bakunin, e quindi si svuotarono di ogni forza storica malgrado cruente e coraggiose azioni e lotte. Siamo quindi andati alla scissione di Genova 1892 tra socialisti ed anarchici, mostrando ancora come sarebbe errore porre i socialisti a destra, e ridurre la distinzione alla tattica elettorale e parlamentare che gli anarchici non accettavano. Già nel 1889 si era costituita la Seconda Internazionale sulla base della dottrina marxista e con la guida di Engels.
La questione pratica delle elezioni dominò la scissione, e quindi abbiamo rilevato come non si potesse definire il programma di Genova come un testo della sinistra marxista. Esso affermava la lotta di classe e ne distingueva due campi di applicazione: quello delle leghe economiche di resistenza, che si erano ormai storicamente imposte in tutto il mondo contro le sterili riserve di pochi anarchici detti «antiorganizzatori», e quello della lotta per la conquista dei pubblici poteri. Ma la posizione di Marx per l'elevamento della lotta economica a lotta politica non è certo tutta qui. Il nostro concetto è che la lotta di gruppi locali, di categoria, di azienda o di mestiere è un fatto fisico insopprimibile ed è base dell'azione socialista, ma non è ancora lotta di classe e prova che il proletariato si sia organizzato in classe. Il Manifesto del 1848 aggiunge: e quindi in partito politico; abbiamo poco fa visto che in una mozione sindacalista si diceva: in classe e quindi in sindacati.
Azione solo economica e solo sindacale significa azione che accetti di restare nei confini delle istituzioni politiche del tempo, dello Stato parlamentare e democratico quale fondato dalla borghesia liberale. Il marxismo insegna che, se non si passa al piano politico (che significa rompere i confini statali democratici), la stessa azione economica fallisce e non si può parlare di classe e di classe proletaria. Bisogna dunque salire al partito che pone la questione del potere di classe, che non è la questione delle elezioni e dei pubblici poteri del 1892 o del 1963 (ecco che la linea chiarificata serve a cavallo di settant'anni, per il momento!) ma è la questione marx-leninista della dittatura e della «organizzazione del proletariato in classe dominante».
Se la questione era incompleta storicamente in Italia nei moti di Romagna e del Mezzogiorno, che vagamente tendevano a far vacillare lo Stato nazionale sabaudo del 1860, lo era anche nella formazione del partito socialista italiano. Una spinta a questo veniva dai sani seguaci delle teorie di Marx ed Engels (Bignami) e dal partito rivoluzionario di Romagna (Costa), ma l'altro fattore era una spinta ancora impura, ed era proprio il fattore che veniva dalle famose «masse», con la quale parola non si intendevano più turbe in rivolta, bensì maestranze organizzate e in attesa di miglioramenti economici immediati.
Infatti il partito in Piemonte, in Lombardia, e nel resto del Nord, veniva dal movimento delle mutue (difesa dell'operaio dalla miseria a solo carico dei compagni di lavoro e di sventura) svoltosi poi in leghe di resistenza (difesa dell'operaio nel quantum del salario da chiedere a un capitalismo divenuto più florido, in genere anche a carico di altre miserie nazionali e regionali, o di masse sottoproletarie e pseudo-proletarie), che, divenuto importante, sollevava problemi che il potere pubblico doveva e poteva risolvere. Dato che questo tradizionalmente li risolveva sempre contro il lavoratore, venne la richiesta del partito politico. Ecco come i rivoluzionari d'istinto, come Lazzari giovane, dicevano prima di Genova: Elezioni no, perché a noi non importa il potere. - Era una grossa sciocchezza, ma Lazzari intendeva:- Non importa influire perché il partito al potere sia di destra o di sinistra liberale, di monarchia o di repubblica, tanto lo Stato è lo Stato dei capitalisti. Solo egli non ne deduceva che occorre rovesciarlo e fondare lo Stato dei proletari.
È quindi indiscutibile che la esigenza di una rappresentanza nel parlamento si collegava a quella, sia pure non del tutto esplicita, dì possedere un'influenza sui poteri esecutivi dello Stato in modo che a mano a mano questi potessero almeno in parte favorire le richieste delle organizzazioni proletarie. In ciò era l'origine del partito riformista, perché era facile la conclusione che per raggiungere tali finalità non era indifferente l'eventuale appoggio a un governo parlamentare disposto a prendere talune misure utili al proletariato.
Evitare questo sviluppo in base alla sola norma programmatica che il partito politico si debba ispirare al principio della lotta di classe ed essere indipendente da ogni altro partito, era una debole speranza finché non si dichiarava che la vera azione politica é la lotta per il potere fuori dal parlamento e con la violenza insurrezionale: il che non fu chiaramente detto dalla sinistra del partito tra il 1892 e il 1914. Quindi il socialismo parlamentare, vantandosi a ragione di essere il solo a comprendere le masse, a tenerle attive e a soddisfarne le rivendicazioni economiche, si avviò deciso alla collaborazione parlamentare. La reazione a questo indirizzo tra il 1892 e il 1906 prese la forma sindacalista, ossia sostenne l'azione diretta dei proletari contro la borghesia. Diretta voleva dire senza intermediari, ossia senza deputati, e infine senza partito politico, in quanto «politica» aveva preso a significare «azione solo elettorale». E quindi si giungeva all'errore della tattica locale, periferica, non centrale, che significava concedere alla difesa conservatrice dell'ordine borghese un enorme vantaggio «strategico» votando alla disfatta i conati del proletariato e delle sue organizzazioni sindacali che non rifuggissero dall'azione violenta.
La situazione del proletariato italiano nell'anteguerra fu dunque di sostanziale impotenza. Il partito era dominato dalla destra parlamentare poggiante sulle organizzazioni della maggioritaria Confederazione Generale del Lavoro; la sinistra del partito non vantava un gran seguito, avendo nel gruppo pochi deputati che man mano subivano la forza di attrazione dell'ambiente, e poca influenza nei sindacati, una cui ala distaccata e scissionista era diretta dai sindacalisti libertari ormai in piena rotta col partito e in alleanza con gli anarchici. Con giusta ragione, fra gli operai socialisti il malcontento era grande e il ritorno a una buona chiarezza programmatica difficile e stentato.
10. 1910: Prima riscossa dei marxisti rivoluzionari.
Nel 1909 vi erano state le elezioni generali politiche con notevole successo socialista e della estrema di allora (socialisti, repubblicani e radicali di ispirazione massonica). Ai gabinetti di Giolitti e di Sonnino seguì quello di Luzzatti, che si presentò con programma di estensione del suffragio, di riforme tributarie nel senso progressivo e scolastiche nel senso laico, sfidando la resistenza dei cattolici che Giolitti aveva chiamato alla Camera.
Il gruppo parlamentare si lasciò trascinare da Turati a concedere per tali motivi l'appoggio a Luzzatti contro la destra, e la direzione del partito giustificò la cosa in base alla famigerata autonomia del gruppo parlamentare.
Frattanto saliva il malcontento contro i riformisti di estrema destra che avevano preso coraggio dalla rottura coi sindacalisti anarchici e dalla vittoria al congresso di Firenze. Bissolati, loro capo, era giunto a far propria la tesi di un ex-anarchico, Comunardo Braccialarghe, che riconosceva la necessità della difesa della patria in caso di aggressione straniera, nel qual caso Bissolati aveva addirittura preconizzato l'abbandono del tradizionale voto socialista contro i bilanci militari.
D'altra parte si delineava un'ala della stessa frazione riformista meno proclive a concessioni di principio e rappresentata da Modigliani e da altri, che, sia pure per motivi non radicali, proponeva al partito una maggiore intransigenza politica e parlamentare.
In questa situazione si aprì nell'ottobre 1910 il congresso di Milano, che partì da vivaci dissensi ma non giunse ancora a battere i riformisti.
Una prima battaglia vinta da questi ultimi fu il rifiuto di discutere l'opera passata del Gruppo e della Direzione prima della questione generale di tattica. Essi infatti temevano di essere battuti sul terreno della critica, come doveva avvenire due anni dopo, e di avere miglior gioco (contro un avversario teoricamente incerto) sul terreno dei metodi generali.
L'inversione fu respinta con 12 mila voti contro 6 mila. Le forze numeriche del partito erano in quegli anni in lieve diminuzione. Dal massimo di oltre quarantamila iscritti si era scesi a 32 mila circa.
Nella discussione, il sempre forte Turati si differenziò non solo dai rivoluzionari, che mai la sua ironia risparmiò, ma sia dai riformisti di destra che da quelli di sinistra. Infatti si pronunciò contro il «bloccardismo» che a suo dire era giustificabile solo in caso di offensiva della reazione (da questo il nostro diritto di bollare nell'interguerra come turatiana la politica del blocco antifascista) e più innanzi svolse un altro punto notevole respingendo l'accusa di sostenere una «aristocrazia proletaria» del Nord, avida di legislazione sociale positiva, contro le necessità delle più misere plebi del Sud, per le quali si levava il gruppo di Salvemini ed altri, che dette poi origine al meridionalismo (edizione peggiorata del riformismo, in cui il futuro partito comunista, quando cadrà nelle mani del centrismo, avrà gravissime pecche). Turati non negò che quello fosse un problema non regionale ma socialista, tuttavia fece l'ortodosso rivendicando che il proletariato industriale era l'avanguardia naturale del movimento. Ortodossia vana, di fronte alle posizioni già assunte da Marx ed Engels, e che lo saranno poi da Lenin, di fronte al grasso proletariato inglese.
Salvemini parlò con forza contro il riformismo ufficiale, accusandolo di «socialismo di Stato», e contro i pericoli di corporativismo e protezione di gruppi privilegiati; ma si dichiarò non meno vivacemente contro i rivoluzionari. In questo era coerente, in quanto, nutrito di solidi studi economici, esprimeva la tendenza, che avrà largo influsso sul partito comunista d'oggi, di sottrarre ai rivoluzionari, che pongono come pregiudiziale ai benefici per i lavoratori la caduta dell'ordine capitalistico, la buona conoscenza dei fatti sociali e dei problemi economici; nel che sta la più efficiente e scientifica delle posizioni di controrivoluzione, dal non breve e molteplice sviluppo in Italia dal quale punto di vista si potrebbe redigere un lungo elenco di conservatori progressisti, unendo nomi che al comune osservatore sembrano antitetici, come Nitti o Mussolini.
Restiamo a quel congresso di Milano. Lazzari svolse la critica ben valida dell'azione parlamentare ed extraparlamentare dei riformisti, e in ciò il vecchio rivoluzionario, che poi non ebbe poche pecche, sarà sempre reciso. Si scagliò contro la tendenza a sacrificare all'opera contingente di legislazione sociale gli obiettivi finali e programmatici del partito, denunziò in quella «una specie di sudditanza di fronte al grande apparato dello Stato della classe dominante», bollò come scandaloso il voto per Luzzatti come per ogni ministero, e stigmatizzò la tesi turatiana di una crescente partecipazione del proletariato ai benefici del moderno processo economico, del quale invece esso era «la massima vittima». Oggi Lazzari sarebbe di gran lunga più a sinistra, nella sua leale ingenuità, dei comunisti stile 1963! Reina, riformista di sinistra, svolse la difesa dalle varie accuse. È a questo punto che fa la sua prima apparizione Mussolini.
In «poche dichiarazioni telegrafiche», egli ricorda «a quelli che qui hanno decantato il suffragio universale, che il suffragio universale l'hanno nazioni avanzate come l'Austria e la Germania, e non è detto ancora che attraverso ad esso si debba giungere al socialismo»; a quelli «che hanno decantato la legislazione sociale, che nei paesi dove essa è più intensa, siamo ancora ben lontani dal socialismo: l'Inghilterra informi»; che, «se il proletariato italiano non fosse più rappresentato da deputati al parlamento, il male sarebbe lieve» e infine che «l'affare della patria, questo vecchio cliché della patria in pericolo, è il cliché ideologico di tutte le democrazie borghesi, col quale da 30 anni a questa parte si pompa il sangue della miseria del proletariato». È chiaro che i signori uomini politici non sogliono mai rileggere i loro discorsi ai congressi di vari anni prima!
Parlando a nome dei sinistri romagnoli condannò con efficacia la tregua corsa fra socialisti e repubblicani in Romagna. Quella violenta lotta politica aveva una seria base economica e di classe, in cui è una delle pagine gloriose del socialismo italiano: socialisti e rossi erano i generosi, eroici braccianti, veri e squisiti proletari della terra e militi armati del socialismo, per cui versarono sangue senza risparmio; repubblicani, massoni e gialli, i grassi e sfruttatori mezzadri, cui i comunisti del 1963 fanno la corte. «Non avete capito nulla, disse Mussolini, col vostro concordato; lì si vive in piena rivoluzione!» Non si poteva dire lo stesso nel 1921 della schifosa pacificazione e relativo patto tra repubblicani, socialisti e fascisti? Anche allora la friggente Romagna fu tradita e castrata. Essa ruggiva ancora quando, nel 1914, Mussolini passò alla causa della guerra democratica.
L'ultrariformista Cabrini difese poi i sindacati confederali, la Lega delle Cooperative, la Banca del Lavoro, e tutte le conquiste dovute a quella «dei pubblici poteri» da parte del proletariato della Valle Padana. La sua apologia dei sindacati fu smaccata: la Confederazione del Lavoro fa la vera «politica proletaria» (dando ordini, dicevano allora i rivoluzionari, ai deputati del partito, ed è questo che rendeva vuote di vita le sezioni politiche). Concluse - anticipando il grido degli odierni innovatori - invocando una trasformazione radicale della impalcatura del partito: «O rinnovarsi o perire!».
Perfino più audace di Cabrini fu Bissolati nel porre in punti precisi il programma dei destrissimi di sottomettersi il partito. Autonomia locale nella tattica per le elezioni. Autonomia del gruppo parlamentare di fronte al partito. Libero appoggio a ministeri se il gruppo lo creda. Approvazione di quello passato e futuro al governo Luzzatti col motivo di ottenere il suffragio per altri due milioni di elettori. Infine, in un vicino avvenire, modificazione del partito, il quale divenendo «partito dei lavoratori» deve cedere il campo «alla rappresentanza diretta del proletariato», ossia «trasmissione di poteri» dal partito politico alla Confederazione sindacale: doveva quindi cessare l'organizzazione del partito sulla base di adesioni personali. A dire di Bissolati, questo era vero marxismo perché il proletariato deve interpretare le proprie necessità senza consiglieri, apostoli o interpreti autobrevettati; é ora che «la classe lavoratrice formuli a sé medesima i criteri della propria tattica e trovi in sé quella coscienza politica che ora in noi va rabbuiandosi».
Se noi seguiamo come elemento di giudizio oggettivo il corso storico che nel seguito avrà Bissolati e il suo gruppo, ci è lecito a questo punto stabilire una conclusione sicura, tratta non da «dogmi» ma dalla forza materiale dei fatti e dei rapporti di forze storiche; conclusione che allora traemmo e che un lungo futuro dimostrò giustamente tratta. Nessuna differenza nell'argomentare dei due gruppi, per gli ingenui e i superficiali tra loro opposti, degli immediatisti, ossia di quelli che non vedono tra il proletariato e la rivoluzione la necessaria medianza del partito, organo di opinione che nel senso universale è la sovrastruttura dell'antagonismo di interessi, non in un senso pedestre e pettegolo, o automatistico. Sono i due nefasti gruppi dei sindacalisti libertari e dei riformisti possibilisti e collaboratori con la borghesia, che fanno la stessissima falsaria speculazione demagogica sulla formula marxista che l'emancipazione dei lavoratori deve essere opera dei lavoratori stessi; grandissima verità storica, purché non la castri l'immediatismo.
Da queste vicende traevano i rivoluzionari la loro forza, seppure ancora immaturi. Ricordiamo che Angelica Balabanoff, nel confutare altra asserzione banale di Maria Giudice contro le discussioni e per un lavoro pratico, rivendicò la necessità più che il diritto di affrontare i temi teorici, e si disse solidale con gli intransigenti, a giusta ragione tuttavia rimproverandoli di non sufficiente «coesione teorica».
Anche questa volta vinse il riformismo, ma sotto il nome di Turati, ché i bissolatiani non si vollero contare. Ben 13 mila voti contro 4.557 a Modigliani (intransigenza di massima) e soli 6.000 circa a Lazzari. Ancora una volta l'ordine del giorno è debole e sola parola nuova è il sottolineare la lotta del partito contro le istituzioni economiche e politiche della società borghese, indicate come «religiose, laiche e militari» con riferimento a Chiesa, Massoneria e Militarismo. È un passo che dette utili sviluppi politici, sebbene non fosse basato su vera chiarezza marxista.
L'«Avanti!» passò da Bissolati a Treves, ma i rivoluzionari per bocca di Musatti (deputato di Venezia) si astennero. Fu rinviata la questione massonica.
Di questo congresso vogliamo ricordare che Lerda, il quale doveva poi scusare la sua ostinata appartenenza alla massoneria, ebbe uno spunto felice nel ribattere Cabrini e Bissolati sul laburismo ed operaismo di tipo sindacale. Egli, dopo di essersi levato contro coloro che vogliono «fare del vero socialismo solo facendo delle riforme» e sostengono che «il socialismo è quello che si produce giorno per giorno per la forza delle cose con l'opera e con l'azione parlamentare», disse che la nuova società socialista non poteva sorgere soltanto «dalla forza amorfa e bruta di bisogni ed avidità nuove emergenti da mutate condizioni economiche» ma anche «dalla forza del pensiero che coordina e guida le energie umane e sociali verso nuovi orizzonti». La formula può essere migliore e forse anche lo fu; non si tratta della forza del pensiero contrapposta a quella del bisogno alla scala della persona individua; ma del passaggio dall'appetito materiale che muove il singolo (senza coscienza di pensiero) nella giusta via, alla funzione del partito, anticipazione di una umanità nuova, che possiede dottrina volontà e coscienza; l'originale posizione con cui Marx spezzò l'incantesimo dei millenari enigmi umani, la generosa risposta nostra in tutti i tempi alla falsificazione del sistema grandioso del determinismo dialettico nelle basse dimensioni di un utilitarismo immediatista e borghese.
11. Gli intransigenti prevalgono.
Quello che dette al partito socialista un violento scossone fu un fatto storico d'importanza non solo locale ed italiana ma collegato al corso dell'imperialismo mondiale, e gli effetti furono favorevoli alla posizione che il partito italiano potrà prendere nel 1914. Giolitti, tornato al potere (con audace manovra, egli aveva fatto di tutto per avere Bissolati nel ministero, ma non vi riuscì, e forse il più serio ostacolo si ridusse, nella pacchiana Italia, a una questione di giacca e non frac al Quirinale!), il 29 settembre 1911 dichiarava guerra alla Turchia e la flotta italiana occupava Tripoli. Non è fuori luogo notare che il pretesto fu la vittoria dei Giovani Turchi, accusati di «nazionalismo». Non si dimentichi che quella rivoluzione, popolare e non proletaria, contro il regime feudale turco, fu altamente apprezzata da Lenin.
Il movimento proletario si era fieramente levato contro l'impresa nazionalista di Tripoli, secondo le sue non recenti tradizioni anticoloniali. Lo sciopero generale non ebbe esito completo, ma vivissime furono le dimostrazioni contro la partenza delle truppe. Il gruppo socialista votò un ordine del giorno Turati contro la guerra, ma ne dissentirono i destri de Felice, Bissolati, Bonomi, Cabrini e Podrecca. È da notare che non pochi «sindacalisti rivoluzionari» si dichiararono fautori dell'impresa libica, in prima linea Arturo Labriola, Orano ed Olivetti.
Il congresso straordinario si riunì il 15 ottobre 1911 a Modena sotto l’influenza di questa situazione generale. Bussi, per Treves e per i riformisti di sinistra, deprecò la guerra e sostenne il passaggio alla decisa opposizione a Giolitti, non per questo rinunziando in linea teorica all'antico possibilismo. Lerda ancora una volta (e qui meglio che altrove) ribatté felicemente che, quanto alla prima, non si trattava di una qualunque congiuntura politica, ma dell'origine del fatto bellico dalla essenza del capitalismo e che, quanto al secondo, non ci si poteva fermare ad esso, ma ungeva constatare il fallimento della colpevole illusione di attendersi vantaggi per il proletariato e per il socialismo dallo Stato borghese, e condannare la tendenza a subordinare le finalità ultime del movimento agli interessi immediati della classe operaia espressi nelle sue organizzazioni economiche: «Se vogliamo adattare l'ideale o quella che potrebbe dirsi la dottrina del socialismo, gli atteggiamenti del Partito e quello degli uomini del Partito, alle contingenze della vita degli altri Partiti e all'opportunismo che è necessariamente nella pratica quotidiana, nella lotta per la vita, certo avremo distrutto in noi ogni ragione teorica del socialismo, e certo ha ragione l'on. Bissolati, ed ha anche ragione Armando Bussi, quando considerano l'evoluzione come forza sufficiente per se stessa a regolare l'avvenire sociale». (Come sempre, Lerda e in genere i rivoluzionari intransigenti dell'epoca, acuti nel rilevare e combattere il divorzio fra azione economica e azione politica, fra rivendicazioni minime e programma massimo, peccano poi di insufficienza teorica nel definire la natura di quest'ultimo: esso è «l'ideale, il pensiero, l'anima socialista», alla quale bisogna «educare» le masse proteggendole contro il pericolo cooperativistico; il riflesso pratico di questa insufficienza teorica apparirà in piena luce durante la guerra, quando si «salverà l'anima» del socialismo, ma non si brandirà il programma come strumento di attacco alla società capitalistica e alla sua manifestazione estrema: l’imperialismo).
Per i rivoluzionari anche Francesco Ciccotti sostenne che l'opposizione alla guerra di Libia doveva basarsi non su motivi contingenti come le spese deviate dall'opera di riforme, ma sui principi internazionalisti. Turati parlò pure abilmente contro Tripoli. Lazzari con ragione disse che non era contento neppure dell'ordine del giorno (Lerda) della sua frazione. Questo, molto breve, diceva che dall'azione parlamentare possono conseguire certi vantaggi, ma essi mantengono tra gli sfruttati l'illusione che si possano rinnovare gli istituti sociali per via parlamentare. Chiudeva però col solito debole accenno alla sola opera di «educazione ed elevazione» proletaria affidata al partito.
La lotta fu tra ben cinque correnti: riformisti di destra, con 1954 voti; di sinistra, Treves e Turati, 7818; idem Modigliani (senza l'avverbio sistematicamente nel capoverso che vietava al gruppo di sostenere coi propri voti «il Gabinetto attuale»!), 1736; integralisti o centristi di Pescetti, 1073; infine rivoluzionari, 8646. Questi avevano finalmente raggiunto la vittoria relativa, e per essi giustamente il compagno Elia Musatti rinunziò al ballottaggio, di modo che gli organi di partito restarono ai riformisti turatiani. (Purtroppo i due deputati di sinistra Musatti ed Agnini nel dopoguerra soggiacquero all'influenza morale di Turati e Treves). Ieri eravamo, disse Musatti, la minoranza della minoranza, oggi possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti con la nostra lotta contro il «ministerialismo» e il ministeriabilismo»!
Il 23 febbraio del 1912 tutto il Gruppo socialista, ma con ben diversa intonazione nei discorsi di Turati e Bissolati, vota contro l'annessione della Libia al Regno d'Italia. In quest'occasione si liquida finalmente il gran pagliaccio Enrico Ferri, che aveva votato a favore. Già nelle piazze lo avevamo fischiato via.
Ma il 14 maggio vi fu altro evento, sia pure non di peso storico. Il muratore Antonio d'Alba sparò contro il Re. Tutti andarono al Quirinale su proposta del repubblicano Pantano, e dei socialisti ruppero la disciplina del gruppo Bonomi, Bissolati e Cabrini. Scoppiò l’indignazione nel partito; Mussolini, che al tempo di Modena era in carcere per le azioni antibelliche, sulla «Lotta di Classe» di Forlì, che insieme al settimanale nazionale «La Soffitta» ed altri giornali locali era coi rivoluzionari, a gran voce chiese l'espulsione dei tre al congresso previsto per il 7-10 luglio 1912 a Reggio Emilia.
In questo congresso ebbero importanza le riunioni della frazione intransigente rivoluzionaria, in cui gli elementi più giovani presero posizioni di avanguardia che hanno relazione con gli sviluppi ulteriori di un'effettiva sinistra. Questa volta fu subito imposta la discussione sugli errori della Direzione e del Gruppo parlamentare. Infatti, il processo di elaborazione programmatica non è che una conseguenza ritardata della battaglia contro le degenerazioni dell'opportunismo e della condanna risoluta delle tattiche disfattiste. La sinistra del partito italiano elaborò in questo campo una ben felice e particolare esperienza nel vivo di tali lotte, e qui ne vogliamo lumeggiare le tappe tra il 1912 e il 1919.
Lazzari fu molto deciso nel chiedere la condanna degli organi centrali del partito, che Modigliani debolmente difese, attaccandone la destra. Serrati deprecò che le agitazioni contro la guerra fossero state subite piuttosto che dirette e guidate dal Partito; disse che anche di fronte allo sciopero generale la Direzione si era «dimostrata fredda, incerta e titubante e aveva dovuto aspettare che la Confederazione del Lavoro la richiamasse al dovere», mentre la propaganda antibellicista «non era stata ispirata a criteri generali né fatta in modo preciso ed uniforme ma saltuariamente».
Vi fu poi il famoso discorso Mussolini, ben sostenuto dalle energiche richieste venute fuori nelle lunghe sedute notturne di frazione, che fecero tacere molti degli esitanti. Finalmente fu condannata in tutte lettere ogni autonomia del gruppo parlamentare del partito. Mussolini svolse una vivace critica del parlamentarismo e della sopravalutazione del suffragio universale offerto da Giolitti in contropartita all'impresa libica («il sacco di ossigeno che prolunga la vita dell'agonizzante»); proclamò che l'uso di quest'ultimo deve soltanto «dimostrare al proletariato che neanche quella è l'arma che gli basta per conquistare la sua emancipazione totale», e disse senza ambagi ch'era tempo di «celebrare solennemente con un atto di sincerità quella scissione che si è ormai compiuta nelle cose e negli uomini».
Ma il suo forte non furono mai le costruzioni teoriche bensì le posizioni di battaglia. Si scagliò contro la visita al Quirinale: noi non siamo per l'attentato personale, ma gli infortuni dei re sono gli attentati, come le cadute dai ponti quelli dei muratori (d'Alba era muratore). Lesse infine tra applausi frenetici la mozione che espelleva dal partito Bissolati, Bonomi e Cabrini, ma nella fretta scordò una parte delle decisioni di frazione della notte: fu necessario gridargli: e Podrecca? e allora afferrò il lapis e scrisse sul foglietto che tendeva al presidente: «la stessa misura colpisce il deputato Podrecca per i suoi atteggiamenti nazionalisti e guerrafondai», sollevando tra lo sbigottimento dei destri e dei centristi alte acclamazioni.
Un'altra frase famosa fu quella, che ben si attagliò al Mussolini futuro: «il partito non è una vetrina per gli uomini illustri!» Morale, diremmo: le verità non sono tali per virtù di chi le afferma, ma per virtù propria...
Cabrini tentò di parlare e il congresso gli cantò la Marcia Reale. Bonomi, altro oratore di forza, tentò pure la difesa: Noi, disse, non vogliamo più rovesciare lo Stato, anzi ci siamo riconciliati con esso in quanto ormai «permeabile alle forze del proletariato». Il nostro socialismo riformistico è un fatto concreto: poggia sul movimento dei lavoratori. È poi un movimento nazionale, perché i bisogni del proletariato vanno intesi «d'accordo con i bisogni più ampi della nazione». È infine una «concezione libera ed eclettica del processo politico economico ed etico attraverso il quale si attua il socialismo», e quindi non assegna «alcun binario prestabilito al movimento proletario» (una chiara eco bernsteiniana nell'aggiunta: «dal moto, solo dal moto, esso deve trarre le norme per l'avvenire»). L'oratore profetizzò che, anche senza le loro persone, il riformismo sarebbe risorto nel partito: essi non facevano che svolgere le conclusioni delle premesse turatiane; se quindi espulsione doveva esserci, fosse la definitiva «separazione di due metodi, di due modi di intendere il divenire socialista, talché d'ora innanzi non ci sarà più un solo socialismo italiano, ma un socialismo rivoluzionario e un socialismo riformista».
Non aveva affatto torto! Concreto, popolare, nazionale, forza delle classi lavoratrici nello Stato, nessun binario prestabilito: non pare un discorso di Togliatti in una domenica, elettorale o no, del corrente 1963?
Podrecca si difese bene invocando Antonio Labriola che molti avevano la debolezza di presentare come teorico del marxismo in Italia: Antonio, diciamo (e non Arturo), che in nome di una diffusione mondiale del capitalismo avanzato, base del socialismo, aveva difeso le conquiste coloniali. Altro uomo abile, Podrecca gridò che non avrebbe firmato un articolo dell'«Avanti!» che augurava lo sventolio del tricolore sulle balze trentine. Non siamo in grado di dire se la diabolica allusione volesse colpire Mussolini che aveva lavorato nel Trentino perseguitato dagli austriaci, i quali tra patrioti e socialisti non andavano forse per il sottile: Mussolini, comunque, non disse nulla.
Berenini per i destrissimi dichiarò che questi avrebbero seguito gli espulsi. Reina e Modigliani presentarono ordini del giorno senza la parola espulsione, ma che constatavano essersi i destri messi fuori dal partito. Il voto: Mussolini 12.556, Reina 5.633, Modigliani 3.250, astenuti 2.027.
Lerda presentò il solito ordine del giorno sulla tattica elettorale, che il congresso approvò senza votazione. Esso non era felice, ma la buona dottrina viene dopo le buone azioni, e la buona azione era stata quella di defenestrare i traditori. La formula teorica restava da affinare dopo, non andando bene questa: «il partito socialista non può essere per la sua essenza rivoluzionaria che un partito di agitazione ed educazione, mai un partito di governo».
Ma il partito è proprio l'organo la cui funzione è il governo!
Nelle adunanze di frazione si disputò, ma su altri punti tattici in cui si decise di andare più avanti: intransigenza non solo nelle elezioni politiche e nella attività parlamentare (come nell'ordine del giorno approvato), ma in tutte le elezioni amministrative e nei ballottaggi, ed espulsione dei massoni. Tali punti si dovettero demandare al futuro congresso. Gli «esperti» spiegarono che ogni congresso vive di una sola grande battaglia.
In realtà, la maggioranza che aveva stravinto era a sua volta divisa in due ali. Ne troviamo questa traccia nel libercolo già citato sui Congressi del P.S.I.:
«Seguì una lunga schermaglia provocata dall'accusa fatta ai rivoluzionari da Nino Mazzoni di avere ripiegato dall'ordine del giorno estremamente intransigente preparato da Ciccotti e votato a maggioranza dall'assemblea della frazione, all'ordine dei giorno Lerda che, non affrontando il problema delle elezioni amministrative, era meno intransigente di quello di Modigliani. Parlarono sull'argomento Modigliani, che espresse il proprio compiacimento per il fatto che tra i rivoluzionari una corrente più estrema si fosse arresa all'altra meno intransigente, e Ciccotti e Maffioli che smentirono le affermazioni di Mazzoni». La verità era quella di Mazzoni, e nella riunione di frazione era stato nettamente sostenuto (tra l'altro Serrati disse in aula di essere di tale avviso) che si dovevano evitare i blocchi amministrativi, lavoro speciale dell'influenza massonica.
Fu approvato un ordine del giorno antimassonico di Zibordi ed altri, e respinto un tentativo di scioglimento della Federazione Giovanile, che era stato dai riformisti ventilato per la sua direttiva ultrasinistra. All'«Avanti!» fu designato Bacci, ma poi vi andò Mussolini.
La lunga lotta contro i riformisti si chiudeva con successo. Scrivendo sulla «Pravda» il 28 luglio, Lenin, che seguiva da tempo con vivissimo interesse le vicende interne del partito italiano, annotava:
«Una scissione è cosa grave e dolorosa. Ma qualche volta è necessaria e, in questi casi, ogni debolezza, ogni sentimentalismo... è un delitto. Se per la difesa dell'errore si forma un gruppo che calpesta tutte le decisioni del partito, tutta la disciplina dell'esercito proletario, la scissione è indispensabile. Il Partito Socialista Italiano, allontanando da sé i sindacalisti e i riformisti di destra, ha preso la strada giusta».
Lerda reiterò la sua dichiarazione di dimissioni dal partito. La storia della sinistra non si tesse su nomi di persone: lo stesso ora citato Ciccotti fu, in guerra, un centrista: Lerda, Lazzari, Mussolini, esponenti finora, poi rottami dispersi e talvolta mal ripescati.
12. L'apporto del movimento giovanile
Verso i primi anni del secolo erano sorti numerosi in Italia i circoli di giovani socialisti, che fiancheggiavano l'azione del partito. Essi avevano già formato una federazione nazionale, che nel marzo del 1907 si riunì al suo terzo congresso.
Benché si sostenesse che i giovani non si dovessero occupare delle lotte fra le tendenze, è ben noto che tra essi quelle più vivaci ed estreme raccolgono il massimo delle simpatie. Poiché in quegli anni, per una falsa valutazione illusoria che abbiamo ben chiarita, appariva che nel movimento socialista la punta più audace fosse quella sindacalista, vicina alle posizioni anarchiche, una fitta ala dei giovani si orientò verso il sindacalismo, che in quell'anno, come abbiamo riferito, si scisse dal partito a Ferrara. Altrettanto avvenne fra i giovani, e, forse per la maggior schiettezza di rapporti nel seno di un movimento fresco ed ingenuo, la divisione fu voluta dall'una e dall'altra parte. Della frazione sindacalista si possono ricordare i nomi di Orano e Masotti, poi ben noti come capi del movimento economico di quell'indirizzo, mentre i socialisti erano diretti da Arturo Vella, Morara, Mariscotti, Altobelli (Demos, figlio di Argentina, organizzatrice riformista), ai quali l'Almanacco Socialista 1919 crede di dare il nome di frazione «riformista-integralista». Sappiamo infatti che al 1907 tali erano le denominazioni delle correnti di maggioranza nel partito (come si diceva) adulto, e i rivoluzionari ondeggiavano ancora tra il voto coi sindacalisti e la divisione anche da loro (Ferrara).
L'ordine del giorno non è molto esplicito: esso dice: «I giovani socialisti, considerando le diversità di concezione, di metodo, di dottrina, riguardanti l'antimilitarismo, i rapporti col partito e le organizzazioni economiche, rivelatesi fra le frazioni formatesi al congresso, approvano la divisione dai sindacalisti, da loro stessi proposta».
I giovani socialisti si riunirono a congresso, il primo della nuova Federazione, a Bologna il 25 settembre 1907, e cominciarono a meglio qualificare la loro posizione. Fu ribadito che si poneva «termine all'equivoco, dividendosi dai sindacalisti che hanno programma anarchista», e si fondò la Federazione nazionale giovanile aderente al Partito socialista italiano. Nella unanimità di quel congresso furono adottati alcuni voti di primo orientamento. Sull'antimilitarismo si affermò che si dovesse fare propaganda perché, nei conflitti tra capitale e lavoro, i soldati non eseguissero mai l'ordine di sparare sugli scioperanti, e circa l'azione internazionale ci si richiamò a quella dei partiti socialisti, pur invocando la possibilità di una «simultanea azione» dei soldati dei vari Paesi belligeranti.
Sull'anticlericalismo si fece anche riferimento alla politica del partito, ma non si tacque sul problema religioso, affermando la necessità di «propagandare la gioventù specialmente onde non si renda mancipia e serva alle pratiche religiose». Forma ingenua, ma contenuto reciso.
Sui rapporti con le organizzazioni economiche, si sancì l'obbligo dei giovani socialisti d'essere militanti sindacali, sempre in armonia col partito.
Fu poi votata una mozione programmatica un po' generica, che ribadiva i concetti già accennati.
Il II congresso ebbe luogo a Reggio Emilia nell'agosto 1908. Vanno notate alcune interessanti tesi. Si decide che non si possano ammettere i «democratici cristiani» e si delibera di respingere le domande di «cattolici militanti» invitando il partito a fare altrettanto; primo esempio di anticipazione sul partito ancora retto da elementi di destra. In altro voto si parla di propaganda «socialista, razionalista, antireligiosa». Per l'antimilitarismo, la formulazione migliore è quella sulla necessità di un'«opera preparatoria nel proletariato affinché sia pronto ad impedire le guerre ricorrendo a qualunque mezzo... in conformità ai deliberati del congresso di Stoccarda» del 1907; richiamo tanto più notevole in quanto, al congresso del settembre dello stesso anno, il partito «adulto» non troverà neppure il tempo di discutere di «socialismo e antimilitarismo», e Bacci dovrà quindi ritirare la sua mozione su questo tema, che d'altra parte non faceva cenno dei deliberati di Stoccarda, in cui non solo si chiamava il proletariato alla lotta contro la guerra, ma si legava indissolubilmente quest'ultima alla lotta per l'abbattimento della dominazione capitalistica.
È però da notare in questo congresso che si sente ancora come il riformismo domini il socialismo italiano, anche perché si è a Reggio Emilia ove la organizzazione dei giovani è tanto diffusa, quanto influenzata, a differenza di ogni altra parte d'Italia, dalla tendenza di destra. Vi sono infatti due ordini del giorno sull'indirizzo del giornale «Avanguardia». Quello di destra è del reggiano Bonini, che vuole scolorire e minimizzare il tono degli scritti del giornale, riducendolo alla funzione educativa dei giovani operai ancora immaturi; e questo ordine del giorno prevale con 131 voti di maggioranza. Di sinistra è l'o.d.g. Consani, che sottolinea il carattere politico e di battaglia dell'organo dei giovani. L'abile Arturo Vella, che sente di non avere una sicura maggioranza, propone un'aggiunta sui «rapporti col Partito», nella quale, non contrastando la tesi che il movimento giovanile non vuole essere un nuovo partito, si dice che il pensiero delle giovani reclute di oggi «sarà l'azione del partito di domani».
Già si sapeva che la dirigenza di destra del partito tendeva a liquidare le sezioni giovanili, troppo rivoluzionarie, e ad assorbirle nei quadri «adulti», come piuttosto filisteisticamente si diceva.
Importante è il congresso giovanile del settembre 1910 a Firenze, successivo a quello tenuto nella stessa città dal partito nel settembre 1908, che aveva visto i marxisti rivoluzionari finalmente misurarsi da soli contro il riformismo e l'integralismo, avendo nello stesso tempo saputo svincolarsi da ogni simpatia per il sindacalismo alla Sorel. Mentre solo a Milano nell'ottobre 1910 i rivoluzionari saranno i più forti nel partito, e solo a Modena nel 1911 ne conquisteranno il controllo, i giovani già alla vigilia del congresso «adulto» di Milano mostrano chiaramente la loro tendenza, benché lo si scorga solo in vari passi dei molti deliberati.
L'«Avanguardia» da tempo combatteva la destra riformista, e l’indirizzo ne viene approvato con ben 2.033 voti a Bertieri contro 944 a Consani. L'ordine del giorno vincente dice fra l'altro «che l’«Avanguardia» fu spesso di incitamento e di stimolo efficace al partito, specialmente per indurlo ad una azione più efficace nel campo dell'antimilitarismo e dell'internazionalismo».
Non molto significativo il voto sull'organizzazione e propaganda del destro Demos Altobelli, e non felice un'aggiunta di un brillante compagno, Sole, che vuole che la gioventù «non si esaurisca in polemiche di tendenza».
Buone tesi sono enunciate sull'antimilitarismo: «la concezione borghese di patria altro non è che la giustificazione ufficiale dei delitti e delle nefandezze commesse dal militarismo attraverso la storia dei secoli» - e ancora, sia pure con una certa ingenuità di formulazione: «Intensificare maggiormente la propaganda antimilitarista e antipatriottica nelle famiglie, in modo che queste educhino i loro figli all'amore e non all'odio, in special modo poi tra i futuri coscritti, essendo infame e fratricida il figlio del popolo che spara sul popolo»,- «combattere con tutti i mezzi la propaganda irredentista che cerca spingere ad una guerra due grandi nazioni, e ricorrere a qualunque estremo pur di impedire l'assassinio legale di migliaia di esseri umani» - «far vive pressioni sul partito» per indurre il gruppo parlamentare «ad un'attiva azione per la riduzione delle spese militari e a riaffermare le idealità antipatriottiche ed internazionaliste del partito socialista».
Anche sull'azione anticlericale vi sono affermazioni notevoli. «I giovani, oltre a fare dell'anticlericalismo (che è divenuto una specie di sport per una parte della borghesia) devono compiere una assidua azione antireligiosa» - «il sentimento religioso è un pregiudizio tendente ad asservire le coscienze alla rassegnazione passiva e alla rinuncia del bene nella vita... specie nella donna... » - «l'anticlericalismo dei giovani socialisti deve essere ispirato ai genuini concetti di classe». E, a conclusione, si decide di espellere chiunque compia «pratiche religiose, che sono in aperto contrasto con le idealità finali del socialismo». E si ribadisce il rifiuto dei cristiano-sociali che in quel torno, avversatissimi dalla chiesa, apparivano in Italia. Il voto è teoricamente chiaro, né lo è meno quello sulla massoneria; esso chiede che il partito escluda i massoni, e lo decide senz'altro per le file dei giovani.
Sarebbe interessante dare i voti su giovani socialisti e sport. È respinto l'o.d.g. Sgai che vorrebbe esclusi gli sportivi. Si protesta perché i giornali socialisti danno posto a rubriche sportive. Notevole un testo di Sole: «riconoscendo per altro che il socialismo tende ad infondere nell'animo umano l'amore per la vita, per la bellezza e per il godimento, contro le concezioni religiose che si inspirano alla rinunzia e al desiderio del dissolvimento», invita i circoli giovanili ad organizzare, «con avvedutezza e serietà di propositi, delle feste che, mentre in un giorno di spensieratezza di gioia e di istruzione sollevano lo spirito e lo rinfrancano dalla quotidiana aspra lotta, distolgano i compagni dai comuni divertimenti che fomentano il vizio e pervertiscono l'animo; ringiovaniscono e temprano il corpo, dal cui stato fisico in gran parte prendono forza e vigoria le idee». Una vera felice formulazione del non facile punto.
Un bell'ordine del giorno di Romita contro la istituzione monarchica «deplora il tacito riconoscimento della monarchia di molti compagni», e una non meno felice aggiunta di Consani «dichiara di dividere ogni attività da quella del partito repubblicano, che ha origine e programma eminentemente borghesi, e in recenti occasioni ha fatto opera di divisione e di crumiraggio nel movimento operaio». Poche parole, queste, che stanno a posto nell'archivio della sinistra.
Un onesto o.d.g. sul movimento operaio, di Baldoni, parte dalla esatta premessa «che il movimento economico è la base su cui deve sorgere e svilupparsi il movimento politico, che ne costituisce l'anima, la guida, l'ispiratore, onde i due movimenti si integrano e completano a vicenda». Una buona aggiunta sul diritto di sciopero nei pubblici servizi si basa sull'ovvia tesi «che nella società borghese non si può ritenere che lo Stato rappresenti la collettività».
Chiudiamo con una buona tesi nel voto sulla donna: «il vuoto programma politico delle femministe borghesi non può confondersi col nostro femminismo materiato di interessi economici» e «improntato alle finalità socialiste e all'azione della lotta di classe».
A questo laborioso congresso ne segue uno a Bologna nel settembre 1912, successivo a quello del partito a Reggio Emilia in luglio nel quale i riformisti di destra erano stati espulsi. I giovani sono oramai all'unisono con l'estrema tendenza rivoluzionaria. Nel congresso del partito si era finalmente fatta giustizia della propensione a liquidare l'organizzazione giovanile. In quell'occasione i delegati dei giovani avevano dovuto convincere con una certa fatica qualche sinistro «adulto» ad abbandonare tale ubbia: ricordiamo il passo che si dovette fare presso l'arcigno Serrati.
Siamo però sempre in Emilia e i riformisti, sia pure non dichiarandosi, tentano di battersi contro la sinistra. Passa alla unanimità l'o.d.g. Borni e Rainoni che approva la relazione del C.C. Ma la battaglia si accende sull'«Avanguardia», che aveva sempre apertamente sostenuto la sinistra rivoluzionaria. I sinistri battono con 2730 voti contro ben 2465 l'o.d.g. del torinese Tasca. Quello approvato dice fra l'altro che il movimento giovanile «oltre ad una missione di propaganda e cultura ha anche essenzialmente un carattere politico e di battaglia antiborghese... e di combattimento». Sui rapporti col partito si ha una più netta vittoria nel prendere atto che è caduta «la proposta della passata direzione del partito per l'incameramento (sic) dei circoli giovanili»; 3412 voti contro 1428. Riconfermati i voti antimilitaristi e antimassonici, il congresso non avrà più posto per un altro certame di voti, esercitazione a cui noi da ben mezzo secolo abbiamo tolto ogni valore, anche interno.
Vi sarà però un intenso e vibrante dibattito sul tema che quindi prese il nome rimasto famoso di culturismo e anticulturismo (si vedano i testi 1-2 nella seconda parte).
Fu Tasca a battersi, sostenuto dai reggiani, per la versione culturale del movimento giovanile e anche non giovanile. Queste posizioni del lontano 1912 sono della massima importanza. In esse, Tasca è il precursore del gramscismo od ordinovismo, che si manifestò nel 1919 dopo la guerra e si fece scambiare per una corrente di sinistra mentre era dalla nascita l'opposto.
La battaglia degli anticulturisti, lasciando passare il non molto bell'aggettivo, non fu facile. Essa era l'acme del vero sganciamento in Italia del marxismo materialista dalle seduzioni tremende dell'illuminismo demo-borghese. Converrà, nell'appendice a queste cronache, riportare le due mozioni, e una vivace polemica che seguì nel giornale di Salvemini, l'«Unità». Salvemini era, come si sa, un riformista, e quindi anche lui culturista e problemista, anzi forse il padre spirituale di tutti costoro; ma non era certo... incolto.
Tra gli enunciati di Tasca, sono ora da rilevare questi (che per verità prendiamo dalle conclusioni del relatore Casciani) : «Funzione preparativa... di educazione e cultura, volta allo scopo di... ingentilire ed elevare l'anima e la mente con una istruzione generica letteraria e scientifica... creare competenti organizzatori e buoni produttori (sic) mediante un'opera di elevamento e perfezionamento tecnico professionale, senza il quale non sarà realizzabile la rivoluzione socialista... e curare la iscrizione dei giovani socialisti nelle associazioni di cultura... ».
Opposte le conclusioni del relatore della sinistra; e che non fossero conclusioni occasionali o contingenti risulta da più testi riprodotti nella seconda parte di questo volume.
In sostanza, alla serie: studio, professione di opinione socialista, attività politica, è opposta la serie che davvero risponde al materialismo determinista: inferiorità di classe ed economica, ribellione istintiva, azione violenta, sentimento e fede socialista e, nel partito che affascia i singoli: dottrina cosciente della rivoluzione. Erano le tesi che Lenin, allora a noi ignoto, aveva nel 1903 affermato.
La scuola borghese anche se laica e democratica oggi è cattolica!! è la più potente arma di conservazione - il nostro scopo é opposto ai sistemi di educazione borghesi: creare giovani liberi da ogni forma di pregiudizio, «decisi a lavorare alla trasformazione delle basi economiche della società, pronti a sacrificare nell'azione rivoluzionaria ogni interesse individuale» - respingere ogni «definizione scolastica del nostro movimento e ogni discussione sulla sua cosiddetta funzione tecnica squisito ordinovismo anti-letterali».
E ancora: «l'educazione dei giovani si fa più nell'azione che nello studio regolato da sistemi e norme quasi burocratiche».
La conclusione finale è: evitare l'ambiente borghese, vivere in un ambiente rivoluzionario di classe e di partito, agire e lottare anche nei sindacati per il fine politico delle massime conquiste.
Questo assai notevole dibattito, che anche fra la corrente estrema trovò qualche difficoltà iniziale ad essere rettamente valutato, ebbe grande eco nella stampa del partito, con contributo massimo all'azione per ricondurre il movimento italiano sulla via rivoluzionaria(1).
Ritorneremo sull'influenza dei giovani, della loro federazione e del loro giornale, quando tratteremo del periodo della prima guerra mondiale: influenza che fu fondamentale e forse determinante.
(1) Il lettore troverà nella seconda parte altri contributi notevoli della gioventù socialista alla chiarificazione di importanti questioni di dottrina - posizione di fronte alla cultura borghese, socialismo e anticlericalismo, partito politico e organizzazione economica, questione elettorale, lotta contro l'irredentismo ecc. - in questo periodo 1912-14 (testi 3-14).
13. L'ultimo congresso socialista prima della guerra.
Fu quello di Ancona del 26-29 aprile 1914. Il nuovo atteggiamento del partito e del suo battagliero giornale «Avanti!» aveva trascinato l'adesione più entusiastica del proletariato italiano, che reagiva alle gesta imperialistiche della guerra di Libia con una vivissima attività di classe. Nell'ottobre-novembre 1913 vi furono le elezioni politiche, affrontate con criteri di vigorosa agitazione socialista e non di programma di natura parlamentare. La scissione di Reggio aveva ridotto il gruppo da 33 a 26 deputati, avendo gli altri sette fatto blocco nel partito riformista o «del lavoro» con i quattro espulsi. Ne furono eletti 53, di cui 13 nei ballottaggi, mentre i riformisti tornavano alla Camera in 26; in gran parte del Sud. Napoli era il focolaio di una situazione gravemente opportunista che fu uno dei centri dell'attenzione del congresso e contro la quale si batteva da tempo - come vedremo nel capitolo successivo - l'estrema sinistra, in gran parte formata da giovani.
Lazzari riferì per la Direzione, tra il generale consenso, sostenendo la sua formula tradizionale di un trentennio: l'obiettivo dei socialisti è l'espropriazione economica e politica della classe dominante, ed essi devono in tutte le loro azioni battere in breccia «il regime politico che mantiene l'ordine costituito della proprietà e del capitale». La formula era esatta, ma non conteneva il chiaro sviluppo delle svolte storiche della lotta politica ed economica, ossia l'idea e il programma di fatto della dittatura del proletariato, organo della trasformazione sociale. Mussolini riferì per il quotidiano. Il partito era giunto a 50 mila tessere, e da Reggio l’«Avanti!» aveva triplicato la tiratura.
Già nel dibattito sulle relazioni i napoletani si scontrarono, e la sinistra svolse il suo concetto che, essendo lo stato borghese di Roma il nemico centrale da abbattere, il metodo doveva essere unitario, ed anzi più intransigente ove le condizioni della società locale sembravano richiedere una fase ulteriore di sviluppo del liberalismo. Infatti, la massa dei deputati del Sud era la forza di manovra della borghesia italiana in Parlamento, e la posizione non classista del partito nel Sud il maggior pericolo per stroncare l'audacia dei movimenti operai nelle regioni più ricche. Quindi la radicale negazione che nel Mezzogiorno si dovesse seguire uno «speciale» metodo socialista mentre, in tutto il paese, unico era il nemico da travolgere: lo Stato centrale.
Le relazioni furono approvate per acclamazione e la parte che attribuiva i successi del partito al metodo rivoluzionario a grande maggioranza, dopo le critiche, quasi senza eco, di Treves contro il preteso neo-idealismo della corrente di sinistra.
Anche in questo congresso furono importantissime le riunioni della frazione di maggioranza delle quali non si possiedono verbali. La prima cosa decisa fu l'inversione dell'ordine del giorno per discutere subito e finalmente, dopo gli annosi rinvii, la condanna della massoneria. Ciarlantini portò la proposta al Congresso, che approvò. Anche qui si dovette reagire alla debolezza dell'ordine del giorno che era nella coppia di relatori Mussolini-Zibordi, un rivoluzionario (allora) ed un riformista (sempre) di sinistra. Esso conteneva la dichiarazione di incompatibilità, ma vi mancava il meglio, ossia l'invito alle sezioni di espellere i massoni. Nel breve ma lucidissimo discorso su questo tema, Mussolini ricordò: «Il socialismo è un problema di classe. Anzi, è il solo, unico problema di un'unica, sola classe, la classe proletaria. Solo in questo senso Marx ha detto che il socialismo è anche un problema umano: la classe proletaria rappresenta tutta l'umanità e col suo trionfo abolisce le classi. Ma non possiamo confondere il nostro umanitarismo con l'altro umanitarismo elastico, vacuo, illogico, propugnato dalla massoneria». Disse che altro è l'anticlericalismo massonico di tipo razionalista, e altro l'anticlericalismo di classe proprio del partito. Ma, anche questa volta, si scordò del codicillo di frazione: lo si dovette chiamare dai banchi, ed egli lo lesse tra un uragano di applausi e lo stupore del buon Zibordi, che dovette fare buon viso. Infatti, l'ordine del giorno che si fermava all'incompatibilità dottrinale ebbe 2.296 voti e quello rivoluzionario 27.378, mentre 2.185 furono per un ambiguo disinteressamento, e soli 1.819 per la compatibilità. Nonostante lunghissimi anni di intrigo, la lue massonica era stata estirpata. Va detto che da sempre i turatiani puri l'avevano condannata.
Seguì la grande battaglia delle elezioni amministrative. I punti sostenuti dalla sinistra al congresso furono soprattutto due.(1) Anzitutto, le condizioni di arretratezza del Meridione nel processo di differenziazione delle classi sociali non solo non giustificavano una tattica diversa da quella generale del Partito, ma ne imponevano una sola comune a tutto il Partito: se infatti questo «vuole dare opera a rompere la compagine borghese che, avvalendosi dell'incoscienza politica del popolo meridionale, mantiene lo sfruttamento su tutto il proletariato italiano, deve stabilire una tattica unitaria e sforzarsi di inquadrare anche le piccole falangi dell'esercito socialista meridionale entro i confini precisi di un programma di classe».
In secondo luogo, bisognava reagire con la massima vigoria ad una prassi che contrabbandava nel partito, attraverso le elezioni amministrative, la famosa questione morale: «Invertiremmo la nostra propaganda - si gridò dai banchi della sinistra - tuonando contro i soli borghesi ladri o disonesti e facendo dimenticare al proletariato che esso è quotidianamente vittima di un altro furto ben maggiore che non sia quello che si può compiere nelle amministrazioni locali, cioè il continuo furto che la borghesia esercita su di lui sfruttandone il lavoro nei campi e nelle officine... Quando si fa la questione morale, essa assorbe tutte le altre; essa diventa pregiudiziale; essa ci conduce alla solidarietà degli onesti di tutti i partiti e di tutte le classi... Il nostro non è un processo paziente di ricostituzione dell'organismo in disfacimento della società attuale, è un processo di demolizione di tutta l’organizzazione sociale presente».
I meridionali localisti si difesero contro l'attacco con un abile discorso del forte oratore Lucci. Modigliani, abilmente anche lui, si disse ultra-intransigente, ma propose che si ammettessero liste di accordo tra partiti e sindacati confederali. Su questo punto, sebbene brevemente, rispose Serrati, opponendosi «e per l'interesse dell'organizzazione economica e per l'interesse di quella politica», e osservando che, se la tesi di Modigliani era accettata, il partito rischiava di essere «controllato dagli incontrollabili, di dover essere giudicato nel proprio programma... da coloro... che non sono nelle nostre file». Dietro la barba di Modigliani, egli disse di vedere la barba dell'ex-compagno Bonomi, cioè lo spettro del cooperativismo, del partito del lavoro, dell'operaismo.
Oggi sappiamo il bilancio futuro della vita di Serrati, ma è certo che in quell'occasione egli toccò un punto essenziale della vera posizione dei marxisti di sinistra, non sempre a tutti chiara. Un altro cenno se ne trova nel discorso dell'allora sinistro Ciarlantini, capo del sindacato dei maestri, benemerita organizzazione di categoria, che non solo difese la lotta del Comune contro lo Stato capitalistico, ma condannò la formula demagogica e massonica della scuola primaria allo Stato e non al Comune, ribattendo il luogo banale che sono i preti a volere l'autonomia della scuola. Gli opportunisti 1963 confermano che l'errore è ancora vivo: anche qui, tutto da rifare.
A Napoli, ad esempio, vi era stata per il bloccardismo amministrativo una prova sperimentale di fatto (altro che dogmatismi!) nella confluenza nel popolaresco blocco (che nel giugno vinse) di massoni, riformisti di destra e sindacalisti rivoluzionari, tutti fuorusciti dal partito che, da loro sputacchiato, seppe cacciarli via a pedate. La pedata nel sedere al traditore è un fatto fisico che segna il corso storico, ed è inutile deriderla perché «teorica». Altri la assaggiarono dopo, e il cammino della rivoluzione ne fu e ne sarà segnato. Ma una buona regola, che abbiamo tratta da ben più di mezzo secolo di esecuzioni, è che vanno fatte su un deretano vivo, non morto.
Modigliani ebbe 3.214 voti, Mazzoni (per alcune deroghe) 8.584 e Ratti per l'intransigenza assoluta 22.591. Anche per i blocchi amministrativi era la fine.
Queste due battaglie esaurirono le energie del congresso, che aveva altri argomenti da trattare, come l'atteggiamento della Confederazione del Lavoro che, sebbene apparsa sul banco degli accusati nei tre congressi precedenti ed anche in questo, aveva continuato, prima, durante e dopo la guerra libica, ad agire in modo divergente dal partito senza che la direzione, in nome della solita abusata unità, intervenisse a richiamarla all'ordine. La sinistra della frazione intransigente - come risulta dall'organo centrale del Partito e da quello della Federazione giovanile - era ripetutamente insorta contro questo andazzo, e valga per tutti un articolo sull'«Avanti!» dell'agosto 1913 (L'unità proletaria), in cui si ricorda che
«il voto di Reggio Emilia rappresentava non il linciaggio di alcuni uomini, ma la critica ad un metodo incoraggiato e voluto da tutti quelli che hanno dato al proletariato un'anima riformistica e prettamente egoistica... Che i socialisti debbano favorire lo sviluppo e l'ascensione del movimento di resistenza, il quale non può essere florido e robusto se non riunisce nei suoi quadri un numero sempre maggiore di organizzati, nessuno lo pone in dubbio. Ma nel favorire lo sviluppo delle organizzazioni economiche noi socialisti non dobbiamo mai considerarle come finì a se stesse, bensì come mezzi per la propaganda e la futura realizzazione del socialismo. Ecco perché il nostro punto di vista non può coincidere con quello dei dirigenti e degli organizzatori del movimento operaio i quali (anche i sindacalisti del resto) vedono il sindacato come fine ultimo, si preoccupano solo del suo sviluppo e quindi anche della sua conservazione, e non sono disposti a comprometterla in lotte che trascendano gli obiettivi immediati e di categoria».
È un punto che dovrà essere riaffermato con estremo vigore nel dopoguerra, e purtroppo non sarà bastato ancora (vedi 1962-63!).
Soprattutto importante era tuttavia l'argomento dell'antimilitarismo. Nessuno presentì che pochi mesi dopo il tema sarebbe stato non attuale, ma tragico addirittura. Nell'assemblea di frazione i giovani della sinistra fecero notare che i due relatori erano stati poco felicemente scelti dalla direzione: il riformista Treves (certo intellettualmente qualificato) e il napoletano Fasulo, un sindacalista bloccardo e filo-massone che, in seguito al voto amministrativo, doveva lasciare il partito. Questo era facile prevederlo, ma non altrettanto facile era sapere che da arrabbiato antilibico si sarebbe svolto in socialpatriota. Cose da poco; ben più grave è che le proteste della frazione fossero versate nel seno di Mussolini, in cui ì giovani vedevano la suprema guida. Non si poté venire ad altra conclusione che il problema della guerra e della patria sarebbe stato trattato in un prossimo congresso, per dargli una figura marxista radicale come si era fatto per gli altri.
Lo stesso ordine del giorno che la Federazione giovanile aggiunse a quello dei due relatori conteneva la condanna dell'imperialismo, ma difettava sulla difesa della patria, accennata male, a proposito dell'abolizione del servizio militare permanente.
Mussolini aveva promesso, e i giovani rossi partivano entusiasti per le lotte che dovevano venire e in realtà non mancarono nelle piazze.
Ma non venne il congresso. Venne la guerra.
1 Cfr. il testo 14 nella seconda parte del presente volume.
14. Le lotte socialiste a Napoli e l'origine della sinistra
Se noi facciamo una storia per congressi, siamo tuttavia convinti che per la rivoluzione comunista occorra qualcosa di più e di meglio dei congressi. Ma, se per lo studio delle esigenze future della rivoluzione è utile trarre conclusioni dalle vicende passate, anche di crisi profonde, noi ben dobbiamo ricordare che nel sottoporre a critica le decisioni di Reggio Emilia e di Ancona, anche in quanto inquadravano i temi allora trattati, eravamo sul filo del nostro compito. Infatti, se è giusto dire che il Partito Socialista Italiano, sezione della Seconda Internazionale, ben seppe con la sua avversione alla sinistra borghese, la sua intransigenza totale nelle elezioni, e la sua rottura con la massoneria e la mania delle «situazioni locali», porsi in una posizione migliore quanto a fedeltà alla dottrina e al metodo marxisti, che non altre sezioni europee dell'Internazionale, ciò non poteva e non doveva bastare, nel primo dopoguerra e nella formazione della Terza Internazionale - come vedremo in tutto il seguito per esagerare tali meriti fino al punto di assolvere la destra riformista d'anteguerra, contro la cui disperata resistenza quei successi furono conseguiti.
Tutto sarà evidente nei capitoli che seguono, e che riferiranno del comportamento del partito socialista italiano durante la guerra 1914-18 e delle lotte che nel suo seno si svolsero, con esito assai migliore che oltr'alpe, ma parimenti col delineare una netta frattura tra la corrente socialdemocratica e la nostra, comunista.
Noi non siamo i soli a scrivere la «storia della sinistra italiana» e delle origini del partito comunista (Livorno 1921). Da tutti gli altri cronisti ci distingue non solo la stretta preoccupazione della verità storica e delle vere testimonianze utili, ma anche il metodo. Il nostro (e non lo ripeteremo mai abbastanza) non si fonda su persone e su nomi più o meno noti alla voce popolare o di frequente ricorso nella «letteratura», che in argomento negli ultimi anni si è resa più fitta e forse meno falsaria. Anche quando di persone e nomi dobbiamo far uso per indicare errori, cattive impostazioni teoriche, ed anche episodi e manovre stigmatizzabili, dai quali si deriva la «teoria dell'opportunismo» (che allo svolto 1914 trova altra ondata di materiale clamoroso), a noi non interessano le colpe dei singoli, ma le cause storiche sociali.
Non poteva mancare, circa la storia delle origini della frazione di sinistra nel socialismo e nel comunismo in Italia, una serie di luoghi comuni. A quelli che si pascono di nomi di persone, di conflitti di gruppi o, peggio, di capigruppo e teste o cervelli del partito, non dedicheremo neppure un rigo, e nessuno spazio sciuperemo per arricchire l'aneddotica relativa ai grandi personaggi e ai nomi famosi, non si tema! Potremo contribuire a una sola aneddotica, e nemmeno questa per finì stuzzicanti la curiosità del lettore: quella delle fesserie e dei fessi, per lo più morti, e morti tali.
Ma non potremo tacere di quei luoghi comuni sulla sinistra trattata come leggenda, che pur nella loro insulsaggine si paludano di teoria e qualche volta hanno formula geografica.
La sinistra, e specie quella che, a parte la titolarità del brevetto che, a dir dei minchioni, potrebbe rivendicare chi la inventò, fu la frazione comunista «astensionista» (poi, si sa bene, battutissima sul terreno organizzativo e politico, ma, piaccia o non piaccia, non rimangiata mai dal suo gruppo di origine, vivo tutt’ora), la sinistra nacque nel mezzogiorno d'Italia e a Napoli. E qui gli specialisti dei luoghi comuni hanno gran pascolo: regione e città ove il capitalismo e il proletariato non erano sviluppati (tra le parole dell'ultragoffa moda di oggi, sviluppo è una di quelle che «fanno faville») e quindi non vi poteva allignare che una teoria deforme, piccolo-borghese, anarcoide, dai vuoti gesti sparafucilisti e barricadieri: un'espressione di questo rivoluzionarismo verboso sarebbe stata la frazione che nel 1919, anno di vitalità rivoluzionaria fino ad oggi massima, cercò di impedire a Roma e poi a Mosca l'infausto naufragio nella sbornia delle schede.
Questa è, a nostro avviso, una questione giudicata a posteriori, alla grande scala storica che vede il partito italiano e l'Internazionale di Mosca finiti nel disonore e nell'impotenza rivoluzionaria - se non in peggio, in una potente influenza controrivoluzionaria. E il trascorrere dei tempi renderà questo grave giudizio ancor più palese. Ma al punto in cui siamo, non è male vederla anche a priori, nella situazione del 1914, alla vigilia della prima guerra, e quando al congresso di Ancona il vivace gruppo dei marxisti rivoluzionari napoletani traeva le conclusioni della lunga e violenta battaglia contro le supermanifestazioni dell'ignominia elettoralistica, che ha una storia di infamie ovunque e sempre, ma ha visto un apice della sua infetta patologia proprio a Napoli e nel primo novecento.
Ci fermeremo quindi a dare uno sguardo a questa cronistoria, sulla traccia di un opuscolo 1921 del Partito allora nato a Livorno, e che partiva da analogo testo del 1914 presentato al congresso di Ancona dal «Circolo Socialista Rivoluzionario Carlo Marx» di Napoli, che aveva per vari anni lottato fuori dal P.S.I. solo perché questo riconosceva a Napoli una sezione da esso ritenuta non socialista, e che in quella occasione chiuse la sua violenta campagna contro i falsificatori del nome del partito e del programma socialista, da esso invece pienamente accettato e difeso.(1)
È dunque un rapporto di fatti e di forze obiettive e materiali che lega in passi ulteriori la reazione alle antiche forme piccolo-borghesi del moto proletario, e la difesa dei valori nazionali ed internazionali del socialismo quali erano nel quadro storico di quel tempo, con la richiesta che tutto il Movimento mondiale si liberasse, dopo la guerra che sarebbe venuta, da ulteriori scorie antirivoluzionarie e prendesse la via, purtroppo nel dopoguerra e dopo la seconda guerra malamente spezzata, di rettifiche e drastiche selezioni ulteriori.
In Italia, dopo il 1860 e con l'inizio della forma parlamentare uscente appena dalle guerre e rivolte di liberazione nazionale, è chiaro che le prime forze operaie avevano per un certo tempo sostenuto la sinistra borghese liberale e radical-democratica, cominciando in parte ad appoggiarsi al partito repubblicano per il suo contenuto anti-istituzionale. Si andava verso le basi della cosiddetta estrema sinistra dei decenni seguenti, di chiara posizione anticlericale. I cattolici, come è noto, per volere papale disconoscevano il nuovo potere di Roma e boicottavano le elezioni politiche, ma non quelle amministrative dove bloccavano con la destra borghese (clerico-moderati).
Napoli e il Mezzogiorno in genere, a parte i residui borbonici, furono subito utili appoggi del famoso ma non organizzato «grande» partito liberale, forma letteraria più che politica, e rifugio delle forze delle classi medie e della intellighenzia. Se in Italia vi è da un secolo una peste, è l'intelligenza, che se è fosforescente, lo è tanto da non obliare quando convenga farsi mantenere da Roma e succhiare i deliziosi «soldi do' Govierno». Questi rapporti sociali valgono anche oggi, e sono tanto più fetidi. Ma, se in «Italia di sotto» non è potuta nascere una borghesia in grado di farsi mantenere dal suo proletariato indigeno, questo è un guaio che non si risolve nell'ambito del Meridione, ma è funzione di tutto il decorso dello Stato capitalistico nazionale, e del capitalismo mondiale. Dunque non si risolve nemmeno nell'ambito nazionale. Forse una lotta di classe autoctona sarebbe sorta se fosse rimasto il re Borbone al posto del Sabaudo e della repubblichetta di oggi, mezzo vaticana.
A Napoli fino al 1900 aveva dominato il partito liberale di sinistra, ma verso l'ultimo decennio del secolo scorso, a parte il suo gioco in parlamento, contraddistinto da un permanente «affittasi» (o SI LOCA, alla partenopea), nelle amministrazioni locali esso aveva fatto, come giù si dice, «carne di porco» beffandosi largamente, nel protezionismo delle conventicole e clientele galoppinesche, della legge comune.
Gli oppositori clerico-moderati all'amministrazione comunale di Summonte ebbero facile gioco nel sollevare pregiudizialmente la questione morale! A Napoli esisteva un piccolo movimento proletario e socialista il quale traeva le sue origini dalla prima sezione dell'Internazionale fondata a Napoli da Michele Bakunin nel 1870, con scarse e sporadiche penetrazioni del metodo marxista nel tempo posteriore, tanto che un non disprezzabile gruppo di giovani studiosi delle questioni sociali non tarderà a indirizzarsi, recandovi non trascurabili contributi, verso la dottrina sindacalista di Giorgio Sorel, chiaramente derivata in Francia dal proudhonismo e dal bakuninismo.
Questo gruppo, irrobustito dalle prove offerte dalle masse lavoratrici nei moti del 1898, in cui i poteri di Roma ebbero non poco da fare per mantenere lo stato d'assedio nella Napoli ribelle, fondò un suo combattivo foglio dal titolo ben scelto: «La Propaganda».
Tra il 1898 e il 1900, bersaglio degli strali del giornale socialista fu l'amministrazione liberale, e quindi lo stesso si trovò dalla medesima parte della barricata con i clerico-moderati di cui abbiamo detto, e che allora passavano per «partito degli onesti».
A chi allora fosse all'ABC del marxismo, già doveva sembrare balorda questa scelta tra il partito dei borghesi onesti e quello dei non onesti: eppure, dopo tanti e tanti decenni la formula è oggi ancora agitata e sfruttata dai partiti, che come allora ne fanno moneta di grande successo presso le masse. O sventuratissime masse!
Dato che passeremo subito alla critica del blocco «a sinistra», motivato con lo stessissimo argomento della barbosa questione morale, vogliamo subito dire che il bloccardismo nasce, nella bella Italia del Sud, come milazzismo, ossia come fronte unico da sinistra e da destra contro il centro. Nel 1900 a Napoli il centro era il liberale Summonte, a Palermo anni fa era la non meno abbarbicata al potere democrazia cristiana, e in fondo anche dopo le ultime elezioni 1962 a Napoli probabilmente un poco di neo-milazzismo sarebbe la sola formula di uscita, dato che nessuna delle tre forze può tener da sola l'amministrazione della città, e dato che dal punto di vista morale, locale e tecnico (soliti motivi in chiave di politica municipale) il peggio di tutto è da attendersi da un governo comunale tenuto dal partito del governo centrale di Roma, italica Capitale del superintrallazzo, devastante le città sottosviluppate col maneggio sordido delle sovvenzioni dello Stato, che in forma democratica, o podestarile, o commissariale, emana lo stesso fetore.
Un pezzo grosso del partito di Summonte, Alberto Agnello Casale - per tornare ai nostri napoletani e al nostro svolto di secolo - aveva come avversario nel collegio politico di Avvocata l'allora radicale, poi socialista, Carlo Altobelli, appoggiato dalla «Propaganda». Questa stampò che Casale era un ladro; vi fu querela, processo memorabile, assoluzione. Vittoria dunque del socialismo, sancita dal magistrato dello Stato borghese.
La cosa fece allora colpo immenso, e sullo slancio si svolsero le elezioni amministrative del 1902 da cui fu abbattuta l'amministrazione liberale e massonica Casale-Summonte, che Giolitti da Roma aveva già deciso di giustiziare, disponendo la celebre inchiesta condotta dal funzionario integerrimo Saredo, vero piemontese superpignolo che mise alla luce miriadi di sgarri. Dalle elezioni 1902 uscì vittoriosa la maggioranza clerico-moderata, con una forte minoranza socialista.
Ma da questo momento il «partito degli onesti» cambia posizione geografica, e la sentina della corruzione diviene la nuova amministrazione clericale di Del Carretto, Rodinò ed altri. La posizione di minoranza è scomoda per tutto quello che non sia la pratica delle virtù civica e il rispetto del codice penale, e si comincia ad agitare la nuova finalità della conquista della maggioranza nel Comune, cosa che non si sarebbe mai potuta fare con le sole forze del partito socialista. Scontata dunque la vittoria del blocco antiliberale, si comincia a pianificare la costruzione di un nuovo blocco, questa volta anticlericale, in cui alle forze socialiste si sarebbero dovute aggiungere quelle di altri partiti di estrema sinistra. Ma questi erano i radicali e i repubblicani, pochini anche a Napoli, e l'edificio bloccardo si dovette erigere su ben più larghe fondazioni.
Il documentato opuscolo dei comunisti di sinistra mostra chiaramente quali furono queste basi: prima la Massoneria, che tendeva tutta la rete e primeggiava nelle manovre del suo lavoro sotterraneo ed infido, soprattutto corrompendo con promesse di rapida carriera i giovani cui garantiva una misteriosa protezione; poi il governo Giolitti, che, nella completa e nota assenza di principi, trescava in molte zone coi cattolici (e infine li ripescò col celebre patto Gentiloni del 1913), ma in altre, come a Napoli, favoriva il gioco dei blocchi anticlericali.
Qui cade acconcio confrontare le tappe della costituzione del blocco, che a Napoli, dopo le elezioni del 1910, doveva prendere la forma inaudita di blocco permanente, con le vicende delle questioni di tendenza di cui abbiamo dato la storia per il movimento socialista nazionale di quei medesimi anni.
A Ferrara nel 1907, come sappiamo, i sindacalisti escono dal partito socialista. Quasi tutta la sezione di Napoli li segue, e si costituisce in gruppo sindacalista, conservando il giornale «La Propaganda» e la Borsa del Lavoro (chiamata Borsa e non Camera, all'uso dei francesi).
La sezione del partito rimane composta di elementi riformisti. Negli anni precedenti vi erano stati voti per i congressi in senso intransigente, ma i delegati avevano poi violato il mandato votando per la destra; elegante lavoro massonico. Questa sezione era preda sicura del bloccardismo, ma si poteva credere che così non sarebbe stato del «gruppo sindacalista» che per i suoi principi ideologici doveva agire, se non da anti-elezionista, almeno, come allora dicevasi, da «aelezionista». Avviene l'inaudito: Gruppo, Borsa del Lavoro, giornale, entrano a bandiere spiegate nel blocco. V'è un residuo di reazione del capo teorico dei sindacalisti, Arturo Labriola (futuro sindaco bloccardo), che dal congresso di Bologna si scaglia contro quelli che «accodando le organizzazioni operaie ad un popolarissimo equivoco massonico avevano tratto vantaggi e guadagni personali». Seguono lettere ai giornali, annunzio di querele, ma il blocco resta e in non molto tempo attira Labriola. La cronaca sarebbe lunga, e val meglio dire: quanto è facile ben predicare, ma difficile ben razzolare!
Formatosi il blocco permanente con partiti e tipi di ogni risma, i socialisti rivoluzionari, appoggiati dai gruppi di provincia, nel 1912 uscirono dalla sezione, pur dichiarandosi parte del Partito Socialista Italiano e «confidando in una vittoria della frazione intransigente per la definitiva soluzione della quistione» ad opera degli organi direttivi del Partito, e fondarono il già citato «Circolo Socialista Rivoluzionario Carlo Marx».
Ma intanto, avendo detto di Labriola, bisogna dire della guerra di Tripoli. Malgrado la fiera opposizione condotta da tutto il partito, la corrotta sezione di Napoli tollerò che suoi membri consiglieri comunali facessero l'apologia dell'impresa coloniale. Diversa fu la faccenda tra i sindacalisti, anzi opposta: mentre Labriola (con lo stesso maneggio dei teoremi di dottrina) plaudiva alla guerra libica, la «Propaganda» condusse una violenta campagna contro di essa e subì processi clamorosi: attitudine che sarebbe stata lodevole, se non fosse servita ai finì del blocco massonico e ad imbrogliare le acque nelle questioni di organizzazione del partito. I sindacalisti di Napoli infatti si fusero coi socialisti della sezione riformista in una Unione Socialista strettamente legata al blocco e manovrata dai massoni. I sindacalisti della «Propaganda», non meno bloccardi e massoni, dissero che era stato il partito a spingersi a sinistra a Reggio Emilia, e che loro si erano degnati di entrarvi!
Nell'ottobre del 1912 i socialisti napoletani sostengono il massone Salvatore Girardi nel collegio di Montecalvario contro il clericale Marciano, e sconfessano la candidatura, posta dal «Gruppo Marx», di Todeschini. La direzione del Partito eletta a Reggio interviene fiaccamente. Nel 1913 vi fu un'agitazione contro il decreto catenaccio sui dazi di consumo, che doveva essere diretta contro Giolitti e invece fu aggiogata a un blocco peggio che elettorale, in quanto economico e comprendente associazioni borghesi commerciali! In quell'anno vi furono le elezioni generali politiche. Il partito aveva due soli deputati «iscritti», ossia Lucci e Sandulli, che riuscirono; ma non ebbe il coraggio di ripudiare gli «indipendenti» Altobelli, Labriola e Ciccotti che anzi furono dall'«Avanti!» gratificati del titolo di «validi ausiliari napoletani», mentre erano del tutto - e nel 1914 lo provarono – nell’orbita del blocco locale.
La preparazione di quest'ultimo batteva il pieno mentre si andava verso il congresso di Ancona, le cui decisioni per la intransigenza amministrativa e contro i massoni abbiamo già riportate.
Nell'opuscolo del 1921 è anche descritto come si comportarono gruppi di partito e persone singole dopo il voto di Ancona. Ben pochi rimasero nel partito nazionale; i più seguirono la disciplina della sezione o «Unione»!
Si erano interposti altri eventi che trovano luogo nel seguito di questo volume: la guerra del 1914-18 che vide una minoranza di socialisti italiani sia pure numericamente trascurabile passare al social-sciovinismo: poi, dopo la fine della guerra, la divisione tra comunisti e socialdemocratici (tra cui massimalisti) che condusse alla scissione di Livorno ma, nel movimento di Napoli, fin dalla fine del 1918 si manifestò con la corrente astensionista, il cui dissenso vivacissimo con i comunisti «elezionisti» (come il Misiano) determinò una peculiare situazione nelle elezioni politiche del 1919 (partito socialista ancora unito) e del 1921.
Prendiamo dalla nostra fonte solo la storia dei famosi cinque onorevoli partenopei Lucci, Sandulli, Altobelli, Labriola e Ciccotti. Poi andremo oltre, trascurando molti fatterelli per quanto espressivi. Nel 1910 il P.S.I. elegge Misiano e Buozzi. In una lista indipendente è eletto il bloccardo Lucci, peraltro rimasto sempre avverso alla guerra. Il Sandulli finisce in altra lista indipendente «dell'orologio» col Bovio (camaleonte che non abbiamo voluto fare soggetto di storia e che ogni due mesi cambia tessera e finisce fascista). Il Labriola, ultra-interventista nella guerra, forma una lista dell’«Avanguardia». In essa va il preteso neutralista Ciccotti, che nel 1921 passerà direttamente a quella fascista, restando a terra come si dice in quel gergo. Altobelli durante la guerra non ebbe chiara posizione; pochi anni dopo morì.
Se dunque la genesi del partito comunista, che è il tema che ci preme, fu complessa in Italia, lo fu maggiormente a Napoli, specie se la seguiamo in cifre di voti ai congressi, in risultati elettorali, e in vicende di uomini ed esponenti.
Ma, se a noi interessa seguirla, è nella formazione del metodo e del programma rivoluzionario, nazionale e internazionale: aspetto che non è separabile da quello della guerra a fondo contro traditori e opportunisti.
Il movimento di Napoli paté dare un contributo che non si misurerà nemmeno nei tempi posteriori con «successi politici» e con rimorchio vantaggioso di maggioranze di seguaci, ma resterà fondamentale nel campo delle più vitali questioni di metodo del marxismo rivoluzionario. Questo contributo tanto meno lo si misura con l'apparizione di personaggi di rilievo eccezionale, di valenti scrittori, oratori, ed organizzatori, i cui nomi a noi non importano nulla, né nel nostro campo né in quello nemico.
Le gravi deviazioni e sbandamenti del movimento di classe del proletariato poterono essere scoperte e denunziate ed anche flagellate a fondo con risultati di rilievo - anche se l'opportunismo è bestia dura a morire e che a varie ondate risorge dalle ceneri e riesce a riformare una popolarità sciagurata intorno alle sue infami manovre -, perché fu chiaro che non si sarebbe mai trovata una difesa e una garanzia nell'apparente estremismo del metodo libertario del 1870 o in quello sindacalista soreliano del 1907. Queste forme «immediatiste» (che cioè negano l'inevitabile mediazione, tra il proletariato e la vittoria rivoluzionaria, della forma politica di partito, programma, potere e dittatura) sono la vera radice del falso estremismo di sinistra di cui i traditorissimi del tempo 1926-1963 osano trovare la prima origine nella sinistra italiana in seno all'Internazionale di Mosca, e nella corrente (poi frazione) comunista astensionista nata a Napoli nel 1918.
La storia fedele dei fatti viene per contro a dimostrare come la giusta critica rivolta agli anarchici nel 1892 e ai sindacalisti nel 1907, se pure teoricamente non perfetta ancora, salvò il socialismo italiano dal disastro del 1915, e come analogamente la formazione di una sinistra durante la guerra e dopo la guerra, anche rispetto al partito socialista, trovò nei gruppi marxisti di Napoli e di altri luoghi la forza di portarsi sulla stessa linea di dottrina e di storia su cui si trovano gli eventi dell'ottobre russo e le loro dottrine, dette bolscevismo e leninismo.
Queste coincidenze, attentamente diagnosticate in un’analisi storica, perché siano ancora utili domani quando nascerà la lotta contro un carognume di capi e di grandi uomini peggiore di quello che abbiamo presentato nella Napoli d'anteguerra, esigono che non sia data loro l'offesa di nomi e cognomi - nemmeno, soprattutto, ove se ne potessero trovare alcuni che nei fili del racconto non abbiano mai barattato, anche in non brevi vite individue, la teoria i principi e i metodi che tennero a guida dell'azione.
Non può sembrar strano che i nefasti del metodo parlamentare che nel partito italiano provocarono le drastiche sanzioni dei congressi di Reggio Emilia e di Ancona, e che, come vedremo, durante la prima guerra a talune riprese minacciarono di far saltare la buona politica del partito, là dove avevano determinato i fatti più vergognosi trovarono nell'esperienza collettiva dell'ala marxista del partito proletario la disposizione a tagliare quel male rovinoso alla radice, specie nel momento del dopoguerra in cui la storia mostrò di voler porre in Italia, in modo definitivo, l'antitesi tra la via legale e quella violenta verso il potere.
Più ancora importa rilevare che la proposta, che parve troppo spinta, partì da un ambiente in cui aveva mostrato il suo effetto più rovinoso il metodo destrissimo di porre avanti gli interessi locali contingenti e le famigerate questioni morali, e in cui il falso immediatismo di sinistra aveva già fatto bancarotta, mostrando il confluire negli stessi peccati delle derivazioni e tradizioni anarchiche o importazioni sindacaliste.
Il gruppo proletario marxista che constatò gli effetti di questa rovina e si levò contro di essa fu uno dei primi critici storici della fallacia di ogni estremismo paludato di attitudini di sinistra, nelle radici dei cui errori e bestemmie teoriche stette quel dispregio del partito, quel culto delle persone, della loro demagogia e del loro buffonesco gestire, che facilmente avevano e avrebbero ancora in altre lunghe fasi stordito le abbindolate e ingenue «masse», facili a vedere l'uomo dimenticando partiti e programmi e principi.
Val la pena di citare i postulati che, a modo di conclusione, il gruppo socialista rivoluzionario napoletano esponeva, sottoponendo al Congresso di Ancona:
«1) Risoluzione definitiva della situazione del Partito a Napoli, che si può conseguire solo dando mandato alla Direzione del Partito di sciogliere l'Unione Socialista Napoletana, per ricostituirla quindi sulla base del programma e dello statuto del Partito Socialista.
2) Negazione di qualunque autonomia locale nella tattica amministrativa, anche limitatissima, richiesta sotto il pretesto di particolari condizioni locali, e che in realtà andrebbe a sancire il fatto compiuto di tutto un sistema di impegni presi in qualche località antecedentemente al congresso.
3) Recisa affermazione della incompatibilità tra massoneria e socialismo, anche in rapporto al fatto constatato che l'inquinamento massonico ha avvelenato nel suo sorgere, non sterile di vere speranze, il movimento socialista di gran parte del Mezzogiorno».
(1) Ai socialisti d'Italia, il «Carlo Marx» per il Socialismo Meridionale e contro le degenerazioni della Unione Socialista Napoletana, Napoli, aprile 1914.
15. Verso la guerra in Europa
Il congresso di Ancona, XIV del P.S.I., si era chiuso il 29 aprile del 1914 e il partito si preparava a una prova di forza, peraltro del tutto sul terreno legalitario, con le elezioni amministrative del giugno. La decisa intransigenza significava tuttavia che il partito, con liste proprie in tutti i comuni, e dopo la violenta sconfessione dei famigerati blocchi locali, popolari, anticlericali, e con lo sfondo turpe degli intrighi massonici, capolavoro della politica servile della classe media e della intellighenzia, eterno leccapiatti del padrone capitalista, avrebbe misurate le sue forze per una conferma della battaglia del 1913, cui avrebbe dato sapore l'insieme delle posizioni dei congressi, antibelliche, anticoloniali, antidinastiche, avendo tra i suoi avversari anche i rinnegati messi fuori a Reggio Emilia e ad Ancona.
Ma gli eventi della lotta di classe precorsero i tempi della lotta legalitaria. Il 7 giugno 1914, domenica, l'Italia borghese celebrava l'annuale festa dello Statuto. Gli estremisti convocarono una serie di comizi diretti contro il militarismo e contro le famose «compagnie di disciplina» contro le quali da anni battagliava la Federazione giovanile. Ad Ancona la manifestazione si fece alla «Villa Rossa», sede dei repubblicani, che in quella città erano forti, come gli anarchici. Avevano parlato alla folla Nenni, repubblicano, ed Enrico Malatesta, anarchico, con vivace tono antistituzionale. La folla dopo i discorsi defluiva verso il centro quando i carabinieri aprirono il fuoco: tre giovani operai caddero e molti furono feriti. Alla notizia divampò in tutta Italia un'ondata spontanea di indignazione. Prima che le organizzazioni decidessero lo sciopero, già i lavoratori erano nelle piazze, specie nelle Marche e in Romagna. Furono proclamate alcune ingenue repubbliche locali provvisorie (Spello di Perugia). Fra le grandi città si levarono Torino, Milano, Parma, Napoli e Firenze, dove la folla affrontò i conflitti a fuoco senza rinculare. Fu la formidabile «settimana rossa».
A questa aveva in primo luogo contribuito l’«Avanti!». Nel commentare i periodici eccidi proletari che hanno sempre distinta l'Italia democratica (o giovani, non vi era ancora fascismo, come non vi è più oggi, e Mussolini non aveva ancora scavalcato la barricata, ma di regola i fucili del costituzionalismo liberale e bloccardo squarciavano i petti di folle che chiedevano pane) il giornale socialista aveva più volte scritto: Al prossimo eccidio lo sciopero generale nazionale! Dopo le fucilate dalla Villa Rossa il proletariato non ebbe bisogno di disposizioni e di consegne: scese in azione.
Nel maggio la Confederazione Generale del Lavoro aveva tenuto il suo congresso, in cui vinsero ancora i riformisti battuti nel partito (Mazzoni presentò un ordine del giorno antimassonico che fu respinto). Tuttavia, nel giugno i capi della Confederazione, loro malgrado, dovettero proclamare lo sciopero generale nazionale. Ma il 12 giugno, quando già i poteri statali e la borghesia sbigottivano, la C.G.L. rese loro uno dei suoi innumerevoli servigi; ordinò la fine dello sciopero generale. Violentissime polemiche seguirono nel partito a questo tradimento. Si trattava di un moto per eccellenza politico e non economico; solo il partito politico avrebbe dovuto dare il segnale dell'inizio e della fine eventuale, ma le idee non erano chiare, e da ciò una volta di più emerge la necessità della vera teoria rivoluzionaria. Era fresca la tradizione anarchica e sindacalista soreliana, secondo cui il sindacato ha per sua funzione la azione diretta e violenta e il partito quella legale. Il confusionismo degli indirizzi frustrò il generoso coraggio della classe operaia italiana.
Mussolini scrisse il 12 giugno, nel pubblicare il comunicato, che definì «fellone», della Confederazione sindacale, il famoso articolo Tregua d'armi(1). Commentatori o pretesi storiografi socialdemocratici dicono che questo violento articolo difettava di idee teoriche. La critica in parte può anche essere giusta, ma va detto in qual senso.
La posizione generale sollevò entusiasmi senza limiti. La partita tra le classi in lotta non si gioca a schede ma con le armi. Essa non era finita ma solo sospesa; la borghesia avrebbe rivisto in armi davanti a sé il suo avversario storico, e il giornale del partito di classe lo scriveva in tutte lettere, anche se a fianco dei capi sindacali pacifisti aveva giocato la preoccupazione schedaiola della destra del partito, che lamentava: Dopo questi estremi, gli elettori ci abbandoneranno. Non fu invece così, e poco dopo Benito scrisse un altro articolo: Barbarossa, padrone di Milano, quando i socialisti conquistarono il Comune. Scherzi della retorica; Barbarossa è un'immagine teutonica, antinazionale e antitaliana per eccellenza: ben lo ricordammo al loquace messere nelle polemiche di pochi mesi dopo.
Ciò non toglie che, nell'articolo, la contrapposizione tra guerra di Stati e guerra delle classi sia posta senz'ombre: credevate, urla il futuro Duce ai borghesi, che dopo la sacra unità della guerra tripolina scioperi non ne avreste più visti? Eccovi serviti.
I caratteri dello sciopero sono ben ribaditi: aggressivo, non di difesa; e fino a questo punto non è possibile negare all'autore una grande fedeltà all'ideologia marxista, tanto più se pensiamo al lurido fattaccio del mussolinismo di soli cinque (diciamo cinque) mesi dopo, tutto imperniato sul più sgangherato difesismo, della Francia, del «piccolo Belgio», della libertà, della democrazia mondiale!... Questo fatto di formulare giustamente una tesi vitale della dottrina, che possiamo scrivere: Funzione della rivoluzione proletaria è l'attacco e non la difesa, per la quale i petti dei lavoratori dovrebbero incassare piombo nelle varie «resistenze» dirette a salvare i sommi traguardi delle istituzioni capitalistiche; «fellonia» è il truccare l'offensiva da difesa di mentite conquiste storiche, essendo il proletariato in Marx la classe che nulla ha ancora conquistato, alla quale nessuno ha nulla ancora conquistato, e che deve tutto conquistare, come massa d'urto che travolga non solo tutte le precedenti istituzioni e forme storiche, ma soprattutto la più infame, la sua stessa natura di classe e la propria servitù; questo fatto storico, dunque, dell'articolo Tregua d'armi, in relazione all'altro dell'articolo uscito dalla stessa penna in ottobre 1914: «Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante» - titolo tanto contorto quanto il primo era diritto come una spada - prova solo che non basta una volta intuire il marxismo rivoluzionario, ma bisogna avere il fegato di farlo per almeno tre generazioni.
La valutazione del moto della «Settimana rossa» è ancora validissima quando ne pone in rilievo l'estensione e la intensità. Per questa, lo sparafucilismo connaturato all'articolista rileva, con indubbio coraggio, le battaglie a colpi di arma da fuoco, l'assalto ai negozi di armaioli, gli incendi fatti fiammeggiare, «e non già delle gabelle», come nelle rivolte dei piccoli proprietari del Sud; e il grande grido: al Quirinale! al Quirinale! Ma, o messer Benito, potete dirci dalla tomba se il grido significasse: al Quirinale in stiffelius e tuba???
Per l'estensione del moto il commento è anche migliore; da un capo all'altro d'Italia, dalle officine industriali ai villaggi di campagna, dagli operai qualificati ai contadini e ai braccianti, a nessuno secondi; ed è valido questo saluto alla forza di classe del proletariato agrario italiano, che fascisti e antifascisti hanno nella stoffa lavorato insieme a castrare; e speriamo sempre, anche se finora invano, che un giorno quelle fiamme tornino a divampare.
Una rampogna va alla Confederazione Generale del Lavoro per aver decretato «inopinatamente e arbitrariamente, all'insaputa della direzione generale del partito, la cessazione dello sciopero allo scoccare delle sacramentali quarantotto ore», e ai ferrovieri che non scioperarono, il che se fosse avvenuto avrebbe fermato i movimenti delle forze di difesa borghesi. Valida rampogna, quest'ultima, a uno spirito di categoria che li teneva, anarchici o socialisti, nel loro sindacato non confederato a nessuno, facendo il gioco della destra confederale, pompiera e fellona.
Possiamo far grazia del resto dell'articolo, che non ci piacque mai. Il personalismo e l'estetismo vi hanno libero sfogo. Il moto è stato un preludio, anzi «un momento della sinfonia». Quale, l'Eroica? Quale dunque l'Eroe; Io, Benito? La nostra teoria sulla bellezza di questi Eroi è che, sempre che l'Eroe sorge e la massa in lui crede, in breve termine la rivoluzione resta fottuta.
L'articolo chiude con un attacco alla sinistra borghese, un accomunamento di Salandra con Bissolati come «nemici di domani», e la rivendicazione del moto al partito e all'«Avanti!», guastata solo dalla firma all'articolo. L'impegno (questo sì che richiedeva vero coraggio) a profittare della tregua, «breve o lunga non sappiamo», per il lavoro di preparazione del proletariato non doveva, ce lo stanno raccontando i fatti, resistere cinque mesi. Benito e Leonida insieme passarono caporali del regio esercito!
Chiusa la fase della settimana rossa, ebbero luogo le elezioni amministrative, e come abbiamo detto il partito non perdé voti per effetto dell'esperimento del metodo estremo e per la vigorosa repulsa dei voti dei partiti della sinistra popolare. È veramente caratteristico come la stessa interpretazione dei voti del 1914 è data da scrittori dell'opportunismo tipo Seconda Internazionale e da quelli che emanano dall'odierno partito comunista «ufficiale», vecchio corteggiatore di voti da qualunque parte vengano. Dato il metodo dei voti, e se non si ha lo stomaco di dire: Perdiamo tutti i voti e tutti i successi elettorali pur di non metterci in contrasto coi finì politici del partito, non resta che concludere che il voto di un puro proletario vale proprio quanto quello di un feccioso piccolo borghese o anche di un padrone capitalista. La democrazia è il regno antimarxista di quella quantità impotente in eterno a divenire qualità.
I ragionamenti dei citati signori sono davvero balordi. Si vinse a Milano e a Bologna, ma la ragione fu che i nomi dei candidati riformisti (tra essi erano persone che come compagni e come marxisti valevano assai meglio degli scribetti di oggi) avevano attirato molti voti dei ceti medi. La prova per Milano è addirittura spassosa. Il capolista avvocato Maino ebbe 34.876 voti mentre il rivoluzionario Mussolini fu «sconfitto» con 34.523. Dunque solo 353 voti di meno, l'uno per cento delle forze della lista! Non è questa una vittoria del partito del tempo, che otteneva votazioni così compatte e impersonali? Oggi i capoccia hanno milioni di voti, e i Pinco Pallino zero preferenze, perché così ordinano gli ignobili partiti a base di «migliori».
A Torino invece si perse dopo una lotta generosa e memorabile anche in un collegio politico ove non si volle portare Mussolini né Salvemini ma il semplice operaio Bonetto. Ed ecco i commentatori comunisti di oggi (quali ordinovisti, sono gli ultimi che possano capire Torino proletaria e la sua storia) ironizzare sulla vessata «intransigenza» per cui non si capì che a Torino prevalevano i piccoli borghesi e gli operai imborghesiti, o diffamatori del proletariato torinese?). Non vale la pena di perdere un seggio alla Camera e porre un semplice lavoratore (Mario Bonetto) contro il fumoso e odioso nazionalista Bevione?
Anche parlando di Lenin stesso, dovremo dire che era ingenua la sua idea che con lo scendere nelle elezioni si misuri il rapporto delle forze. Lenin è certo l'uomo che sembrò aver la ventura di sollevare sulle fragilissime spalle cento anni di storia portando l'immensa Russia dall'ultimo al primo posto nell'attingere la dittatura proletaria senza aver tollerata quella borghese, ossia a fare per prima quello che «avrebbe dovuto» fare per ultima. Un risultato che fu pagato a caro prezzo, avendo «sottesa» la fase più velenosa e verminosa del potere capitalistico: la piena democrazia parlamentare. La Russia, nell'epopea leninista, tracannò la coppa della libertà borghese nel giro di qualche mese. Vladimiro, colosso della storia, dette il segno che vi si doveva sputare dentro vomitando lo champagne inacidito nei rudi stomaci proletari; e la peste parlamentare non poté allignare.
Quando si trattò di troncarla in quell'Occidente dove aveva allignato fino in fondo e dove i ventri proletari erano stati domati dalla libidine addormentatrice dell'elettoralismo, il grande Lenin, convinto che la catastrofe capitalista in Europa e nel mondo più non potesse essere retroversa, pensò che si potesse sfidare il pericolo - troppo era più facile fare in Europa di ovest e magari in America lo stesso che si era fatto in Russia, giocando la storia di un secolo; e troppo son carogne quelli di oggi che pretendono ch'egli avesse fatto al resto del mondo il regalo di non subire la dittatura rossa disperditrice di assemblee democratiche a calci di fucile.
Marxista colossale, egli però non vide che una causa deterministicamente sicura - se mai ve ne saranno - non va difesa anche davanti a gente di mezza tacca dialettica con argomenti teoricamente non rigorosi, nemmeno per accelerare la presa di occasioni che la storia potrebbe allontanare; e pur di cacciare i rivoluzionari nei parlamenti adoperò anche argomenti a cui non nascondeva di non credere, come quello radicalmente nefasto della conta numerica delle opinioni. Fu fatto un grande sforzo per mostrargli qual'era la potenza storica del parlamentarismo borghese: i suoi occhi avevano tutti gli elementi del quadro, ma egli ritenne che la nostra forza di eversione sarebbe stata maggiore. Anche Trotsky era vissuto nell'Ovest e nemmeno lui vide bene la questione. Si andò nei parlamenti per buttarli di sotto. Sono ancora in piedi, e quelli che ci abbiamo mandati ragionano come se Lenin avesse sancita una norma letterale: Solo quando, contando i voti, avremo provato che la maggioranza è nostra, sarà il caso di pensare al potere! Quindi sono ripiombati in una teoria che è quella dei socialdemocratici classici. E di tutto il vigore che Vladimiro aveva ridato al marxismo, nulla è rimasto saldo. Importa marxisticamente chi ci culpa? No di certo, e non serve a nulla. Ma ci culpa anche lui.
Il nembo della guerra, che si addensava sull'Europa del 1914 all'apice delle contese elettorali, poteva sciogliere il nodo che serrava alla gola la classe operaia mondiale, e dare la parola alle armi, togliendola alle schede. Il tempo fu mancato, e il nodo si è fatto più stretto.
La borghesia che ha preso le armi due volte come Stati, e anche più volte come classe della società, nulla ci ha appreso, e le abbiamo ridato nelle mani il capo del cappio.
(1) Cfr, il testo 15, nella seconda parte.