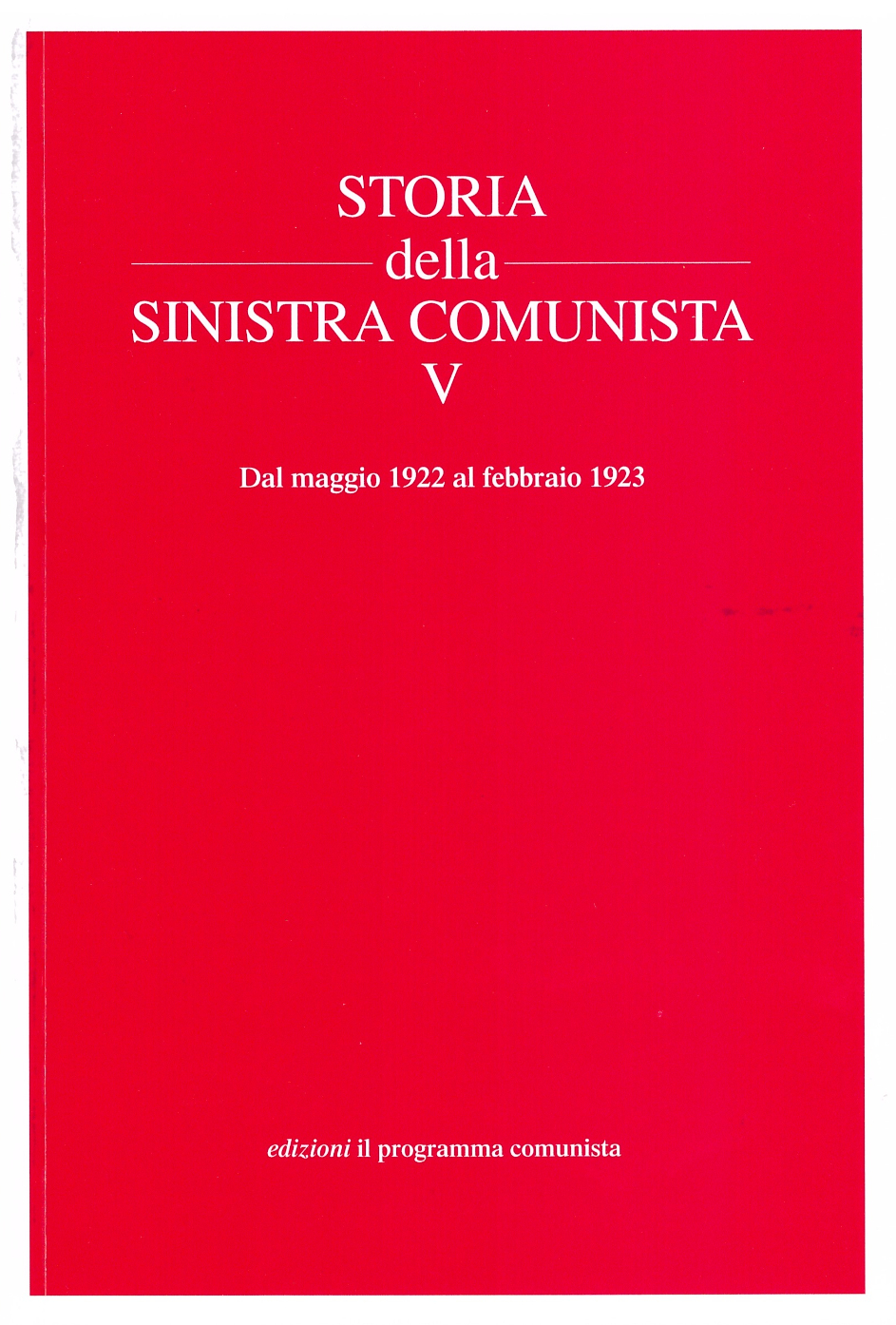"La tremenda guerra italiana del 1915, vero carnaio di cui la seconda guerra, malgrado il tormento delle popolazioni non combattenti, è stata una scialba ripetizione, coi seicentomila morti ufficiali sul campo e le dieci battaglie sull'Isonzo, esasperava l'odio del proletariato per la classe dirigente, che si abbeverò di sangue quando alzava la bandiera democratica assai più che quando poi alzò, con militarismo in sordina, quella nazifascista" (da Storia della sinistra comunista, Vol. I).
A quasi 100 anni dal cataclisma che sconvolse l'Europa dal 1914 al 1918, si annunciano le prime celebrazioni dell'unica guerra "vittoriosa" che la nazione italica può annoverare nel curriculum di "grande potenza" – se si eccettuano quelle riportate contro avversari già moribondi (la Turchia nel 1911-12) o usi ancora a combattere scalzi in guerre tribali, contro i quali i comandi delle eroiche armate dispiegarono il meglio che la fiorente industria bellica era in grado di offrire. Dogali, Amba Alagi e Adua suggerivano di non sottovalutare la capacità dei bellicosi primitivi di dar filo da torcere a eserciti scarsamente motivati e spesso altrettanto poco nutriti, ancorché civilissimi. Se non si era andati troppo per il sottile con i selvaggi di Libia, era allo scopo di non far ammazzare troppi fantaccini coloniali, non per umanità almeno patriottica, ma per non far figuracce internazionali e, soprattutto, non far vacillare governi e ambiziosi piani imperiali. Il governo Giolitti cadde ugualmente. Ma finalmente, nel 1915, questa vocazione imperiale poté manifestarsi col dispiegamento di potenti armate, forti di centinaia di migliaia di uomini: ben più di quanti ne potesse mettere in campo l'odiato impero Austro Ungarico, nemico finalmente degno di tanta Nazione. Si realizzava così la volontà di una minoranza di chiassosi nazionalisti, esigua ma sostenuta dagli interessi di aziende come l'Ansaldo, allettate da profitti patriottici, per le quali importante era fare la guerra, non importa da che parte. Il tempo delle guerre "progressive" si era concluso con la guerra franco-prussiana e con la Comune di Parigi e con l'alleanza antiproletaria tra l'esercito vittorioso e quello sconfitto, ma in Italia si prospettavano ancora code "risorgimentali" per il completamento dell'unità e la liberazione delle "terre irredente". Ogni contendente accampava le sue buone ragioni, di "difesa della Patria" o della democrazia, o di contenimento delle pretese avversarie. Fu, su tutti i fronti, guerra squisitamente imperialista alla cui maturazione diede un grande contributo proprio l'inizialmente neutrale Italia, con il colpo di grazia assestato all'Impero turco nel 1911-12 e la conseguente fibrillazione dei Balcani.
Mentre letterati e poeti cialtroni, al sicuro delle retrovie o nei cieli irraggiungibili dell'aviazione, pontificavano di eroici sacrifici, chi marciava fucile in spalla, ignaro della propria sorte ma già destinato alla macelleria della prima linea, era un esercito di poveracci composto per lo più da contadini che non avevano alcuna cognizione del perché si ritrovassero in divisa, né di dove andassero e a far che cosa. D'altra parte, era meglio che non sapessero gran che di quello che stava accadendo e si limitassero a fare il loro dovere: obbedire. Ci avrebbero pensato i vati e i gazzettieri un tanto al rigo a celebrare la loro morte sul campo, incomparabile ricompensa al sacrificio ed eterna gloria dei discendenti (se mai avevano avuto il tempo di farne). Ben presto, i soldati al fronte compresero che l'alternativa all'obbedienza cieca era il carcere militare o la fucilazione, e dovettero sparare, attaccare, ammazzare e farsi ammazzare. Il grande vantaggio che ne sarebbe derivato al Popolo lo conoscevano i capi, e tanto bastava. Lo conoscevano anche gli intellettuali irredentisti e gli anarco-sindacalisti, ferocemente avversi all'impero carceriere dei popoli slavi, oltre che tirannico e un po' feudale. Vuoi mettere la Democrazia, la Nazione, Il Popolo... il Proletariato, perfino. Finalmente temprato nella fucina del conflitto, l'operaio avrebbe rivolto le armi contro il padrone, o quanto meno sarebbe ritornato alla vita civile più consapevole e forte. Magari avrebbe fatto la Rivoluzione. Queste idee che oggi, dopo due macellerie mondiali e centinaia di scannatoi minori, variamente giustificati, ci appaiono frutto di grossolani sbandamenti (cfr. "Romanzo della guerra santa", su “Battaglia comunista” 1950), ai tempi fecero presa sull'indole attivista di parecchi libertari e rivoluzionari che poco avevano familiarizzato con il marxismo (anche tra quanti, come Gramsci, avrebbero poi militato nelle nostre file). La teoria della guerra di popolo rivoluzionaria, non contro la Germania imperialista, ma contro il Kaiser... feudale sarebbe stata poi propagandata dal rinnegato Mussolini (cfr. "Guerra e rivoluzione", 1950), ma d'altra parte a quel punto anche quelli che passavano per maestri internazionali di marxismo, i socialdemocratici di Germania, avevano calato le braghe davanti all'alternativa tra difendere i princìpi e difendere la Patria in pericolo. Scelta a grande maggioranza la Patria dal fior fiore degli internazionalisti, le porte della Grande Macelleria Mondiale si spalancarono e una massa sterminata di disgraziati vi entrò a far da macellaio e da materia prima. Rimasero solo i socialisti italiani, con i compagni serbi, bulgari, l'inglese Independent Labour Party e i bolscevichi, a non sottoscrivere il fatto compiuto, pur senza aver tutti – con l'eccezione dei russi – la visione, la determinazione e la forza per contrapporvisi efficacemente.
Ora che si stanno aprendo le celebrazioni del centenario ci aspettano i rinnovati piagnistei preteschi per "l'inutile strage", le prediche delle anime belle che considerano la guerra alla stregua di un “errore storico”, frutto della volontà di minoranze e non del convergere di forze storiche talmente potenti da rendere bastevole l'attivismo di pochi per affermarsi; ci aspettiamo, perché no, un ritrovato "sano" nazionalismo, come traspare dalle edificanti rappresentazioni dell'opera dei buoni militari delle "missioni di pace", che non mancherà di esibire bandiere, divise, corpi e generali. Il tutto, ci mancherebbe, in nome della Pace, valore supremo di ogni esercito moderno e democratico. Ci aspettiamo tutto questo, fuorché il riconoscimento del crimine immane perpetrato contro il proletariato ad opera dalle classi dirigenti di allora, civili e militari, servitrici degli interessi di una borghesia avida di profitti e smaniosa di sedersi al consesso delle grandi potenze per spartire il bottino destinato ai vincitori. Ma per farlo a beneficio delle classi dirigenti di oggi, non dissimili da quelle di allora, è necessario riproporre un'immagine completamente falsata, che dietro l'ipocrita celebrazione di un numero così grande di vittime cancelli completamente le responsabilità storiche della borghesia, neghi le crudeltà, l'arroganza criminale dei generali, i massacri insensati, la fame, le fucilazioni, il disfattismo di massa che caratterizzarono quella tragedia. E soprattutto che neghi lo scopo ultimo della guerra, che non fu di abbattere un impero già declinante, ma di irregimentare il proletariato, costringerlo all'obbedienza, piegarlo al sacrificio, ridurne i ranghi che, nel loro pericoloso grandeggiare, minacciavano l'ordine costituito.
Capita di leggere, di questi tempi, su un giornale locale, le cronache fantasiose di un giornalista che, nei panni di un "inviato virtuale", pretende di raccontare il clima che si respirava nelle "terre irredente" allo scoppio del conflitto. A sentir lui, nell'aria il fervore patriottico si tagliava a fette e la morte in battaglia del primo alpino avrebbe suscitato questi pensieri: "sappiamo che questa guerra, per giusta e necessaria che sia, provocherà migliaia di vittime e disastri sociali ed economici. Tuttavia sappiamo anche che non ci sono altri mezzi per avere giustizia e quindi tutti noi siamo disposti al massimo sacrificio per onorare la patria." Tutti noi chi? E di quale "giustizia" si parla? Così poteva forse pensare uno sciagurato irredentista di allora, uno dei pochi che almeno andavano a morire con una convinzione, non certo gli abitanti di Gorizia e Trieste che sotto la protezione dell'Impero se la passavano meglio dei sudditi d'Italia, non gli uomini strappati dalle proprie case, dalle famiglie e dalle occupazioni quotidiane per immolarsi in sacrificio a una Patria assetata di gloria, maschera del Capitale assetato di profitti, col suo contorno di profittatori in carne e ossa. Anche a molti convinti interventisti la sbornia idealista passò ben presto, e rimase, come per tutti, la lotta per la sopravvivenza.
Piuttosto, una testimonianza diretta di cosa provassero davvero i fanti nelle orribili trincee la troviamo nelle migliaia di lettere dal fronte intercettate dalla censura, che frequentemente costavano agli autori il carcere militare con l'accusa di disfattismo o, peggio, di tradimento. Il reato stava nell'aver espresso paura, disgusto, sfinimento, rabbia, disperazione, ben altro dall'immagine convenzionale dell'eroico fante che, ben nutrito, ben vestito e tutto d'un pezzo, affronta la morte circonfuso di un'aura gloriosa. Uno storico di allora, Adolfo Omodeo, riferendosi alle lettere dei disertori italiani raccolte da Leo Spitzer in un lavoro edito in Germania nel 1921, scrisse che "gli entusiasmi e le fedi eroiche, il sereno cosciente sacrifizio non erano cose comuni e volgari neanche nell'esercito combattente e che la grandezza dei migliori consisté proprio nel permeare una materia spesso avversa, nel contrastare e vincere le inerzie, i torpori, le paure che son presenti in ogni esercito come Tersite nel campo Acheo". (1)
Riconosceva così che l'"eroismo" era prerogativa di pochi, e che quei pochi dovettero piegare moltitudini comprensibilmente poco inclini a farsi ammazzare. Si trattava di forzare quella "materia avversa" all'eroismo, fine al cui raggiungimento più che la frase patriottica contribuiva la certezza di punizioni "esemplari". Molte delle medaglie più ambite furono riservate agli ufficiali che si distinsero in questo compito con le decimazioni e le esecuzioni sommarie. Quanto al valore storico di quelle corrispondenze destinate ai propri cari o ad amici, il giudizio dello storico Omodeo è tranciante: "Nulla di più insignificante di quelle lettere: attestano soltanto il più banale istinto di conservazione: nulla hanno da dire allo storico. E se possedessimo tutti i diari degli imboscati, non ci direbbero nulla, perché nulla storicamente esso han creato."
Per noi materialisti, all'opposto, proprio la capacità di garantire la conservazione e la riproduzione della specie misura l'adeguatezza di una data formazione storico-sociale ai suoi compiti storici, finché l'avvento della società di specie, riportando in equilibrio il rapporto tra la società umana e la natura, segnerà finalmente, con la fine della scarsità e dello spreco, la fine della preistoria umana. Dunque, "il più banale istinto di conservazione" è primario fattore storico. La guerra moderna, per come si è manifestata a partire dal primo conflitto mondiale, attesta invece che gli scopi del Capitale divergono dagli interessi della specie e la conducono alla catastrofe; essa fu nello stesso tempo fonte di enormi privazioni e dissipazione di materiali, di mezzi e soprattutto di esseri umani. Se allo storico che applica alla guerra una lettura distorta da idealità patriottiche le lettere appaiono prive di significato, per noi non vi potrebbero essere testimonianze più obiettive, con la loro spontaneità ed immediatezza, nel rappresentare la verità della guerra. Per ironia della storia, siamo oggi a conoscenza di quelle testimonianze grazie agli sforzi della repressione che in ogni modo tentava di celare la verità sul conflitto e di perseguire ogni manifestazione di disfattismo. La censura militare intercettava le lettere dal fronte e le trasformava in altrettante prove contro il mittente, reo di intenti denigratori dell'esercito o della volontà di diffondere il seme del disfattismo nelle retrovie. Una semplice lettera indirizzata alla moglie, ai genitori, dalla quale trapelasse sconforto, sfiducia per le sorti della guerra, insofferenza verso i comandi, stanchezza per le fatiche della trincea poteva costare all'incauto anni di galera.
Un soldato al padre (luglio 1916): "Altro che i giornali che parlano che i soldati al fronte stanno bene, mangiano e bevono. Vorrei farli provare un giorno o due ai Signori d'Italia che ridono al caffè quando leggono sul giornale Vittorie dei soldati italiani... se provassero, se vedessero un minuto solo le cose che toccano ai poveri soldati, scapperebbero sotto terra..." (un anno di reclusione al mittente).
Un disertore: "Nel momento mi trovo priggioniere, però, non lo sono, senza che mi spieco mi capite per conto della Patria che non ci posso tornare più. Non ci penso per niente, perchè la Patria è da per tutto. Pensando al momento in cui mi trovo, per mè non esistono patrie. La guerra si chiama guerra e chi non scappa lo sotterra..."
Un'altra lettera, giudicata "deprimente", di un sergente (giugno 1918): "Qui la guerra va molto a lungo e non si può sopportare. E' un macello completo del mio plotone... sono rimasti 5 di 42... non so che santo ci ha salvato in questi giorni... Ho capito che qui si tratta di far macellare la povera gente e per questo si fa la guerra... quando è l'ultimo siamo chiamati stupidi pure se si è fatto tanto, chi l'ha capito si è già dato da fare e chi ha voluto la guerra resta a casa sua, oppure imboscato, i poveri stupidi si trovano qui a combattere..."
Un mugnaio ventiquattrenne al fratello (luglio 1918): "Ora ti annuncio che domani parto un'altra volta per andare in trincea e non so di preciso da che parte si vada a finire... Non si vergognano questi puzzolenti dopo venti giorni di combattimento a mandarci di nuovo in trincea. Si dovrebbero anche vergognare. Ma ormai abbiamo ben conosciuto ch'è una guerra di distruzione della carne umana..." (lettere riportate nel libro di Forcella e Monticone, in seguito FM).
Se la maggior parte delle corrispondenze esprimono uno spontaneo rifiuto della guerra e il naturale odio verso i carnefici, altre rivelano una una maggiore consapevolezza della natura di classe della guerra. Così un fante torinese: "Compagni, la morte non mi fa paura, se anche i miei superiori mi dissero che questo è un posto d'onore, il mio sangue vorrò spenderlo per una causa giusta e leale, per far risorgere la vera società di fratellanza e di umanità... ". Un altro soldato pagherà con quattro mesi di reclusione queste frasi indirizzate al padre nel settembre 1916: "chi visse da lungo tempo come me in mezzo a questi soldati in gran parte analfabeti, non esclusi i graduati e i sergenti, e che si levi un po' da essi, comprende in quale grave situazione si trova, a quali canagliate, privazioni, umiliazioni è oggetto e di conseguenza logica diventa un ribelle a questa forma di vita se vita si può chiamare. Immaginati poi se è un sovversivo, quanto gli deve ripugnare questo cumulo di ingiustizie; chè non potendosi ribellare, deve tutto soffocare nel cuore". Dalla lettera di un soldato alla fidanzata (21/7/1916): "Ora per darti l'esempio vedi che i giornali della borghesia hanno la sfacciataggine di pubblicare sopra ai suoi schifosi giornali che il deputato socialista - per modo di dire ma lasciamo andare - di Trento lo hanno fatto prigioniero e quindi lo hanno messo alla forca [si riferisce a Cesare Battisti] . E non hanno fatto il suo dovere! Certo rispetto loro perchè li aveva traditi. Cosa fanno i nostri signori tribunali di guerra ad un povero soldato che si vede innanzi il pericolo della morte e dice io non vado avanti perchè muoio. Viene quindi processato com'è successo qui l'altro ieri che due soldati [...] li hanno fucilati" (FM).
Giustizia militare
L'aspetto fondamentale della "Grande guerra" che solitamente non compare nella storiografia, ma che si può dedurre dagli avvenimenti e dalle cifre, è che prima ancora di essere una guerra tra eserciti fu una guerra interna a ciascun esercito, condotta unilateralmente dai comandi, dall'apparato repressivo e dal sistema politico, per piegare gli uomini alla sua logica assurda e criminale. In questo, la disciplina, le regole gerarchiche, la giustizia militare e civile svolgevano un ruolo fondamentale accanto alla propaganda e all'imbonimento ideologico. Forse in nessun esercito questo aspetto si presentò con tanta evidenza come in quello italiano. I comandi, e Cadorna in particolare, dubitavano dell'affidabilità in combattimento di masse di contadini ignoranti trasformati d'un botto in guerrieri, e si premurarono di allestire un sistema efficace di costrizione all'attacco: chi esitava a lanciarsi nel fitto delle pallottole nemiche, con la quasi certezza di finire falciato, doveva avere la certezza di finire fucilato alla schiena se non si fosse improvvisamente trasformato in un "eroe" intrepido: "Solamente un soldato estremamente coraggioso avrebbe potuto a quel punto cedere fino alla diserzione" (2).
Così, quando un reparto non si dimostrava particolarmente votato al suicidio, doveva solo scegliere tra le pallottole nemiche e la mitraglia alle spalle, tra una morte gloriosa e una marchiata di codardia. Per esempio, il 19 giugno 1916, un reparto della brigata Barletta fu sterminato dalle cannonate italiane: finito in mezzo al fuoco di due contingenti austriaci, era impossibilitato a muoversi; per costringerlo ad attaccare, i “nostri” gli spararono addosso da dietro; come punizione, gli altri uomini del reggimento restarono in trincea, in prima linea, per altri due mesi. Alla vigilia di operazioni di assalto, arrivavano i carabinieri che si mettevano in fila dietro i soldati, armavano le mitragliatrici e gliele puntavano alla schiena. “Sparavano a chi si fosse attardato nei camminamenti, invece di andare all'assalto. C'erano uomini ... che avevano paura di uscir dalle trincee, quando le raffiche degli austriaci sparavano all'impazzata. Tentennavano, cercando di ripararsi, e allora i carabinieri li prendevano e li fucilavano. A volte era lo stesso ufficiale che li ammazzava a rivoltellate" (3).
Dopo i sanguinosi quanto inutili attacchi sull'Isonzo e sul Carso del primo anno di guerra, fallita la prospettiva di un rapido sfondamento delle linee avversarie, quando divenne chiaro che la guerra si sarebbe protratta a lungo con le stesse modalità, il sistema repressivo si rafforzò e si perfezionò, contando soprattutto sulla fedeltà degli ufficiali e sui Regi Carabinieri. Allo scoppio della guerra, era stata attivata la norma del Codice penale che attribuiva attività legiferante all'autorità militare; negli anni che seguirono, con i massacri e la durezza della condizioni di vita, i casi di diserzione assunsero carattere di massa. Nel maggio del 1916, Cadorna diede ampia libertà al comando delle truppe sull'altopiano di Asiago di ricorrere a esecuzioni sommarie contro la “codardia” che minava le capacità di resistenza dell'esercito di fronte alla Strafexpedition e nel novembre una circolare introdusse il criterio del sorteggio in caso di decimazione per indiziati di reati collettivi. Era il riconoscimento che si stavano moltiplicando i casi di insubordinazione e che la propaganda antimilitarista, anche con la diffusione dei proclami di Kienthal e Zimmerwald [NOTA], incontrava crescenti simpatie. Più della propaganda "sovversiva", il fattore decisivo nel diffondersi di sentimenti disfattisti e antimilitaristi fu la spontanea avversione al massacro insensato e alla inumanità dei comandi, di cui fu espressione massima il generale Andrea Graziani, che raggiungeva le truppe sul fronte dell'Isonzo seguito da una pattuglia di carabinieri e ordinava fucilazioni sul posto senza tanti preamboli.
Il 1917 è l'anno in cui si registrano i casi più numerosi di disfattismo e diserzione. Nell'estate, mentre si verificavano manifestazioni contro la guerra in varie città, il comando supremo italiano adottò provvedimenti eccezionali che prevedevano la pena di morte in caso di diserzione di fronte al nemico o il trasferimento in prima linea, anche solo per un ritardo al rientro dalla licenza. Già all'inizio dell'anno tra le truppe si era raggiunto un livello tale di esasperazione da mettere in discussione la tenuta della struttura gerarchica di comando; fenomeni analoghi si stavano verificando tra le truppe francesi e soprattutto tra quelle russe, dove il disfattismo si legava direttamente al processo rivoluzionario in corso nel paese e all'azione dei bolscevichi. In Italia, la tensione si sarebbe manifestata nella “rotta di Caporetto”, con lo sbandamento dell'esercito che non si dissolse completamente solo per l'impossibilità degli austro-ungarici di spingersi oltre il Piave per insufficienza di mezzi e di uomini.
In una lettera al Presidente del Consiglio Boselli nel giugno del 1917, Cadorna lamentava il diffondersi di "teorie antipatriottiche", di "gravi sintomi di indisciplina che hanno richiesto le più energiche misure di repressione perchè il male non dilaghi", e lo informava che "si è perciò dovuto ricorrere a fucilazioni immediate, su vasta scala, e rinunciare alle forme di procedimento penale, perché occorre troncare il male alle sue radici e finché si può sperare di arrivare in tempo", e " alla decimazione dei reparti infetti dal contagio" (4). La lettera si concludeva sollecitando le autorità civili ad adeguare i mezzi di repressione a loro disposizione portandoli al livello dei provvedimenti "estremi" presi dai comandi militari. La risposta non tardò ad arrivare.
Nell'ottobre del 1917, il decreto Sacchi contro il disfattismo adeguò la legislazione civile italiana a quella militare, realizzando così la convergenza delle tendenze repressive dei due poteri. Il rigore si attenuò soltanto, senza cambiare sostanzialmente, col passaggio al nuovo comando Diaz-Badoglio nel 1918. Fino ad allora infatti, i tribunali si erano accaniti soprattutto contro poveri analfabeti, la cui unica colpa era di tenere alla pelle. Per i custodi delle idealità patriottiche, ciò era motivo sufficiente per giudicarli indegni, troppo rozzi per desiderare il sacrificio per la Patria, desiderio riservato solo agli spiriti più nobili e istruiti:
"...il reo dimostra tanta bassezza di sentimenti da doversi considerare indegno di appartenere all'esercito", "individui immeritevoli del nome di italiani" (FM). Ai graduati, nonostante la loro superiore responsabilità di comando, talvolta erano comminate pene inferiori rispetto a quelle riservate ai semplici soldati, anche in presenza delle stesse circostanze e del medesimo reato: in seguito a uno sbandamento "in faccia al nemico" sull'altipiano di Asiago (ottobre 2016), sei soldati furono condannati a morte e i due graduati che li guidavano a 20 anni di reclusione. Fu dunque una giustizia apertamente di classe ed estremamente dura: "Su un totale di 170.000 condanne [inflitte dai tribunali militari], circa 40.000 comportarono pene superiori ai sette anni di reclusione [...] circa 20.000 furono condanne a pene gravissime (circa 4000 a morte e oltre 15.000 all'ergastolo" (5). Delle condanne a morte (superiori per numero a quelle di tutti i paesi belligeranti), ne furono eseguite 750, mentre 3000 furono emesse in contumacia. Le pene inflitte erano talmente sproporzionate rispetto ai reati da costringere il potere politico a concedere sospensioni e amnistie, anche per non sottrarre troppa carne da cannone al fronte. La galera era vissuta dai più come una liberazione...
Spontaneo disfattismo e repressione
Nel corso del conflitto, il disfattismo tra le truppe italiane assunse dimensioni enormi. Le cifre da sole testimoniano che il rifiuto della guerra fu un fenomeno di massa. Nei primi mesi del 1918, il numero dei disertori superava quello dei morti e prigionieri. Le denunce che risultavano a fine guerra (quando, il 2 settembre 1919, fu concessa un'amnistia per i reati militari) per "indisciplina, resa al nemico, mutilazione volontaria, renitenza o diserzione, etc.", ammontavano a 870.000; di queste, 470.000 riguardavano renitenti in cui si comprendevano gli emigrati non rientrati (370.000 stimati) (6).
La giustizia di guerra fu "lo strumento per la repressione e la compressione di ogni atto di intolleranza della guerra che si potesse verificare nella massa dei soldati; arrecò il suo valido e terribile concorso a portare e a tenere al fronte una immensa schiera di uomini; fu pertanto il supporto dell'interventismo" (7) e riuscì a colpire solo una piccola parte, i più esposti o i più sfortunati, tra quanti manifestarono in vari modi l'avversione alla guerra o parteciparono a episodi di resistenza e insubordinazione collettiva.
Una gran parte delle condanne a morte per fucilazione fu pronunciata contro rei di diserzione, la modalità più comune adottata per sottrarsi alla guerra e dunque la più duramente punita. A volte, bastava addormentarsi in un ricovero in zona di guerra per essere accusati di codardia e condannati a morte per fucilazione. Le condanne con l'aggravante del "passaggio al nemico" furono, per ovvi motivi, quasi tutte in contumacia. Le sentenze, gonfie di retorica patriottica, lasciano intendere che anche darsi volontariamente prigionieri richiedeva un bel coraggio ed era tutt'altro che senza rischi:
"Com'essi furono al limite della vicina trincea austriaca - narra una sentenza del 6/12/ 2015, fronte orientale - ignominiosamente si arresero mostrando inermi le braccia, e qualcuno agitando in essa una bianca pezzuola. Appena riavutisi dalla sgominante sorpresa per tanta incredibile nefandezza - perché pareva che i soldati si fossero lanciati arditamente all'attacco del nemico - soldati e graduati del reparto... indignati fecero fuoco contro i traditori; ma questi che il destino non volle rimanessero colpiti dal piombo dei compagni, per poterli bollare col marchio d'infamia d'una condanna penale, riuscirono, vigliaccamente a penetrare, umili e abbietti, nelle file del nemico..." (FM).
Ma la sorte di quanti finivano prigionieri di guerra fu spesso altrettanto tragica. Nei campi di prigionia austriaci, la fame e le malattie mietevano vittime a migliaia, non per la crudeltà dei carcerieri, ma perché in una situazione di crescente scarsità di approvvigionamenti i prigionieri di guerra erano gli ultimi a poter reclamare diritti. L'atteggiamento preso da governo e comandi italiani, particolarmente dopo Caporetto, aggravò notevolmente la condizione dei prigionieri. Contro di loro fu messa in atto una feroce campagna denigratoria che mirava a presentarli indistintamente come una massa di disertori, codardi e traditori che si erano arresi volontariamente al nemico. I trecentomila italiani caduti prigionieri degli austriaci dopo Caporetto furono tutti considerati fautori di uno "sciopero militare" e come tali i soli responsabili della disfatta. Alcune lettere di familiari rivelano come in molti casi i padri fossero indotti a rinnegare i figli, o le mogli i mariti, sotto la pressione della propaganda che li segnava a dito. Pochi mesi dopo Caporetto gli alti comandi disposero il blocco dei viveri inviati dai parenti. L'Italia fu l'unico paese belligerante a non permettere ai propri soldati prigionieri di guerra di ricevere aiuti dalle famiglie e a ostacolare l'operato della Croce Rossa nei campi di prigionia (8). La morte per fame di migliaia di prigionieri fu un ulteriore crimine da addebitare alle classi dirigenti, civili e militari. Anche questo atteggiamento rientrava in una logica funzionale a rafforzare l'azione repressiva tra le truppe: i soldati dovevano sapere che cercare rifugio presso il nemico non sarebbe servito a salvare la pelle. Non restava che farsi massacrare nelle modalità consentite.
L'altro comportamento "disfattista" più frequente, l'autolesionismo, assunse forme le più diverse, sempre più perfezionate e "creative". I tribunali militari si accanivano contro i poveracci che si presentavano con ferite d'arma da fuoco ai piedi, alle mani o in altri punti non vitali, con ustioni e altro. Lo scopo dei processi non era certo quello di appurare con assoluta certezza che il soldato si fosse effettivamente procurato da sé il danno, ma quello di scoraggiare il ricorso a questa via di fuga dalla guerra, punendolo con anni di galera e in qualche caso addirittura con la fucilazione. Spesso il tentativo di sottrarsi al macello procurandosi ferite si diffondeva per imitazione e coinvolgeva gruppi numerosi, come nel caso di 16 condanne a 20 anni per autolesioni volontarie dello stesso tipo nello stesso reparto (FM). Le motivazioni delle sentenze documentano tutta la pignoleria con cui avveniva l'accertamento delle circostanze e delle caratteristiche delle ferite, con il supporto del referto medico. Di fronte a mutilazioni gravi e permanenti, le sentenze dei tribunali a volte manifestano una beffarda e pur sempre contenuta indulgenza: "Nei confronti dei primi tre accusati cui l'insano tentativo oltrepassò certamente il malizioso intendimento e che trovarono già nella completa cecità di entrambi gli occhi giusta e severa punizione del crimine commesso, il collegio reputa poter concedere il beneficio delle attenuanti generiche" (FM). I "ciechi per non morire" si beccarono comunque 8 anni di reclusione militare.
Naturalmente i giudici non si chiedevano cosa potesse spingere un uomo a provocarsi ferite o addirittura menomazioni permanenti, pur di sottrarsi al suo "dovere" di soldato.
Se diserzione e autolesionismo rientravano in un disfattismo individuale finalizzato a portare a casa in qualche modo la pelle, i comportamenti ribelli e indisciplinati di alcuni minacciavano di essere veicoli della diffusione del virus disfattista. A essere condannati alle pene maggiori erano spesso gli elementi più indocili, interpreti di un sentimento collettivo che pochi avevano il coraggio di manifestare:
"Chiaro apparisce che la figura principale del quadro - si riferisce al rifiuto opposto da un gruppo di soldati all'avanzata verso Gorizia nel marzo del 1916 - campeggia l'E.P. autore principale, promotore, istigatore attivo, noto. [...] Egli dové esercitare sugli altri il prestigio di un capo, determinandoli, istigandoli ad agire. Quindi su di lui deve ricadere la massima severità della legge, ed in suo confronto deve essere emessa sentenza di condanna alla pena di morte" (FM).
Condanne come questa si proponevano di scoraggiare intenti e sentimenti che covavano e crescevano tra le truppe. La durezza della repressione era direttamente proporzionale alla minaccia concreta che la situazione sfuggisse di mano ai comandi. Di frequente, il motivo scatenante era il prolungarsi della permanenza in prima linea per mesi e l'assenza di ricambio con nuove truppe. Quando tutti aderivano alla protesta, la repressione poteva accanirsi contro i pochi riconosciuti, a torto o a ragione, come "responsabili".
Alla minaccia della giustizia militare si aggiungevano le punizioni disciplinari, che potevano arrivare al punto di legare i soldati, per un loro sbaglio qualsiasi, ai reticolati, esposti per ore al fuoco nemico. Se accadeva che le truppe sotto attacco si dessero alla fuga, arrivavano immancabili le "punizioni esemplari". Il 26 maggio 1916, in seguito ad uno sbandamento di massa sull'altopiano di Asiago, si verificò la prima decimazione di cui si abbia sicura testimonianza: "Il comando di reggimento (in conformità anche alle superiori disposizioni) per dare un esempio che servisse di ammonimento alla massa, nello intento salutare di impedire che simili fatti si ripetessero compromettendo al sicurezza stessa delle truppe e macchiando il buon nome del glorioso reggimento, faceva passare per le armi un sottotenente, tre sergenti e altri otto militari di truppa, tra gli sbandati". Altri sessantaquattro militari furono sottoposti al giudizio del tribunale di guerra, condannati a due o tre anni di reclusione e poi rimandati al fronte per dar loro l'occasione di "riabilitarsi", "Tanto più che avranno il costante e terribile monito - recita la sentenza - dell'esemplare punizione inflitta ai compagni" (FM).
Anche gli episodi di fraternizzazione erano oggetto di condanne severissime. A un macchinista ventenne bastò aver risposto "Anche noi vogliamo la pace!" al grido "Pace!" proveniente dalla linea nemica, per meritarsi un anno di galera (dicembre 1916, altopiano di Asiago). Nello stesso periodo e nello stesso luogo, sotto Natale, bastò che alcuni soldati italiani impegnati a spalare la neve scambiassero frasi amichevoli e gli auguri con militari tedeschi impegnati nello stesso compito, perché fossero accusati di "conversazione col nemico" (1 anno), mentre un poveraccio che si espresse in tedesco si prese 8 anni per "tradimento indiretto". (FM). A un gruppo di soldati furono comminati dai sette ai 20 anni di reclusione per aver lanciato pane e sigarette ai tedeschi, invece di sparargli addosso (FM); numerosi episodi analoghi di fraternizzazione furono pagati con anni di galera.
Non era raro che i comandi, venuti a conoscenza di atteggiamenti antimilitaristi in alcuni reparti, li infiltrassero con carabinieri travestiti da soldati. Questi poi provvedevano solertemente a denunciare eventuali casi di diffusione del virus disfattista, che poteva configurarsi "ogni qual volta il mezzo adoperato - qualunque esso sia - reca in sé l'attitudine alla persuasione... nei discorsi velenosi sovvertitori della disciplina", nell'elogio della diserzione, nella manifestazione di un pensiero contrario alla guerra, nella denigrazione dell'opera dei superiori... Insomma, in qualunque forma si manifestasse " l'ars diabolica del subornatore". Oppure, per incastrare elementi in odore di disfattismo, giovani zelanti ufficiali portavano volutamente il discorso sui mali della guerra per indurre gli elementi sospetti a manifestare le proprie idee (FM).
Nelle sentenze non mancano valutazioni espressamente politiche: "dire ingiusta una guerra che con unanime consenso ha voluta tutta la nazione ed ha lo scopo non solo di realizzare le supreme aspirazioni nazionali, sogno di tanti martiri, ma ancora d'insorgere e di resistere contro l'imperialismo tedesco, al quale scopo si è trovata concorde tutta la democrazia del mondo, significa insorgere contro quell'istessa classe di lavoratori, di cui il V.D.S [l'accusato di "lettera denigratoria"] si vorrebbe elevare a paladino" (FM). A volte, poi, riprendono la retorica vomitevole della propaganda, quasi a voler coprire con parole roboanti il crimine di condannare a morte un poveraccio che ha cercato di disertare: chi non muore con una pallottola in fronte, muore con una scarica alla schiena del plotone di esecuzione: "Ritto nella trincea sotto il fuoco che l'attornia e lo avvince, il soldato d'Italia sta saldo e sicuro, fidente nel sopraggiungere di altri petti, che gli permetteranno di mantenere il posto d'onore che gli è affidato. Il P.C. [...] ha preferito, anziché la palla in fronte che gli avrebbe dato il diritto di invocare nell'ultimo singulto con profondo orgoglio il nome d'Italia, e della mamma sua, volgere le spalle. Su lui morto, già completamente morto nell'onore, scenda non crudele ma inflessibilmente severa la sanzione della legge, monito solenne ai vigliacchi e ai traditori" (fronte orientale, luglio 1917, FM).
Mentre i "vigliacchi", nella logica demenziale degli alti comandi, temendo la condanna a morte si sarebbero miracolosamente trasformati in eroi, ai "rivoluzionari" per un certo periodo furono riservate pene più miti, e forse non era del tutto estranea a questa scelta la volontà di evitare di trovarsi troppi "eroi" e "martiri" tra le schiere degli antimilitaristi e degli avversari politici. "Solo" 19 anni di carcere militare a un muratore di 22 anni colpevole di discorsi sovversivi, di inviti alla ribellione e a rivolgere le armi contro coloro che "malvagiamente mandano al macello, ossia contro i superiori"; ma l'ergastolo a chi aveva istigato i compagni a boicottare la guerra con un "Rifiutiamoci di combattere e così finirà questa guerra che è un macello di poveri" (FM). Probabilmente, i giudici ritenevano che la prospettiva di uno "sciopero militare" avrebbe più facilmente trovato adesioni di un aperto ammutinamento in armi nella massa dei combattenti ormai esausta ed esasperata. A partire dal 1917, il moltiplicarsi dei comportamenti di insubordinazione e aperta rivolta tra le truppe e delle agitazioni proletarie nelle città produsse un inasprimento dei provvedimenti contro il disfattismo e la propaganda antimilitarista.
Nel mese di agosto a Pradamano – località poco distante da quella che poco prima era stata teatro della rivolta della Brigata Catanzaro (cfr. più avanti) – si tenne il processo a carico di 19 imputati, civili e militari, accusati di propaganda dei deliberati di Kienthal e Zimmerwald e del Bureau giovanile socialista di Zurigo, "affermanti la necessità di imporre con tutti i mezzi la cessazione della guerra" e come tali in grado di esercitare un'”influenza perniciosa” sullo spirito delle truppe e di attentare alla “capacità di resistenza militare”. Il tribunale comminò 17 condanne per tradimento "senza intenzione di tradire", o per complicità nel reato, ad un massimo di 15 anni di reclusione (FM). Qualche giorno dopo, sempre a Pradamano, si celebrò un processo contro una cellula di propaganda socialista, composta da civili e militari, con condanne da uno a cinque anni di reclusione. La svolta repressiva che coinvolse organizzazioni proletarie impegnate contro la guerra segnava un mutamento di prospettiva: fino al 1917, gli episodi di insubordinazione, insofferenza e disfattismo avevano coinvolto singoli o gruppi più o meno numerosi che spontaneamente reagivano alle condizioni inumane cui erano costretti; dal 1917, i comandi temettero che l'insofferenza montante favorisse la propaganda antimilitarista e la spinta all'insubordinazione [NOTA SU ESEMPI INTERNAZIONALI]. L'inasprirsi delle pene contro la propaganda politica è ben esemplificata dalla condanna all'ergastolo comminata nel novembre 1917 a un militare reo di aver raccolto offerte per un giornale pacifista. Il 20 agosto dello stesso anno, un fante impegnato sul fronte in Carnia convinse i compagni a lanciare dal treno sassi contro gli ufficiali, al grido "Viva la Rivoluzione russa, abbasso l'Italia!". Fu condannato a 7 anni di reclusione.
Piccole e grandi rivolte
Innumerevoli furono gli episodi di rivolta e insubordinazione di interi reparti, che per il loro carattere collettivo rendevano il lavoro dei tribunali particolarmente difficoltoso. Se non si riuscivano ad individuare i responsabili che avevano dato il via alla protesta, non si poteva procedere a incriminazioni di massa senza privare il fronte dell'indispensabile carne da cannone. Molti di questi episodi videro protagonisti il corpo degli alpini, proprio quello che tuttora rinnova annualmente celebrazioni e sfilate patriottiche. Fu un gruppo di alpini a rivoltarsi il 26 dicembre 1915, alla stazione di Sacile, contro l'ordine di rientrare immediatamente al fronte dove erano stati appena rimpiazzati. Probabilmente incoraggiati da abbondanti bevute, obbligarono 300 fanti a scendere da treno sparando in aria e compiendo atti vandalici. L' episodio fu tutto sommato limitato - agli accusati fu addebitata anche la razzia di due fagiani "dell'approssimativo valore di L.12" - ma per le sue caratteristiche di spontaneità fece capire ai comandi che bastava poco perché le ire dei disperati mandati a morire sfociassero in una rivolta in grande stile: "Le autorità politiche e quelle militari le collegarono ad altre manifestazioni di protesta degli alpini, scorgendovi una sobillazione politica. L'episodio di Sacile restò negli occhi dei comandi come uno dei gravi fatti di indisciplina della guerra" (FM). Nell'ottobre del 1916, durante un trasferimento in treno, alla fermata di Bassano un gruppo di alpini cominciò a sparare colpi in aria "fra schiamazzi di allegria e di scherno... grida sediziose come quelle 'Abbasso la guerra!, 'Fuori gli imboscati'". Un mese dopo, si verificò un episodio analogo in un trasferimento da Verona a Vicenza, che coinvolse un numero maggiore di alpini e costò 20 anni di galera ai pochi che poterono essere identificati. La sentenza di condanna contemplava l'aggravante che proprio il corpo degli alpini si fosse reso protagonista del deplorevole episodio: "perché maggiormente delinque chi deve vincere freni morali più forti" (FM). "Viva gli alpini!", verrebbe da dire, se non fosse che nel frattempo il corpo è divenuto oggetto di una mitologia patriottica che poco ha a che fare con la verità storica... Va da sé che molti di questi episodi comportassero una durissima repressione: nel marzo del 1916, un gruppo di soldati sul fronte orientale si rifiutò di fronte a un colonnello di obbedire all'ordine di avanzare, gridando "non si può, non si può". Due di loro furono riconosciuti responsabili di sobillazione e fucilati a un mese dall'episodio.
Il 1917 è l'anno delle dimostrazioni contro la guerra, alle quali partecipavano donne, bambini e non di rado militari in licenza. In una lettera al fratello, un contadino di Como scrive: "Se non fate qualche rivoluzione voialtri mi vogliono mazzare tutti... che se non termina presto noaltri soldati che si trovano al fronte non torniamo a casa nessuno... pensate voialtri borghesi a far la pace perchè non è impossibile dirgle anche alle donne che facciano delle dimostrazioni, altrimenti andiamo molto male, baste?" (FM). A Castagnole Lanze, nel gennaio 1917, alcuni soldati in licenza dal fronte "si erano abbandonati ad atti vandalici, avevano istigato la popolazione a mostrarsi ribelle agli inviti delle autorità di ritornare alla calma, si erano rifiutati di di eseguire gli ordini loro impartiti dai R.R.C.C. di allontanarsi e, con insulti, avevano lanciato contro gli stessi R.R.C.C. pietre e rape". I dimostranti si diressero contro la caserma dei carabinieri per reclamare la liberazione di alcuni arrestati. Un alpino di Cuneo, arrestato "nell'atto in cui aveva lanciato contro l'appuntato dei carabinieri M. una rapa" fu condannato assieme ad altri militari dimostranti a dieci anni di reclusione (FM). Nella sentenza si legge: "Nell'applicazione della pena il collegio ritiene che debba essere severo. Non è consentito che, nel momento politico che attraversiamo, si organizzino delle dimostrazioni contro la guerra e si commettano atti che sono diretti a scuotere la concordia nazionale e specialmente non è concepibile che a quelle dimostrazioni partecipino dei militari che, dalle trincee, debbono portare nei propri paesi la parola di entusiasmo e di fede per la grandezza della Patria. ... deve giungere fino a loro la parola severa della Legge e la mano pesante della giustizia che deve essere di monito per tutti." Evidentemente, la Giustizia considerava le rape micidiali quanto le bombe, ed in effetti il loro significato simbolico era dirompente. Furono inflitti oltre 5 anni di reclusione a 7 contadini giovanissimi per aver cantato una canzonetta pacifista (FM) e 15 anni di reclusione a un cappellaio milanese, socialista, accusato di tradimento per aver diffuso l'appello della seconda conferenza di Zimmervald "Ai popoli che la guerra uccide" (9); 22 anni a un altro "pessimo soggetto" che "all'udienza ha pure tenuto un contegno manifestamente antimilitarista, dichiarando con chiarezza e franchezza di essere contrario alla guerra" (FM); dai 15 ai 20 anni per "rivolta disarmata" a quattro ragazzi poco più che ventenni per aver lanciato sassi dal treno che li portava al fronte.
Il 21 aprile 1917, 410 militari schierati in armi per partire da una caserma di Fano gridano in un sol coro " Non vogliamo partire, abbasso la guerra". La protesta continua alla stazione e gli ufficiali intervenuti nel tentativo di sedare nuove scintille di rivolta si vedono puntare contro i fucili dai soldati. Il tribunale, chiamato a giudicare solo i tre che erano stati identificati, è costretto con rammarico a riconoscere che "tutti i partenti... tumultuavano (FM)".
In agosto, esplose a Torino una rivolta "per il pane", dal chiaro segno proletario e antimilitarista. Per affrontare i dimostranti, alcuni dei quali armati, "occorse uno spiegamento di forze enorme, arresti a migliaia di dimostranti e di militanti socialisti, e pressione morale inaudita sui parlamentari e capi sindacali di parte operaia […] Va rilevato che proprio agli operai di Torino il pane non poteva mancare più che altrove e la trincea non faceva paura, perché erano esonerati delle fabbriche di produzione bellica; anzi, sfidarono la pena d'esser rimandati al fronte" (10). E infatti qualche centinaio tra gli arrestati fu spedito in trincea per "redimersi" combattendo per la patria. La rivolta fu dunque essenzialmente un'azione politica di classe e internazionalista, un segnale lanciato ai proletari di Vienna e Berlino perché facessero altrettanto. Fu invece presentata come un "complotto" ordito ai danni della Patria che poi sarebbe sfociato nel disastro di Caporetto.
La gloriosa "Brigata Catanzaro"
Anche le rivolte più gravi nacquero dall'esasperazione, e come tali erano destinate a concludersi in tragedia. La più notevole sul fronte orientale fu l'ammutinamento dei due reggimenti della Brigata Catanzaro, nella notte tra il 15 e il 16 luglio 1917, in località Santa Maria La Longa. Dopo due anni di combattimenti sul Carso, in condizioni psicofisiche estreme, i soldati avevano ricevuto la promessa di un trasferimento su fronti più tranquilli. Quando fu loro ordinato di ripartire per il fronte orientale, la situazione precipitò. Sembra che il parroco del paese, avuto sentore che si stesse preparando una forte manifestazione di rifiuto della guerra, il cui scopo era di provocare una sollevazione dell’esercito per “fare la pace subito”, ne informasse il comando della brigata. Fu allora inviato un distaccamento di carabinieri e gli ufficiali furono messi sull'avviso (11).
L'azione, partita dai baraccamenti del 141° Reggimento fanteria ed estesa quasi subito al 142°, fu ben organizzata e condotta come un'azione di guerra, con l'attacco a postazioni militari, il tentativo di coinvolgere altri reparti e di occupare il paese di Santa Maria La Longa. Pare fosse loro intenzione attaccare il vicino campo d'aviazione e compiere il gesto clamoroso di farla pagare all'odiato D'Annunzio che soggiornava in una villa nei pressi, per essere stato l'uomo-simbolo dell'interventismo. Purtroppo, quella sera il Vate non era lì, e il giorno dopo poté dunque scrivere alcuni versi dei suoi "in onore" dei ribelli appena fucilati: ma non scrisse che avrebbero preferito essere loro a fucilare lui. Nel corso della sparatoria notturna, furono uccisi due ufficiali e nove soldati, altri due ufficiali e 25 soldati rimasero feriti, ma le cifre e le perdite nei rispettivi schieramenti non sono mai state chiarite. Vi fu anche il tentativo di alcuni ufficiali di minimizzare la portata di un episodio così grave, di cui Cadorna colse subito il peso inviando due telegrammi informativi al ministro della guerra. L'azione repressiva fu immediata e coinvolse carabinieri, reparti lealisti, artiglieria e blindati. Alle 3.30 del mattino, quando sembrava che la rivolta fosse stata domata, la 6ª Compagnia del 142° Reggimento e il 371° Reparto mitragliatrici continuavano a resistere, facendo "fuoco ostinato". I ribelli si arresero solo quando si trovarono a fronteggiare gli "autocannoni", la cavalleria e l'artiglieria.
Il mattino dopo, spenti gli ultimi focolai di resistenza, furono messi al muro e fucilati 16 soldati trovati con le armi cariche e le canne ancora calde per gli spari. Poi si passò alla decimazione della 6^ Compagnia del 142° Reggimento, che si era ammutinata in massa: altre 12 fucilazioni su circa 130-140 ammutinati. I 123 ribelli superstiti furono denunciati al tribunale di guerra e e rimandati al fronte, scortati dalle autoblindo, "per redimersi". I processi a loro carico si svolsero fin dai primi di agosto e comportarono pesanti condanne; anche i partecipanti alle manifestazioni di solidarietà con i condannati subirono denunce e processi.
L'ammutinamento della Brigata Catanzaro, per quanto fosse stato preparato dal punto di vista militare, non riuscì ad estendersi. Il generico intento di provocare una sollevazione nell'esercito per "fare la pace subito" si scontrò con l'efficienza repressiva allertata dal fiuto poliziesco del prete, ma fondamentalmente l'iniziativa mancava di collegamenti. Gli obiettivi della rivolta si limitavano a un trasferimento su fronti meno caldi e alla fine della sospensione delle licenze. La sproporzione enorme tra il carattere dirompente dell'episodio e le sue modeste finalità mise in evidenza il potenziale rivoluzionario che covava tra le truppe, ma nello stesso tempo la mancanza di una guida politica che sapesse indirizzarlo verso obiettivi coerenti con un percorso rivoluzionario. Mancarono l'organizzazione e gli obiettivi: mancò il Partito.
Tuttavia, i fatti accaduti in quel piccolo paese alle porte di Palmanova, con tutti i limiti che possono esser riconosciuti all'episodio, furono una scintilla di rivoluzione, segnarono il punto più alto della rivolta contro l'inumanità della guerra su quel fronte. Non c'è nulla, nei pressi del muro del cimitero dove vennero abbattuti, che ricordi il sacrificio di quegli eroici ragazzi – la sola tra le tante insensate carneficine ad avere un significato di vero riscatto che indicasse la strada della società società futura.
Assai più celebrato e ricordato è ancora oggi, da quelle parti, l'episodio della fucilazione di quattro soldati sul fronte carnico, per il rifiuto di condurre un attacco suicida alle postazioni austriache in cima a un monte. A loro è stato dedicato un monumento in località Cercivento e la loro vicenda ha ispirato una rappresentazione teatrale e alcune pubblicazioni. Alcuni parenti dei fucilati ancora oggi insistono presso le autorità politiche e militari per la loro riabilitazione, ma non possono ottenerla perché le norme stabiliscono che la richiesta deve essere prodotta... dagli stessi interessati. Le scariche di fucileria hanno dunque decretato l'eternità della “colpa” dei disfattisti e nemmeno un secolo è stato in grado di annientare l'idiozia burocratica. Meglio così. Quella che per lo Stato borghese è colpa senza remissione, per noi è testimonianza per le generazioni future. E ancor più lo è quella dei fanti della Catanzaro, che ebbero lo straordinario coraggio – purtroppo disperato – di volgere le armi contro i loro superiori.
Sull'Isonzo
Lo storico Schindler (12) così sintetizza lo svolgersi delle battaglie lungo il tragico fiume: "In 41 mesi di combattimenti le forze armate chiamarono alle armi 27 classi di coscritti. Tra i 5 milioni e mezzo di uomini che indossarono l'uniforme, due terzi di essi vennero uccisi, feriti, catturati, o riportarono serie lesioni. Passò un'intera generazione prima che l'esercito calcolasse in modo preciso l'entità delle perdite. Le cifre finali rivelarono che l'Italia aveva sacrificato 689.000 fra i suoi figli per liberare il litorale, ora Venezia Giulia, ed il Tirolo meridionale. Un altro milione di italiani era stato gravemente ferito, e di questi la metà era rimasta invalida. La maggioranza delle vittime cadde sull'Isonzo, in quella che fu la campagna più grande e sanguinosa della guerra italo-austriaca [Per triste ironia, la popolazione acquisita con le conquiste territoriali compensava quasi esattamente le perdite subite - NdR] La valorosa armata del Duca D'Aosta, a seguito delle numerose battaglie sostenute sul Carso aveva perduto un totale di 1,269.061 soldati, di cui 140.462 caduti, 680.565 feriti e 448.004 dispersi (in gran parte morti). La fanteria e l'artiglieria da montagna italiane, i famosi Alpini, persero 166.881 uomini, la metà dei quali caduti. Dal giugno 1915 all'ottobre 1917, l'Italia aveva perduto sull'Isonzo almeno 1.100.000 soldati, il 95% di essi nel corso delle undici inconcludenti offensive di Cadorna. Perfino per i terribili standard della Grande Guerra, questo rappresentò un immenso sacrificio".
Sul fronte opposto si contarono circa 650.000 perdite, tra morti, feriti e dispersi. Fino a Caporetto, sull'Isonzo si susseguirono undici sanguinose offensive, tutte fallite. Cadorna è stato definito "prudente" nell'operare al comando delle armate: forse lo fu nei riguardi del proprio posteriore e di quello dei suoi nobilissimi accoliti, non certo verso le centinaia di migliaia di poveri cristi che mandò al massacro a più riprese senza batter ciglio. Un criminale ostinato, uso a ripetere "il superiore ha sempre ragione, specialmente quando ha torto", ma "prudente": l'unica volta che ebbe l'occasione di "sfondare" veramente approfittando della debolezza temporanea dell'avversario (nel 1916, dopo la presa di Gorizia), preferì fermare l'avanzata; evidentemente gli piaceva continuare a far la guerra in quel modo estremamente produttivo in termini di morti: dare gigantesche "spallate" a postazioni di fatto imprendibili. Gli piaceva anche che la guerra continuasse e che si vincesse a quel modo, e non altrimenti, ad esempio aggirando le posizioni nemiche con uno sbarco nel Quarnaro: non sarebbe stato abbastanza eroico vincere con la tattica invece che con la forza, e presupponeva di condividere i meriti dell'inevitabile vittoria con i comandi della marina e con altri generali meno "generalissimi" di lui. La storia trova sempre gli uomini adatti a raggiungere i suoi scopi; allora, per sottomettere all'autorità masse di “contadini incivili”, per sfoltire l'eccesso di forza lavoro, serviva uno così, senza peli sullo stomaco quando si trattava di disporre piena libertà di azione agli ufficiali per fucilare sul posto i "disfattisti".
La terza battaglia, (ottobre 1915) costò agli italiani 67.000 perdite (4000 al giorno): "Intere brigate e divisioni furono sottoposte a continui massacri, soltanto per tornare il giorno successivo sulla stessa collina, senza che si verificasse un solo ammutinamento" (Schildler, cit.). Quasi 42.000 le perdite austriache. Da allora, gli ufficiali di Stato Maggiore cominciarono a parlare di fabricklicher Krieg (guerra della catena di montaggio), e in effetti la "messa in opera" di armi micidiali su larga scala produceva una quantità enorme di morti, realizzando in breve tempo e con grande efficienza il fine ultimo di ogni guerra moderna: la distruzione di merce-capitale e di merce forza-lavoro (cioè di proletari) in eccesso.
Con Caporetto si era raggiunto un punto di rottura dopo anni di incredibile tenuta del sistema industriale di distruzione. In Francia, la crisi era già sopraggiunta all'inizio del 1917, quando il numero dei morti eguagliò quello dei soldati delle divisioni in prima linea. Nell'autunno del 1917, l'esercito italiano contava 600.000 fanti nelle unità combattenti e aveva avuto già 571.000 morti. Nell'ultima battaglia, in agosto, annunciata come decisiva, i morti furono 100.000 e i risultati furono insignificanti. All'ennesimo insuccesso fece seguito il disastro militare di Caporetto.
1917: la crisi degli eserciti
Nel corso del 1917, le contraddizioni sollevate dalla guerra produssero le situazioni più prossime al crollo delle strutture politico-militari imperialiste che sostenevano lo sforzo bellico. La perdita di vite umane aveva raggiunto livelli mai visti nelle guerre precedenti. Già alla fine del 1914, la Francia aveva perso 300.000 uomini e altri 600.000 erano stati feriti; nel 1918, i morti raggiunsero il milione e 300mila. La pace sociale resse fino ad allora solo grazie alle pensioni di guerra ai familiari delle vittime (680.000 le vedove di guerra) e ai buoni stipendi dell'industria bellica. Le perdite pesavano soprattutto sulla situazione nelle campagne, in un paese ancora prevalentemente agricolo. In Germania, entro la fine del 1916 era stato ucciso più di un milione di soldati. La guerra sembrava volgere alla vittoria (occupazione di Belgio e Francia settentrionale, sconfitta di Serbia e Romania, successi sul fronte russo), ma i sacrifici interni erano enormi per il blocco dei rifornimenti dovuto alla supremazia navale dell'Intesa, almeno finché l'azione degli U-boat tedeschi non fu libera da limitazioni (1917). L'inverno del 1916-17 fu chiamato "l'inverno delle rape". In Austria-Ungheria, la situazione era ancora peggiore: nell'intera guerra, l'esercito austriaco contò 5 milioni di perdite, il più alto numero tra tutti i belligeranti, i più caduti sul fronte russo.
Tuttavia, nonostante le carneficine al fronte e gli immensi sacrifici delle popolazioni, le democrazie ressero bene l'impatto con il conflitto. Ascriviamo alla democrazia, non al "militarismo" prussiano, anche la capacità di tenuta del Reich, perché per noi è proprio la democrazia elettiva il " terreno di coltura" del militarismo (13). "Durchalten" ("andare fino in fondo", la parola d'ordine dei tedeschi) funzionava per la tenuta della coesione nazionale, di cui il militarismo gerarchico rappresentava solo uno strumento. Il paese che più seppe sostenere lo sforzo bellico nel corso del critico 1917, anche quando la Francia fu costretta a mantenersi a lungo sulla difensiva, fu la democraticissima Inghilterra, in grado di contrattaccare su vasta scala di fronte alle incalzanti offensive germaniche dopo il cedimento dei russi a oriente. Il primo vero cedimento inglese, paragonabile per perdite a una Caporetto, si ebbe nel corso dell'offensiva tedesca nel marzo del 1918, quando la Germania fu a un passo dalla vittoria. Ma nel frattempo continuava a ritmi sostenuti l'afflusso di truppe americane che diedero il contributo decisivo alla tenuta di quel fronte. L'intervento della democrazia più moderna, quella statunitense [NOTA SULL'OPPOSIZIONE ALLA GUERRA IN USA], fu il fattore decisivo nella vittoria dell'Intesa.
A cedere fu l'arretrata Russia, dove "l'offensiva Kerensky" della primavera 1917 fallì nel tentativo di dare alla guerra un nuovo carattere democratico-rivoluzionario e di creare nelle truppe una nuova coesione e nuove motivazioni patriottiche: l'esercito si dissolse sotto l'azione del disfattismo rivoluzionario dei bolscevichi, che si legava allo spontaneo disfattismo delle masse di soldati-contadini.
Già sul finire del 1916 la censura militare registrava nei ranghi dell'esercito zarista un "insopprimibile desiderio di pace a tutti i costi". A differenza che nelle democrazie a occidente, in Russia la tenuta economica e politica era precaria. Il problema economico non era tanto la penuria di beni, come negli Imperi centrali: "Si trattava al contrario di uno sviluppo incontrollato. La mobilitazione industriale in Russia, finanziata da un'enorme espansione del credito e dall'abbandono della parità aurea, aveva creato una continua domanda di lavoro alla quale si rispose con l'esonero dal servizio militare dei lavoratori specializzati – da qui parte dello scontento tra i soldati contadini..." Grandi masse rurali si spostavano verso le città per trovare impieghi più remunerativi nelle miniere, nelle ferrovie e nei campi petroliferi, nell'edilizia e soprattutto nelle fabbriche, dove la forza lavoro fu più che triplicata durante la guerra (14). L'aumentata circolazione di moneta generò inflazione, che aumentò i costi di produzione nell'agricoltura, mandando in crisi i rifornimenti alle città. La rivoluzione di febbraio fu provocata dalla carenza di cibo, ma fu il contesto generale a determinarne la possibilità e il successo, grazie allo spontaneo schierarsi con le masse in rivolta di una parte della guarnigione di Pietrogrado. Dopo l'abdicazione dello zar, il governo provvisorio e gli stessi soviet cercarono di rilanciare la guerra attribuendole carattere patriottico di difesa nazionale dall'invasione straniera.
Kerensky, in qualità di Ministro della guerra, liquidò i vertici dell'esercito e vi mise a capo Brusilov, nella speranza vana di rianimare lo spirito combattivo della truppe, ma ormai il disfattismo dilagava; così, nel rapporto di un generale si legge: "in riserva i reggimenti dichiarano la loro disponibilità a combattere fino alla vittoria totale, ma poi si defilano di fronte alla richiesta di andare in trincea" (Keegan, cit. p.382). Nel giugno l'"offensiva Kerensky" ottenne qualche successo iniziale, poi le truppe di prima linea si rifiutarono di avanzare e iniziarono le diserzioni in massa. Sappiamo che, per la parte relativa alla guerra, le "Tesi di aprile" redatte da Lenin non furono comprese inizialmente nemmeno da molti bolscevichi: ma esse costituivano la chiave di volta del processo rivoluzionario nella prospettiva internazionalista di Lenin, che entrava apertamente in contraddizione con quella della continuazione della guerra nazionale, in qualunque veste si presentasse. Alla presa bolscevica del potere fece subito seguito l'armistizio e poi, in marzo, la pace di Brest-Litowsk. Nel frattempo, l'esercito russo si era dissolto, i soldati avevano, come disse Lenin, “votato per la pace con i piedi”: in centinaia di migliaia, si erano allontanati dalla guerra anche prima della Rivoluzione d'ottobre, per consegnarsi prigionieri ai nemici. Alla fine del 1917, quasi quattro milioni di russi erano in mano tedesca o austriaca, ben più del milione e 300mila russi che si stima siano caduti sui campi di battaglia.
Qualcosa di simile si verificò anche a occidente, senza tuttavia che si arrivasse alla completa disgregazione degli eserciti. Ad aprile 1917, i francesi attaccarono in forze sull'Aisne con l'obiettivo di sfondare le linee nemiche, che nel frattempo erano sì arretrate ma si erano enormemente rinforzate. Il fallimento dell'offensiva comportò 130.000 perdite francesi, di cui 29.000 morti. Subito dopo iniziarono gli "atti di indisciplina collettiva" che alcuni chiamano "ammutinamenti del 1917", altri "sciopero militare". Il grosso rifiutò di obbedire agli ordini e di "tornare in trincea". Fu una manifestazione di dissenso estrema che portò a una specie di compromesso: i soldati accettavano di mantenere le posizioni difensive, ma si rifiutavano di attaccare. Richiesero più licenze, cibo migliore, maggiori sussidi per le famiglie, fine delle "ingiustizie", del "massacro" e "pace". Le richieste erano spesso le stesse di coloro che partecipavano agli scioperi civili, che si moltiplicarono nella primavera del 1917 in seguito alla crescita dei prezzi, alla rabbia contro i profittatori di guerra e alla prospettiva di pace sempre più lontana. I manifestanti civili si lamentavano che “mentre il popolo deve lavorare fino alla morte per guadagnarsi a malapena da vivere, i padroni e i grandi industriali ingrassano" (cit. in Keegan, cit. p.374).
Pétain, subentrato a Nivelle, venne incontro alle richieste dei combattenti e adottò una tattica strettamente difensiva che comportava risparmio di vite umane al fronte. Gli alti comandi si erano convinti che “non possiamo pensare di piegare il movimento con il rigore, altrimenti si arriverebbe certamente all'irreparabile” (cit. in Keegan, cit. p.375).
Tuttavia, anche questo movimento fu piegato solo con il ricorso alla repressione dei "responsabili", degli agitatori civili e di quelli tra le truppe. "Ci furono 3427 ricorsi alla corte marziale, che condannò a morte 554 soldati, 49 dei quali furono effettivamente fucilati. Per centinaia di altri la pena fu commutata nel carcere a vita. [...] In superficie l'ordine nell'esercito francese fu ristabilito con relativa rapidità". Di fatto, la condotta nella guerra divenne del tutto passiva, e i tedeschi si adattarono di buon grado. "Il costo dello sforzo per vincere la guerra – 306.000 morti nel 1914, 334.000 morti nel 1915, 217.000 nel 1916, 121.000 nel 1917, in gran parte prima degli ammutinamenti, un milione in tutto su una popolazione maschile di venti milioni – aveva spento la volontà di combattere dei francesi. I soldati erano disposti a difendere il suolo della patria, non ad attaccare. Il loro atteggiamento non cambiò per quasi un anno" (Keegan, cit.375-376). Quando gli inglesi proposero a Pétain una nuova offensiva in giugno, si sentirono rispondere che due divisioni francesi avevano rifiutato di partire e dare il cambio a due divisioni in prima linea. I comandi avevano perso completamente il controllo delle truppe.
Nella primavera del 1918, i tedeschi, notevolmente rinforzati dall'arrivo delle truppe dirottate dal fronte orientale, tentarono il tutto per tutto prima che arrivassero gli americani. A quel punto, le perdite in tutti e quattro gli eserciti principali avevano pareggiato il numero degli effettivi di fanteria con i quali avevano iniziato il conflitto. I tedeschi erano effettivamente a un passo dalla vittoria, ma fallirono non solo per errori di conduzione dell'offensiva, ma anche per motivi legati alla "frale natura umana", che possiamo con buona ragione attribuire allo spontaneo disfattismo di chi è mosso dal bisogno: "la zona delle retrovie britanniche, piena dei lussi goduti dall'esercito di un paese che era sfuggito agli anni di blocco che in Germania avevano trasformato le più elementari necessità della vita in prodotti rari e costosi, indusse più volte i tedeschi che avanzavano a fermarsi per saccheggiare e sfamarsi". Un colonnello tedesco dichiarò che "intere divisioni si rimpinzarono all'inverosimile di cibo e liquori" perdendo l'occasione di "muovere il decisivo attacco in avanti" (cit. in Keegan, cit.p.455). Si può ben dire che, in un momento cruciale, a salvare l'Intesa poterono più i prosciutti e le birre dei fucili e dei cannoni.
Il prezzo pagato dai tedeschi per le ultime offensive fu enorme (400.000 uomini), tanto che alla fine di aprile non erano più in grado di insistere negli attacchi: "Le truppe non attaccheranno, nonostante gli ordini. L'offensiva è giunta alla fine" (da un rapporto della VI armata, cit. in Keegan). A metà del 1918, gli effettivi dell'esercito tedesco erano calati da 5,1 milioni a 4,2 milioni. La guerra aveva raggiunto il suo scopo: non c'erano più uomini da sacrificare nella carneficina e i nuovi reclutamenti erano del tutto insufficienti ai rimpiazzi – i soldati non volevano più combattere. Dall'altra parte, la presenza degli americani aumentava al ritmo di 250.000 effettivi al mese. La sproporzione di forze che si stava determinando indusse i tedeschi a ritirarsi fino alla linea Hindemburg, formatasi nel 1914. In settembre, "le truppe che tornavano dal fronte insultavano quelle che vi si avviavano al grido di 'crumiri'" (Keegan, cit. p. 466). Ludendorff, contro le disposizioni del nuovo governo Max di Baden che lavorava ormai alle trattative di pace sulla base dei "14 punti" di Wilson, in un proclama all'esercito chiamò le truppe all'estrema difesa, ma dovette dimettersi quando la notizia giunse al Reichstag.
Il vecchio esercito imperiale aveva esaurito la propria capacità di sostenere la guerra, ma si sarebbe riorganizzato nelle formazioni dei Freikorps, tenute insieme da ufficiali e veterani, che prevalsero nelle battaglie di strada contro i proletari rivoluzionari nelle città tedesche, "rendendo così il governo repubblicano eternamente debitore nei confronti dei generali di quell'esercito improvvisato" (Keegan, cit. p.472). Anche cessate le ostilità, la guerra, con il suo portato di nazionalismo, "spirito di corpo", coesione gerarchica, continuava il proprio servizio alla controrivoluzione.
Caporetto
Caporetto chiude il tragico, lunghissimo capitolo della guerra sul fronte orientale italiano. In seguito, dalla ritirata sul Piave in poi, non ci fu più la stessa intensità bellica, ma un fronteggiarsi di eserciti esausti nel fisico e nello spirito, incapaci di produrre vere offensive. I comandi dovettero adattarsi, e a quel punto il vero nemico diventava più che mai il disfattismo, contro il quale si moltiplicarono le energie repressive.
In ottobre, gli austriaci organizzarono un'offensiva con il supporto di truppe tedesche provenienti dalle vittorie sul fronte russo. Al loro successo contribuirono certamente gli errori degli alti comandi italiani, tanto supponenti quanto inetti, ma il fattore fondamentale fu la scarsa volontà di combattere del grosso delle truppe. Quando fu chiaro che il fronte aveva ceduto, gli italiani cominciarono ad arrendersi in massa, consegnandosi spesso spontaneamente al nemico. Non volevano più saperne della guerra. A differenza delle grandi offensive sull'Isonzo, la rotta di Caporetto provocò un numero relativamente ridotto di morti (10.000), ma i prigionieri furono ben 275.000. Cadorna cercò di addossare la responsabilità del disastro al "disfattismo" delle retrovie e parlò di "sciopero militare". In realtà, si era spezzato il fragile equilibrio che aveva incredibilmente retto nei lunghi mesi di guerra: "In pratica i proletari soldati avevano applicato sia pure in modo insufficiente il disfattismo, disertando il fronte. Avevano gettato le armi invece di tenerle per azioni di classe, come nello stesso tempo avveniva sui fronti russi; se non avevano sparato sui loro ufficiali, era perché gli ufficiali erano scappati con loro anziché impugnare le storiche pistole dell'Amba Alagi 1897 (altra grande tappa italiana) nel tentativo di impedirne la fuga” (15).
Se è vero che gli ufficiali non poterono impedire la fuga di una massa sterminata di uomini – e i primi a darsela a gambe furono i generalissimi – , non per questo i comandi rinunciarono a punire a casaccio i responsabili di tanta vergogna nazionale. Durante la ritirata furono innumerevoli gli episodi di giustizia sommaria contro gli sbandati. Le pistole di Amba Alagi spararono ancora, ma senza altro scopo che la vendetta e la sopraffazione. Lungo le principali direttrici verso Ovest si crearono paurosi ingorghi di uomini, animali e mezzi. Ai militari si aggiungevano i civili in fuga, terrorizzati dall'arrivo del “barbaro teutonico”. La disorganizzazione dell'esercito era totale, automezzi e artiglierie venivano abbandonati sui cigli delle strade o gettati dai ponti per risolvere gli ingorghi. Quando i ponti vennero fatti saltare, furono tagliati fuori interi reparti ai quali fu impedita la ritirata. Nel caos più completo, la disciplina fu affidata all'arbitrio degli ufficiali, cosicché anche la ritirata si trasformò in carneficina dalle dimensioni ignote. Gli ufficiali più solerti nel punire i sottoposti furono incaricati di adottare metodi brutali e sbrigativi contro i reduci: "Il gen. Antonino Di Giorgio decretò che i militari che avevano abbandonato il proprio reparto potevano essere passati per le armi. Per la fucilazione bastava un qualunque ufficiale superiore. La zona di riflusso doveva essere pattugliata da contingenti di carabinieri e ufficiali energici. Con i soldati disarmati bisognava usare il bastone". Chiunque poteva essere messo al muro: "I reparti non esistevano più, ogni militare era tecnicamente 'disperso'": dunque, tecnicamente colpevole di aver abbandonato il proprio posto. "L'arbitrio la fece da padrone" (L.Del Boca, cit., p.205-206). L'"Avanti" pubblicò le lettere dei reduci: “Al Tagliamento, i soldati furono obbligati a consegnare le armi. Perché? Più avanti le compagnie venivano fermate e, presi alla rinfusa 10, 20, 30 soldati, si procedeva alla loro fucilazione. Perché non si erano dati prigionieri! Fucilati come cani per il capriccio di un generale che era, anch'esso, fuggito. E credeva, apparendo spietato, di mettersi al riparo dal disprezzo di chi l'aveva visto fuggire” (16).
I fucilati furono decine, forse centinaia, e i fucilatori spesso non si facevano nemmeno scrupolo di seppellirli e registrare i nome dei disgraziati. L'accusa ricorrente era di “saccheggio”, ma i soldati erano costretti a rubar galline per sfamarsi, dato che nessuno passava loro nemmeno lo schifoso rancio. L'”Avanti” pubblicò allora molte testimonianze dei reduci, tra le quali l'episodio di un soldato pestato brutalmente perché teneva la pipa in bocca su ordine del gen. Graziani che evidentemente giudicava l'atteggiamento poco rispettoso della Patria in pericolo. Dei civili protestarono, e per tutta risposta l'ufficiale dimostrò che lui poteva fare ciò che voleva, e fece fucilare il soldato: ufficialmente, la morte fu attribuita ad "asfissia". Il “valoroso patriota Graziani” non poté però godersi la meritata pensione: nel 1931, il suo corpo fu ritrovato sulla massicciata della ferrovia Bologna-Firenze, ufficialmente vittima di una disgrazia, più probabilmente di una vendetta tardiva [EPISODIO NARRATO DA BL?].
Da Caporetto in poi, le esecuzioni sommarie contro disertori e ribelli, che dall'inizio della guerra fino alla metà del 1917 furono non meno di un migliaio, salirono a 5 mila, sempre approssimativamente e per difetto.
Quanto agli effetti politici del disastro militare, era prevedibile che esso avrebbe agito potentemente sulle fragili convinzioni pacifiste di molti esponenti del PSI, specie parlamentari, che avrebbero voluto schierare il partito sulla linea del Piave, in una ritrovata concordia nazionale. A impedirlo furono solo la mobilitazione dei militanti e l'azione della Frazione intransigente appena costituita: per arginare la "Caporetto" del partito fu ingaggiata una vera e propria "colluttazione" interna che impedì la deriva patriottica. In seguito, la Sinistra valutò che il successo della tendenza classista e internazionalista fu un'arma a doppio taglio: se si fosse realizzata la versione italiana dell'"Unione sacra", e ci mancò pochissimo, l'inevitabile scissione avrebbe abbreviato il percorso di formazione del partito di classe e tagliato immediatamente i ponti con il grosso dell'opportunismo interno. Ma intanto la Frazione intransigente era riuscita a riportare il Partito e la Direzione sul terreno classista e internazionalista, e si ponevano le premesse programmatiche e organizzative per la costituzione della "Sinistra italiana". Alla ritrovata intransigenza del PSI, rispose una dura repressione contro le manifestazioni di antimilitarismo, le lotte operaie, i militanti socialisti (17).
A riscattare la Caporetto dei patrioti venne la "gloriosa" Vittorio Veneto. In realtà a Vittorio Veneto non ci fu battaglia, perché gli Austriaci non erano nelle condizioni di battersi; gli Imperi centrali erano ormai piegati dal completo esaurimento delle risorse economiche e umane – era l'insieme della loro struttura imperialistica aver ceduto, prima di quella militare – e già se ne prefigurava il completo crollo politico. Il 2 novembre fu stipulato l'armistizio che sarebbe entrato in vigore il giorno dopo, ma i comandi italiani disposero il cessate il fuoco solo per il 4, con 24 ore di ritardo. Le truppe spararono sui soldati austriaci disarmati e convinti che la guerra fosse finita. Per cancellare la memoria del precedente disastro militare, i fautori della guerra dovevano chiudere i conti con una "vittoriosa" battaglia finale, "che al solito dovettero alle armi straniere, poiché la loro più alta impresa nazionale si chiamò Caporetto" (cfr. "Guerra e rivoluzione", 1950).
Disfattismo e rivoluzione
Allo scatenarsi del conflitto, il PSI, se si era "salvato l'anima" non aderendo all'"Unione sacra", era ben lontano dalla prospettiva indicata da Lenin di trasformare la guerra imperialista in guerra civile, e la poco felice formula di Lazzari ("non aderire né sabotare") lo relegava entro un passivo pacifismo "da crocerossine" (18), esponendolo alle critiche di "panciafichismo" degli interventisti di varia estrazione. Nell'agosto 1917, per iniziativa di alcune sezioni, si costituì il primo nucleo della Frazione intransigente rivoluzionaria, che immediatamente si propose di mettersi alla guida dei moti proletari contro le istituzioni borghesi e per "la pace immediata", non ancora per gli obiettivi indicati da Lenin. L'azione interna della Sinistra si rafforzava, precisava i propri capisaldi teorici e contrastava efficacemente sia le tendenze più inclini al cedimento patriottico che covavano nella destra da sempre filo-intesista sia il pacifismo ufficiale del Partito. Nella polemica tra pacifismo e interventismo, la nascente Sinistra si proclamò per "l'interventismo della lotta di classe", per l'azione rivoluzionaria del partito tanto nelle lotte operaie quanto nella battaglia antimilitarista tra i soldati. Nel 1917, dopo Caporetto, la Frazione riuscì a coinvolgere la Direzione nella sua linea intransigente, ma il Partito nel suo insieme rimaneva un agglomerato di tendenze tra loro anche lontanissime e non poteva avere forza e coesione sufficienti per portare i proletari in divisa sul terreno del "disfattismo rivoluzionario politico" . Le masse proletarie al fronte, per quanto – come si è visto – spontaneamente inclini alla rivolta, non poterono disporre ancora dell'organo-partito che solo avrebbe potuto dar loro la giusta prospettiva e le indicazioni pratiche, l'organizzazione e il fine. Se si fa eccezione per l'esercito russo, dove il disfattismo dimostrato "con i piedi" ebbe da un certo punto in poi il sostegno della politica rivoluzionaria e antimilitarista dei bolscevichi, negli altri fronti il disfattismo rimase un fatto spontaneo, motivato da ragioni di sopravvivenza, dalla necessità di resistere individualmente e collettivamente ai soprusi dei superiori. Nel tempo, assunse sempre più spesso motivazioni pacifiste, talvolta classiste, antimilitariste e rivoluzionarie: ma i pur numerosi episodi non ebbero mai un collante organizzativo che desse loro la forza di provocare una rivolta generalizzata. Quello che accadde in Francia – materia senz'altro da approfondire – fu effettivamente un movimento grandioso di protesta e di rifiuto di combattere. Si presentò più come "sciopero militare" che come rivolta in armi – anche se alcuni episodi importanti di questo genere si verificarono – e si tradusse in una serie di rivendicazioni che i comandi furono costretti in buona parte a concedere. La risposta "riformista" della politica e dei comandi rafforza la nostra tesi della superiorità della democrazia negli affari bellici e, più estesamente, nella capacità di controllare il conflitto sociale; questa capacità è tuttavia subordinata alla disponibilità di adeguate risorse da spendere per la pacificazione, e se l'Intesa ne disponeva in abbondanza, non altrettanto si può dire degli Imperi centrali. Non siamo a conoscenza di episodi altrettanto generalizzati di disfattismo tra le truppe del 2° Reich, ma certamente un fattore decisivo nel rafforzare la coesione nazionale nello sforzo bellico fu il sostegno della socialdemocrazia tedesca all'union sacrée. Altrettanto efficace, e quanto mai moderno, si rivelò l'abbinamento di concessioni e repressione nell'intento di isolare i gruppi e gli elementi sovversivi dalla massa dei sottoposti. Questa politica fu messa in atto nei confronti degli eserciti francese e italiano soprattutto a partire dal 1917, quando la tenuta delle strutture gerarchiche entrò in grave crisi. Se qualcosa fu concesso, in termini di licenze e approvvigionamenti, e se di fatto la guerra si trasformò in una tregua prolungata che ridusse l'intensità del massacro, la repressione si accanì con maggiore brutalità ed estensione contro i proletari più coscienti.
Nelle circostanze in cui la protesta si elevò a ribellione armata, anche nei limiti di una spontaneità disperata o di rivendicazioni limitate, si raggiunse il livello più alto di opposizione alla guerra, ma anche il più comune disfattismo fece vedere i sorci verdi ai comandi di tutti gli eserciti; niente come il suo virus era in grado di annichilire la mostruosa macchina bellica, e la sua radice stava nell'umanità umiliata e massacrata sui campi di battaglia, qualunque divisa vestisse: "Le masse avevano capito quanto possono capire, finché non fa maggior luce il partito rivoluzionario" (19).
Gli insegnamenti di allora rimangono quanto mai attuali. La guerra imperialista rimane l'unica via d'uscita di cui il Capitale dispone per uscire dalla crisi storica del meccanismo di accumulazione nella quale è profondamente invischiato. Invocherà ancora la Patria, la Nazione e la Democrazia per giustificare nuovi conflitti, compreso un nuovo conflitto generale che si profilerebbe come una minaccia per la stessa sopravvivenza della specie. Nella veste di fronti imperialistici avversi, il Capitale si porrà ancora come obiettivo lo schiacciamento dello storico nemico di classe, il proletariato internazionale. Allora dovrà risuonare alto e forte il richiamo internazionale del partito di classe al "disfattismo rivoluzionario politico, economico e sociale".
La guerra tra le nazioni capitalistiche (che è anche distruzione di nazioni) è diventata la condizione necessaria e sufficiente della loro stessa esistenza economica e politica in quanto tali, ovvero della dittatura imperialista della borghesia su scala mondiale: non più solo, come in passato, per sviluppare un mercato interno, ma per essere via di integrazione nel mercato internazionale – al passo degli scarponi chiodati. La base politica delle piccole nazioni o pseudo-nazioni è diventata quella di altrettante filiali cui si chiede d'essere sempre e comunque con il bilancio, sia economico che politico, in attivo. Il proletariato internazionale, unica classe a non avere vincoli nazionali materialmente definiti in quanto libera merce forza-lavoro, esportabile ed importabile, dovrà battersi per il disfattismo nazionale ovunque si trovi: dovrà portare la propria guerra rivoluzionaria al cuore della “nazione moderna”, che oggi si esprime economicamente e politicamente nella forma imperialista. Non c’è dubbio che le uova deposte a Versailles un secolo fa si schiuderanno di nuovo: dovrà essere il proletariato con la sua guerra rivoluzionaria e la sua dittatura sul piano internazionale a soffocare sul nascere le loro mostruose creature.
Testi integrativi
Pacifismo? No. Noi siamo fautori della violenza. Siamo ammiratori della violenza cosciente di chi insorge contro l’oppressione del più forte, o della violenza anonima della massa che si rivolta per la libertà. Vogliamo lo sforzo che rompe le catene. Ma la violenza legale, ufficiale, disciplinata all’arbitrio di un'autorità, l’assassinio collettivo irragionevole che compiono le file di soldatini automaticamente all’echeggiare di un breve comando, quando dalla parte opposta non meno automaticamente vengono incontro le altre masse di vittime e di assassini vestiti di un' altra casacca, questa violenza che i lupi e le iene non hanno, ci fa schifo e ribrezzo. L'applicazione di questa violenza militare alle masse di milioni di uomini tolti agli angoli più remoti degli Stati, nelle tremende alternative di questa guerra, non può avere altro effetto che di livragare e soffocare quello spirito di sacrificio e di eroismo a cui potremo domani chiamare i campioni dell’insurrezione proletaria - e che è ben diverso dalla bestiale tendenza a distruggere, ad uccidere finché è possibile, con gli occhi velati dal fumo e dal sangue.
Noi pacifisti? Noi sappiamo che in tempo di pace non cessano dal cadere frequentissime le vittime dell’ingiusto regime attuale. Noi sappiamo che i bimbi degli operai sono falciati dalla morte per mancanza di pane e di luce, che il lavoro ha la sua percentuale di morti violente come la battaglia, e che la miseria fa, come la guerra, le sue stragi.
E di fronte a ciò non è la supina rassegnazione cristiana che noi proponiamo, ma la risposta con la violenza aperta a quella violenza ipocrita e celata che è il fondamento della società attuale. Ma la violenza sacra della ribellione per non essere colpevole sacrificio deve colpire giusto e dare al tronco. Furono ben morti le migliaia di comunardi caduti sotto il piombo dei versagliesi. Ma il mandare al massacro in nome della rivoluzione un milione di uomini, consegnandoli ai dominatori di oggi perché siano impegnati in un'impresa di successo incerto, che trova le sue ragioni in una discutibile e bolsa retorica incosciente e contraddittoria, non si giustifica col dirsi immuni da tenerezze pacifiste, no, perdio, ma è opera insana da macellai impazziti.
E contro essa noi restiamo al nostro posto, per il socialismo, antimilitaristi domani come ieri e come oggi, perché desideriamo al sacrificio delle nostre vite, quando fosse necessario, una DIREZIONE molto diversa.
(da “Il socialismo di ieri dinanzi alla guerra di oggi”, L’Avanguardia, n.359, 360, 362, del 25/10-1/11-16/11/1914)
In nessun caso, senza rinnegare se stesso, il socialismo può rassegnarsi alla concordia nazionale. Questa è condivisa ed esaltata da tutti gli altri partiti sempre che la patria sia in pericolo, anche se per colpa o per volontà del governo statale. Ma tale concordia non può e non deve essere comune a noi quand'anche la causa dell’orribile fenomeno della guerra fosse nella volontà dei governi nemici, magari con la illusa complicità dei loro popoli.
E ben diverso il sacrificio che compiono gli altri partiti da quello che si richiederebbe al nostro. Gli altri hanno nella concordia e nella pace sociale la finalità delle proprie ipocrite ideologie, che mascherano le inconfessabili tendenze delle minoranze dominanti a conservare il privilegio dell’oppressione. Noi siamo invece il partito dell’aperta discordia civile, della proclamata lotta tra le classi, e portare il Socialismo al di fuori di questo campo, sotto pretesti presi a prestito dal mondo avversario, significa ucciderlo.
(da “Socialismo e ‘difesa nazionale’”, Avanti!, 21/12/1914)
Il pacifismo borghese, movimento sterile e per nulla rivoluzionario, può arrestarsi dinanzi alla guerra inutilmente avversata, e ricordarsi solo della necessità di salvare la patria. Ma il socialismo, antimilitarista perché antiborghese, non deve desistere dalla propria azione dinanzi allo scoppio di una guerra, non deve lasciarsi vincolare da scrupoli patriottici. Altre forze, altri fattori sociali, altri partiti pensino alla salvezza della nazione, se a loro è noto il contenuto di quel termine alquanto astratto. Il Partito socialista non ha e non può avere altra missione che quella di salvare il socialismo, tanto più oggi che molti cominciano a pentirsi di averlo dimenticato. Il socialismo italiano, malgrado la triste guerra a coltello di vecchi e nuovi avversari, deve, e saprà - avvenga o non avvenga la guerra -, passare attraverso l'incendio e la rovina tenendo alta la bandiera, sicuro di trovare domani solidali col suo atteggiamento i lavoratori degli altri paesi ridesti dal sonno sanguinoso di distruzione e di strage.
(da “Dal vecchio al nuovo antimilitarismo”, Avanti!, 19/3/1915)
La guerra è decisa. Come più volte avevamo preveduto, si lancia a noi socialisti l’appello ipocrita alla solidarietà nazionale in nome della patria in pericolo.
Noi siamo di quei socialisti che nel loro convinto internazionalismo non lasciano posto per la superstizione della patria. E perciò, se anche credessimo sincero e leale l’appello che ci viene dai nostri nemici di ieri, se anche ritenessimo il governo nazionale innocente della guerra, se anche ammettessimo la buona fede e il disinteresse di tutti i fautori dell’intervento, nonostante tutto ciò resteremmo, in nome dei nostri principi e della nostra fede, tenaci assertori della discordia di classe, che ponendo i servi contro l’oppressione dei padroni è l’unica feconda opera diretta a un avvenire migliore.
(da “Fermi al nostro posto”, Il socialista di Napoli, n.35, 22/5/1915)
Note
1- Questa e le successive citazioni siglate (FM) sono tratte da E. Forcella, A. Monticone, Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, Laterza 1998.
2- J.R Schindler, Isonzo, il massacro dimenticato della grande guerra, Libreria editrice goriziana. 2001, p.175.
3- Fondo Serrati, lettera del soldato Ettore Barbarisi, nota 15, p.105, in L. Del Boca, Grande guerra, piccoli generali, UTET, 2011, p.105-106.
4- In M. Magli (a cura di), Fucilazioni di guerra, Nordpress, 2007, p.110.
5- Forcella, Monticone, op. cit., p. XCVII.
6- http://www.remtechnology.net/giustizia%20militare.htm
7- Forcella, Monticone, op. cit., p.C.
8- M. Magli, op. cit., p.139.
9- Il compagno evitò la condanna a morte grazie alla concezione caporalesca delle relazioni umane propria dei giudici militari che riconobbero al "traditore" l'attenuante di aver agito "perché, come affigliato al Partito socialista, e come tale schiavo dei caporioni suoi, che purtroppo rimangono nell'ombra e quindi nell'impunità, non ha avuto la forza di non ottemperare alle istruzioni malsane a lui date" (FM, p.117).
10- Storia della sinistra comunista, Vol. I, p.112-113.
11- Del Bianco, La guerra e il Friuli. Sull’Isonzo e in Carnia. Gorizia. Disfattismo, Udine 1939.
12- J.R Schindler, op. cit., p. 462.
13- Storia della sinistra comunista, Vol. I, cit. p.92.
14- John Keegan, La prima guerra mondiale. Una storia politico-militare, Carocci ed. 2000, p.378.
15- Storia della sinistra comunista, Vol. I, p.114.
16- L.Del Boca, op. cit., p.205-206.
17- Storia della sinistra comunista, Vol. I, p.113-117.
18- Storia della sinistra comunista, Vol. I, p.94.
19- Storia della sinistra comunista, Vol. I, p.114.
Partito Comunista Internazionale
(il programma comunista n°03-04 - 2014)