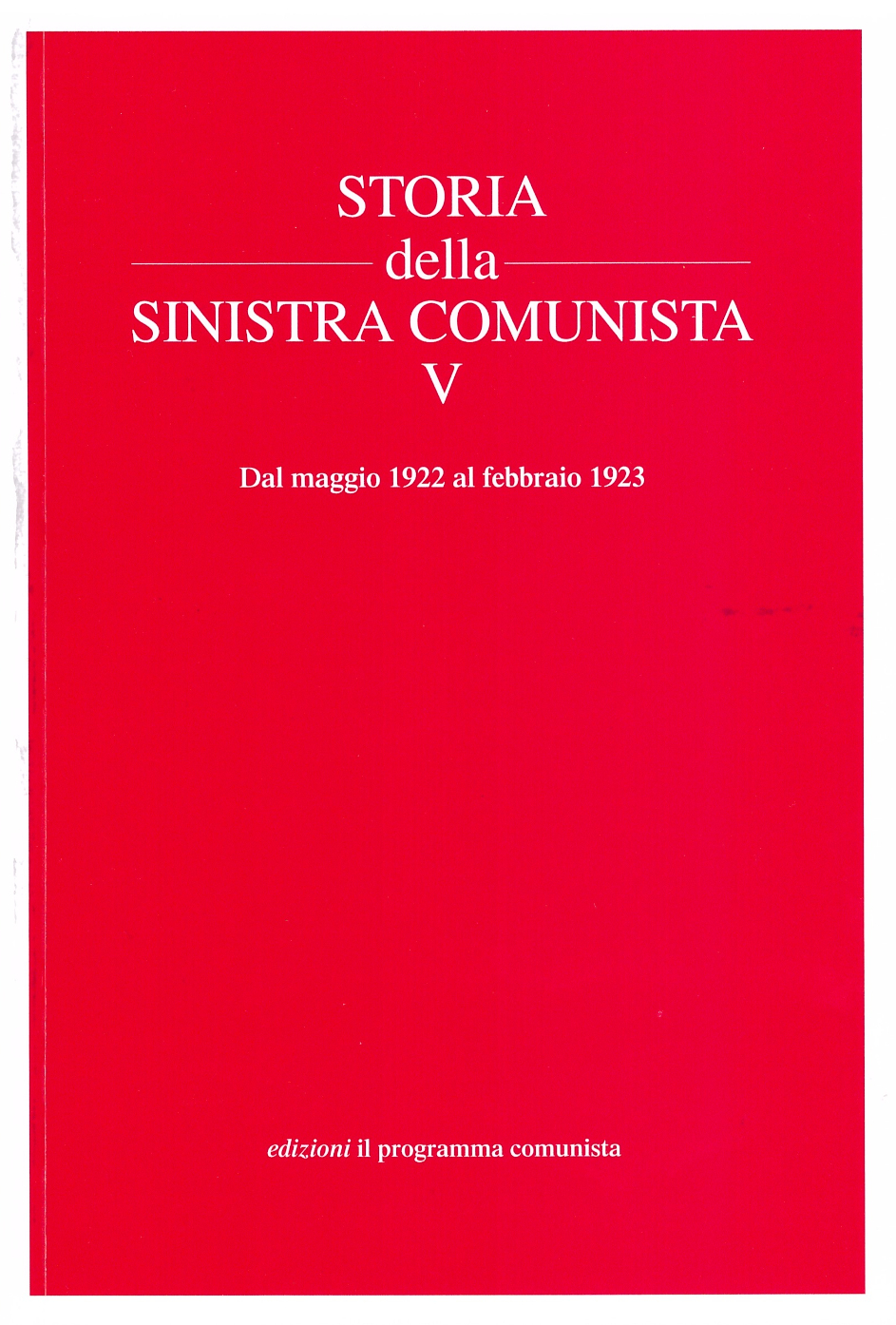Il genocidio perpetrato dallo Stato d'Israele ai danni dei proletari della Striscia di Gaza e dintorni (e lasciamo per il momento da parte le “imprese” dei “coloni” israeliani sostenuti dal loro esercito in Cisgiordania) non ha fatto “soltanto” 60mila o, secondo alcuni studi al di sopra delle parti, 100mila morti. Quanti saranno i morti futuri per le conseguenze di ferite invalidanti, per l'impossibilità di sopravvivere senza braccia o gambe, di ricevere cure adeguate a patologie preesistenti o sviluppatesi in tutti questi mesi di massacro incessante oppure destinate a presentarsi nel prossimo futuro, a fronte di strutture ospedaliere decimate? Oppure, molto più crudelmente, per la nuda fame, la nuda denutrizione?
Il genocidio ha molte facce. La devastazione fisica, materiale, abbattutasi da cielo, terra e mare, su città, villaggi e campagne, sempre più rende e renderà invivibile la quasi totalità della regione: come si potrà sopravvivere fra gli scheletri traballanti delle poche case rimaste in piedi, lungo strade cancellate dai bombardamenti, tra cisterne e acquedotti inariditi e inservibili, reti fognarie disastrate, centraline elettriche esplose, su terreni resi inabitabili da mine anti-uomo, proiettili radioattivi, avvelenamento del suolo e del sottosuolo?
E ancora. Un articolo uscito su Le Monde del 25/6 c'informa che “più del 95% delle terre agricole” è stato danneggiato o distrutto: non esistono più cetrioli, pomodori, angurie, meloni, patate, fragole – vale a dire, quel 10% dell'economia (per lo più di sussistenza) ancora permessa dalla spietata persecuzione israeliana. “Più di 500mila palestinesi – c’informa l’articolo – vivevano unicamente della produzione agricola, dell'allevamento e della pesca. In aprile [2025], solo il 4,6% della superficie totale delle terre agricole (688 ettari) risultava ancora coltivabile e accessibile, secondo un'analisi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione e il Centro satellitare dell'ONU (Unosat), pubblicato il 26 maggio”. L’analisi precisa che questo livello di distruzione “non implica solo una perdita di infrastrutture: è il crollo del sistema agroalimentare e delle possibilità di vita a Gaza. Le terre coltivate, le serre, i pozzi sono stati distrutti, e di conseguenza la produzione alimentare locale s'è fermata”.
Inoltre, quasi il 95% del bestiame grosso e più della metà dei greggi di montoni e capre sono stati annientati, e solo un'assoluta minoranza di pescatori riesce ancora a uscire in mare, con piccole imbarcazioni a remi e tenendosi il più possibile vicino a riva per paura d'essere intercettati e colpiti dai droni o mitragliati a morte dalla marina militare israeliana (come è successo ad almeno 210 di loro nei mesi scorsi): la costa di Gaza è considerata infatti dall’esercito israeliano “zona di combattimento”. Già a partire dal 2002, ricorda sempre Le Monde, la zona di pesca era stata ridotta da 20 miglia marine a 6: “Lungo la costa di Gaza, i pescatori si concentravano in cinque luoghi. Quello più a sud, a Rafah, è stato raso al suolo insieme alla città. Nell'estremo nord della Striscia, non rimangono più né barche né infrastrutture”. Nella città di Gaza, dove lavorava una buona metà dei pescatori e si trovavano almeno due terzi delle imbarcazioni, riporta una testimonianza rilasciata al giornale, già “il quarto giorno della guerra le forze d'occupazione hanno bombardato il porto con i loro F-16, spaccandolo in due e scavando un cratere di circa 20 metri”: battelli, conservifici, mercato ittico, tutto devastato, e da tempo risultano inservibili gli allevamenti di pesci. Si tratta, insomma, d'impedire ai pescatori di garantire i bisogni alimentari degli abitanti della Striscia.
Anche ammettendo che si possa giungere, prima o poi, a una tregua (una tregua che però, è bene averlo chiaro in mente, potrà solo essere provvisoria), che razza di ricostruzione sarà mai possibile a Gaza e dintorni, subordinata come sarà, oltre tutto, ai sanguinari appetiti di tutti gli imperialismi, vicini e lontani? Quanti decenni saranno necessari per restituire a quel luogo insanguinato una parvenza di vita?
Nel frattempo, altre migliaia di proletari palestinesi saranno morti e, i quelli sopravvissuti a stento, a migliaia avranno cercato rifugio altrove (ma dove?). In questo incerto altrove dovranno comunque incontrare i loro fratelli di classe, il proletariato internazionale e, stretti a esso, ricordare e vendicare i propri morti riprendendo la strada della guerra di classe (classe contro classe, e non Stato contro Stato o Patria contro Patria!), combattendo il mostruoso nemico di sempre che è il capitalismo, reso ancor più selvaggio e assetato di sangue dalla sua fase imperialista.
luglio 2025
Ultim’ora. Mentre chiudiamo questo numero (metà settembre), il genocidio ha imboccato la strada della “soluzione finale”. La città di Gaza viene rasa al suolo, a centinaia i proletari palestinesi vengono massacrati da ogni tipo di sofisticata macchina di annientamento. Intanto, assistiamo alla ributtante pantomima della complicità di tutti gli Stati, strumenti di tutte le borghesie, da quelle arabe locali a quelle occidentali (Stati Uniti in testa), che nello Stato d’Israele hanno da sempre visto un proprio partner commerciale privilegiato e un necessario gendarme armato a difesa di un’area preziosa per gli interessi capitalistici mondiali; e dell’ipocrita balbettio di tutti gli organismi internazionali nati nel secondo dopoguerra per assicurare il “radioso avvenire” del regime capitalistico, che oggi dimostrano non solo la propria inutilità, ma l’eterno ossequio alla legge del più forte e degli affari innanzitutto. Questo dev’essere il momento, non solo della rabbia e della mobilitazione (lo è sempre stato!), ma anche della comprensione reale e profonda di che cosa ha rappresentato quest’ennesimo capitolo della ferocia imperialista, incarnata in questo caso dallo Stato d’Israele – il momento di un bilancio impietoso di tutte le dinamiche sviluppatesi fin dal maledetto 1948, drammaticamente chiuse dentro a un carosello di nazionalismi contrapposti, di sanguinarie faide religiose, di biechi interessi, localistici e non. Soprattutto, dev’essere il momento di un ritorno teorico e pratico a un’analisi classista di eventi che già preannunciano e pre-disegnano gli scenari di un nuovo macello mondiale: il ritorno a un vero internazionalismo proletario e, di conseguenza, a un disfattismo rivoluzionario che combattano apertamente ogni cancro nazionalista e patriottardo.