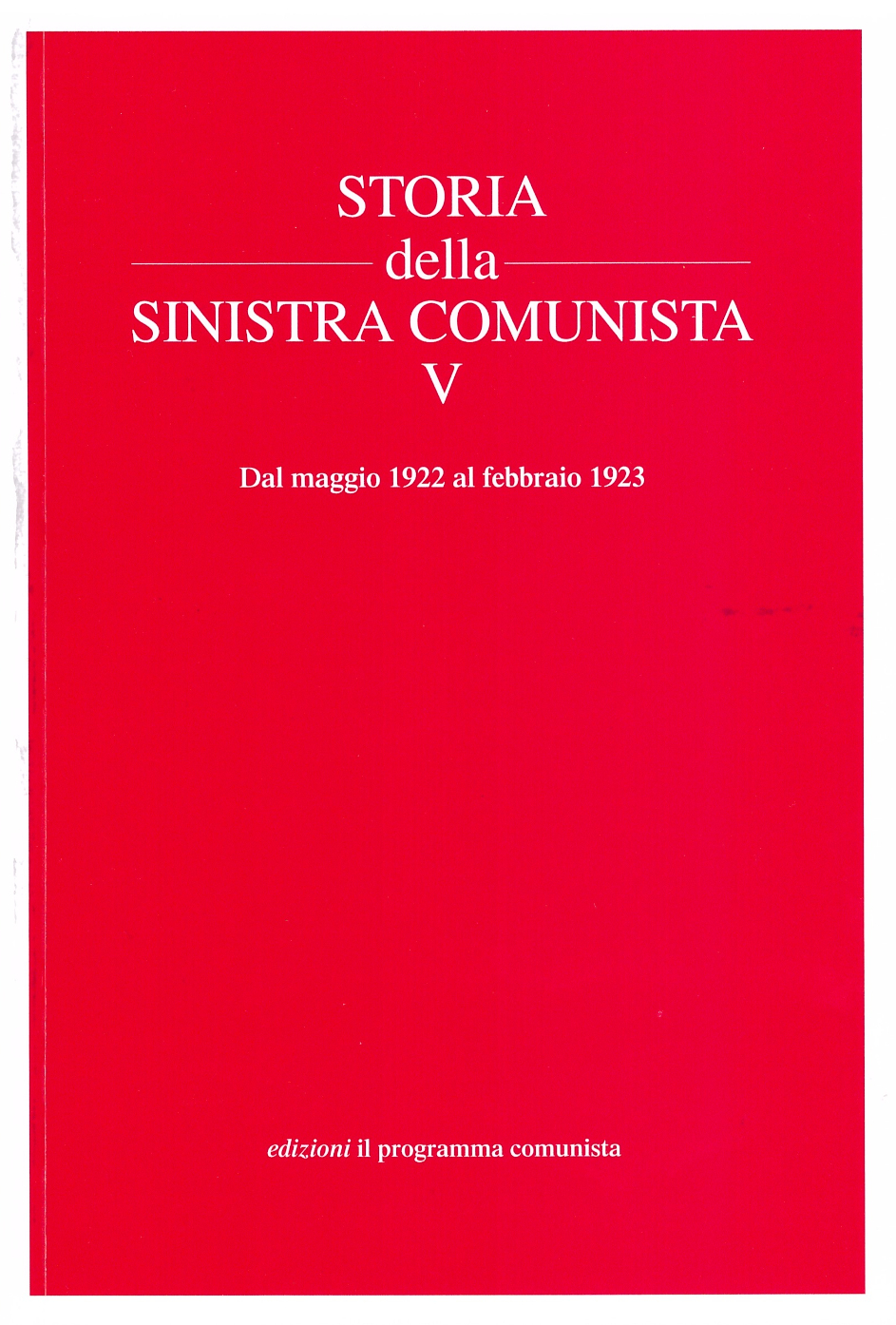A cinquant’anni dalla tragedia cilena, riproponiamo due articoli usciti allora sulla nostra stampa: uno pochi giorni prima, l’altro pochi giorni dopo la caduta del governo Allende. Perché quegli insegnamenti non vadano dimenticati.
Si tragga da Allende almeno una conferma sulla necessità della violenza e del terrore
Da quando Allende è salito al “potere” in Cile, per l’opportunismo – di tutti i colori e di tutti i Paesi – il suo esperimento avrebbe dovuto rappresentare una conferma, anzi la schiacciante dimostrazione, della possibilità di una pacifica instaurazione del socialismo. Da lui si attendeva, insomma, la solenne smentita del “catastrofismo rivoluzionario”, e perciò la rivincita del gradualismo socialdemocratico.
La tesi era già sballata in partenza: nessuno dei progetti – e nessuna delle sue traduzioni in pratica – di Allende era o poteva essere “socialista”; erano tutti provvedimenti non solo compatibili con la sopravvivenza del modo di produzione capitalistico e con le sue sovrastrutture politiche, sociali, giuridiche, ma destinati a consolidarne le basi liberandole dai ceppi di una economia arretrata e di una società corrispondentemente inadatta al pieno sviluppo delle forze produttive moderne – una timida “riforma agraria”, una serie limitata di “nazionalizzazioni” contro indennità, un tentativo (mezzo e mezzo, data la potenza degli interessi costituiti) di svincolarsi dalla pesante sudditanza diretta a compagnie industriali e commerciali nord-americane, e non certo dal mercato mondiale in cui il Cile trova il suo polmone. Non si “instaura” il socialismo “in un solo paese” e, anche dato (ma non concesso) che le misure prese o preventivate dal governo Allende potessero definirsi socialiste, la loro radicalità presupponeva, nell’essere spinta a fondo e non restare in superficie, una reale presa del potere, che significa rottura dello status quo, privazione di ogni diritto politico alle classi possidenti – borghesia in senso proprio, proprietà fondiaria tradizionale, eccetera – , distruzione dell’intero apparato statale esistente, dittatura di un partito rivoluzionario unico; tutte condizioni che contraddicevano al programma, alle finalità, alla base sociale dell’eterogeneo raggruppamento politico allendista.
Si può concedere che, in un paese con un piede solo nel capitalismo pieno come il Cile, le prime misure dispotiche di un governo rivoluzionario degno del nome di marxista (e quello di Allende non pretende neppure di esserlo, anche se ai giornalisti e a chi li foraggia fa comodo di presentarlo come tale) siano forzatamente caute e “progressive”, a condizione tuttavia che siano appunto dispotiche, cioè non vincolate a nessuna legge, a nessun diritto costituito, meno che mai a diritti di proprietà. La dittatura proletaria non può non essere gradualista in economia; ma il suo è necessariamente un gradualismo radicale che presuppone il rivoluzionamento di tutta una rete di rapporti economici e sociali, quindi l’anti-gradualismo sul terreno dei rapporti di forza delle classi, e dunque del potere. Tolta questa conditio sine qua non, un governo “operaio” può definirsi come meglio gli garba, ma non costruisce nemmeno le basi del socialismo normale: si muove sul terreno classico di un timido e irrisorio “raddobbo” del regime esistente.
Ma il letto di Procuste in cui si dibatte come un malato in preda alla febbre il governo Allende dimostra qualcosa di più: nemmeno una vigorosa spinta innanzi del capitalismo (giacché tale, e nulla di diverso né di più serio, vuol essere il governo di “Unità Popolare” cileno) è possibile nel quadro del rispetto della legalità di fatto: o questo tentativo assume le forme del giacobinismo, della radicalità rivoluzionaria plebea, del terrore “sanculotto”, del “comitato di salute pubblica”, insomma della violenza esercitata per spezzare i vincoli che ancora tengono stretto il “paese” al suo passato pre-capitalistico e, per quello che può sembrare un paradosso solo agli orecchianti in marxismo, alla pressione mondiale dell’imperialismo pascolante proprio sull’arretratezza delle strutture economiche e delle sovrastrutture politiche; oppure, se ciò non avviene, esso è condannato al fallimento perfino nei suoi obiettivi circoscritti anche se storicamente necessari e fecondi.
Così trionfarono le borghesie inglese e francese; così, benché con altre potenzialità ma con mezzi non per questo meno brutali, trionfarono le borghesie affacciatesi in ritardo in Europa o in continenti extra-europei freschi di colonizzazione capitalistica (è quest’ultimo il “segreto” di Mao). Esse non restarono sulla difensiva: attaccarono. Si crearono una loro legalità distruggendo ogni legalismo: non si inchinarono di fronte al diritto costituito e ai suoi difensori secolari o “spirituali”. Allende, questo “presidente costituzionale” che il pennaiolismo mondiale sfrontatamente classifica fra i discendenti di... Marx, non è il lontano pronipote neppure di Robespierre; che diciamo?, neppure di Lafayette o del girondino Brissot. Egli non può vantare in tutta la sua carriera di capo dello Stato che una serie di ritirate, di rinunce, di capitolazioni: oggi, ha nella sua barca consunta gli uomini – nella migliore delle ipotesi – dell’“equilibrio”, i generali indispensabili per mantenere l’“ordine”, cioè per frenare lo scoppio, necessario e auspicabile, dei conflitti sociali; tratta con la DC; “sfida” solo per burla gli autotrasportatori; subisce in altra forma quella pressione dell’imperialismo, tramite le ferree leggi del mercato mondiale, che aveva preteso di eludere a colpi di innocui decreti; si lascia terrorizzare, invece di praticare il terrore; è prigioniero delle forze che, per definizione, non poteva attaccare senza cessare d’essere se stesso; e se perverrà alla necessità di impiegare il terrore, lo farà soltanto per conservare le riforme moderate e non per imporre la trasformazione dei rapporti sociali in senso borghese-radicale.
La lezione è chiara e, come al solito, ci viene dallo stesso modo di produzione e di vita associata in cui riconosciamo il nostro nemico: perfino per spalancare le porte a una evoluzione pienamente capitalistica, la violenza è necessaria; se non vi si fa ricorso, trionfa la contro-violenza – che è sua sorella, anche se di segno opposto. La legalità uccide: le borghesie consapevoli della loro storica missione l’hanno saputo e lo sanno. L’allendismo è al di sotto della stessa coscienza rivoluzionaria borghese.
I proletari, loro, devono assurgere alla coscienza che quanto è stato ed è vero per le borghesie rivoluzionarie, lo è mille volte di più per la classe che esse opprimono e ingannano, anche là dove le premesse economiche del socialismo non esistono ancora o esistono solo per metà.
(da Il programma comunista, n.6 del 30 agosto 1973)
Nessuna classe può vincere senza rivoluzione violenta, nessuna può conservare il potere senza dittatura e terrore
La tragedia cilena risolleva con asprezza tagliente l'aggrovigliata questione del corso e del destino storico dei paesi nei quali le lotte di un proletariato non molto numeroso né molto concentrato – ma combattivo nella stessa misura in cui si accumulano, s'intrecciano e si moltiplicano le contraddizioni economiche e gli antagonismi sociali propri di quelle aree – e di un piccolo e piccolissimo contadiname misero e disperso, si svolgono sullo sfondo del tenace persistere di rapporti di proprietà e di gestione arcaici nelle campagne, del tardo e fragile impianto di un'industria capitalistica nelle città, della mano pesante dell'imperialismo che di quella arretratezza e di questa fragilità è insieme il beneficiario e un fattore, e sotto la nefasta cappa di piombo della controrivoluzione, socialdemocratica e stalinista, mondiale.
La prospettiva marxista del 1848 e 1850
Nel Manifesto del 1848, Marx ed Engels delineano per i paesi, come la Germania, che sono “alla vigilia della rivoluzione borghese” e la compiono “in condizioni di civiltà generale più progredite e con un proletariato molto più sviluppato che non avessero l’Inghilterra nel secolo XVII e la Francia nel secolo XVIII”, un ciclo storico attraverso le cui fasi, mai tappe in sé concluse ma sussulti giganteschi di un'unica reazione a catena, il modo di produzione capitalistico e le sue sovrastrutture politiche e giuridiche eromperanno spezzando violentemente l'involucro feudale che tiene ancora imprigionate le forze produttive, consolideranno il loro dominio, spazzeranno via gli ultimi relitti del passato e – loro malgrado – schiuderanno le porte alla rivoluzione proletaria. Il nocciolo di questa visione, nella cui sequenza la grande borghesia soppianta una feudalità sopravvissuta a se stessa, la piccola borghesia radicale ne raccoglie le bandiere frettolosamente ammainate e le porta un altro passo avanti nell'opera di sgombero delle strutture arcaiche, la classe operaia già sua alleata la prende alla gola innestando la propria rivoluzione sul tronco dell'altrui, per seppellirla sotto il suo peso; il nocciolo di questa visione non è la rapidità più o meno grande del suo snodarsi successivo, ma da un lato la sua necessità e irreversibilità materiale, dall'altro il carattere violento, esplosivo, catastrofico, di ognuno dei suoi trapassi: alto su tutti, per terrificità di potenziale rivoluzionario, l'ultimo, quello proletario e comunista.
La sconfitta del 1848 non altera il quadro nei suoi tratti necessari, ma – come nel bilancio redatto da Marx ed Engels due anni dopo, nell'Indirizzo alla Lega dei Comunisti – riduce il potenziale eversivo della seconda fase aumentando nella stessa misura il potenziale rivoluzionario della terza. Salita al potere, ma terrorizzata dalle forze sociali tumultuante che ha messo in moto e alla cui fiera determinazione di combattere o morire deve la vittoria, la grande borghesia capitalistica si è rifugiata in una rinnovata alleanza col “partito feudale assoluto”: è la piccola borghesia repubblicana, pronta a chiamarsi “rossa” e “democratico-sociale”, a raccoglierne malamente l'eredità nella pavida ricerca di una via costituzionale ad una trasformazione della società vigente che la renda, per lei e per i suoi alleati (i contadini), “più comoda e tollerabile”. Rifiutandosi di decadere ad “appendice della democrazia ufficiale”, stretto in “organizzazione indipendente, segreta e pubblica”, dotato di armi proprie, deciso “a rendere il più che possibile difficile, e a compromettere per quanto sta nelle sue forze il momentaneo ed inevitabile dominio della democrazia”, diffidente non più verso “il vinto partito reazionario, ma verso i propri alleati di ieri”, il proletariato – che in tutto il processo ha agito di stimolo costante per “portarlo fino in fondo” – risalirà sulle barricate al grido della “rivoluzione in permanenza”, pronto a caricarsi sulle spalle i compiti economici borghesi lasciati inadempiuti dalla democrazia cosiddetta radicale e, “in coincidenza con la vittoria diretta della classe operaia in Francia”, ad affrettare il “lungo processo rivoluzionario” di ascesa al potere e di soddisfazione dei propri esclusivi interessi, sulle macerie – borghesi non meno che pre-borghesi – del passato.
E tuttavia, anche in questo ciclo a energia assopita nella parte intermedia e ridotta a zero nella prima, non c'è fase che non si tinga del rosso del sangue: l'evoluzione non prende mai il “corso pacifico” che pure è nei sogni della grande borghesia, fresca dell'aver scaricato sulla controrivoluzione feudale l'odiosità delle “misure di violenza” e non d'altro ansiosa che di goderne in pace, persino fra il coro osannante delle plebi, i frutti copiosi: come anche è nei sogni della piccola borghesia costituzionale, per “avanzati” che ne siano i programmi. Non lo prenderà: la missione storica lasciata a mezzo dalla democrazia radicale verrà assolta da borghesi e junker uniti – col pugno di ferro di Bismarck e il rullo compressore delle armate di Moltke. Mezzo secolo dopo, la classe operaia tedesca insorgerà allo storico grido, e sarà sconfitta. Il gigantesco “film” del '48-'50 verrà girato fino all'ultimo, fino all'epilogo smagliante dell'Ottobre – protagonista il proletariato – in Russia.
Ritardo e fragilità del “decollo” capitalistico nel Cile
Se c'è un'“originalità” nell'ascesa borghese e capitalistica in Cile e, in genere, nell'America del Sud, essa sta nel fatto – dovuto a cause non certo... etniche, ma duramente materiali – che l'arco storico previsto da Marx e da Engels nel 1850 vi si è svolto non solo al rallentatore, ma ad ancor più bassa energia che nell'Europa centrale del secolo scorso [il XIX] e degli inizi dell'attuale [il XX].
Gli squilli della storiografia idealistica celebrano l'avvenuta “formazione dello Stato nazionale” in Cile oltre centocinquanta anni fa, prima della corrusca Germania, prima della ruffianesca Italia. Ma l'episodio è talmente formale, così privo di contenuto, che i rapporti di proprietà tradizionale e le forme di gestione aziendale arcaica in un Paese totalmente agricolo ed esportatore di materie prime vegetano ancora per cent'anni, pascolo ubertoso prima dell'imperialismo inglese affamato di derrate alimentari e di salnitro, poi dell'imperialismo americano affamato di rame ed esportatore di derrate alimentari là dove un tempo queste si esportavano. Su questo telone grigio, antidiluviano, la democrazia, “una delle prime del mondo” (si è scritto con orgoglio in questi tempi di senilità borghese), proietta il sul film... pubblicitario: dietro le quinte, pietrificato in una squallida esistenza da semi-colonia anglosassone, dorme un sonno non turbato che da bruschi ma passeggeri sussulti, il latifondo.
Bisogna aspettare il primo dopoguerra perché un esile filone di industrialismo capitalista metta radici: ma non va oltre l'industria leggera, presenta un settore dominante di imprese piccole e medie, vivacchia sulle strutture agrarie anchilosate senza intaccarle oltre la superficie, paga agli USA, nel prezzo del rame “nazionale”, la rendita mineraria, geme e suda sotto il peso dei debiti esteri, dà il benvenuto – bestemmiando – al capitale yankee e alle sue ed altrui “società multinazionali”. Non c'è capitalismo industriale senza mercato interno; non c'è mercato interno degno di questo nome senza rivoluzionamento dei rapporti di proprietà e di produzione nelle campagne, e questi, sotto la vigile scorta dell'imperialismo, sopravvivono – in una decadenza che ne aggrava l'improduttività e funge da ulteriore inciampo all'erompere delle forze produttive. L'agricoltura cilena è tutt'oggi in alto grado di mera sussistenza, i suoi prodotti non raggiungono il mercato. I momios (mummie, cioè i grossi agrari), certo, campano altresì di usura, di transazioni commerciali, di speculazioni in titoli (esteri, che diavolo: la patrie au fumier! nel letamaio la patria!): i nostri Gattopardi ne sanno qualcosa. Soprattutto campano su quell'imperialismo che insieme li protegge e li asfissia – decadenti sono, ma “organizzati”: hanno le loro guardie bianche, i loro reparti dell'esercito (altra gloria della storiografia idealistica in questi giorni di Beozia: “il solo esercito rigorosamente costituzionale dell'America del Sud”, chissà come e perché bruscamente convertitosi alla “incostituzionalità” nel cambio della guardia dal generale Prats a Pinochet), le compiacenti batterie da marina e da... Borsa degli Stati Uniti. Ma tutto ciò non cambia la fisionomia sociale della classe; ne aggrava, semmai, il parassitismo.
È sotto il pesante fardello di quest’arretratezza cronica nelle campagne e del suo “congelamento” ad opera dell’imperialismo già inglese, poi americano, che arranca la borghesia industriale, ansiosa di liberarsene, divisa tra il desiderio di scrollarsi di dosso la palla di piombo del latifundio-minifundio e il fardello dei debiti verso l’estero e della rendita mineraria da un lato, e il bisogno di solidi appoggi finanziari yankee dall’altro, terrorizzata dalle forze che essa stessa e l’evolvere mondiale del capitalismo evocano e gettano sull’arena politica e sociale: i piccoli e piccolissimi contadini assetati di terra, i salariati d’industria e, per quel tanto che esistono, dei campi, spremuti sotto la macina di una lenta e tanto più gravosa accumulazione originaria.
Quello che gli ideologi borghesi chiamano il “potere”, e che per noi è soltanto il governo, passa negli anni ’60 nelle mani della “gracile” borghesia industriale stretta intorno alla Democrazia cristiana: visto alla luce della drammatica sequenza delle rivoluzioni borghesi – non “inventata” ma registrata da Marx ed Engels – , il trapasso dovrebbe essere violento, e non lo è: è pacifico, parlamentare, democratico. L’“epopea” della “formazione dello Stato nazionale” aveva avuto il suo Bolivar: la batracomiomachia dello slancio capitalistico-industriale non ha neppure l’ombra remota di un Cromwell, non diciamo di un Saint-Just o di un Robespierre, non diciamo nemmeno di un Washington o di un Bismarck; per restare in “ambiente”, di un Mao; per non chiedere troppo, di un Castro. Né patibolo, né ghigliottina, né cannoni accompagnano la marcia tutt’altro che eroica della borghesia “progressista”; le sue armi non sono gli “interventi dispotici” il cui esempio le borghesie rivoluzionarie lasciano in non voluta eredità ai proletari perché le rivolgano contro esse stesse, ma i pezzi di carta di innocui decreti parlamentari: il vecchio apparato statale rimane intatto; l’esercito “serve” e tace (il silenzio è d’oro!); la riforma agraria di Frei, che contempla l’esproprio contro indennizzo delle terre scarsamente produttive al di sopra degli 80 ettari per assegnarle ai contadini (insieme, e spesso in maggior misura, a terre demaniali), non solo non si realizza che in minima parte (e del resto, quand’anche andasse n porto, interesserebbe poco più di un quinto del territorio agricolo), ma, mentre permette agli ex proprietari – che fra parentesi hanno già provveduto a disfarsi del bestiame – di investire i quattrini ottenuti in rimborso in più redditizie imprese commerciali o industriali, non riesce né a fissare al suolo se non un piccolo strato di coltivatori privi di un minimo attrezzature né, appunto per ciò, a impedire che il già elevatissimo tasso di inurbamento salga alle stesse; l’indebitamento verso l’estero sia per gli approvvigionamenti alimentari ognor più deficitari che per gli indispensabili beni strumentali, tocca punte vertiginose; infine, la borghesia industriale “al potere” non osa neppure quella nazionalizzazione delle miniere di rame (prezioso bene di grandi compagnie USA) che, in teoria, dovrebbe sollevarla dal peso... e dall’onta della rendita mineraria codardemente subita. Ci vuol altro, per un serio “decollo” dell’industrializzazione capitalistica!
Urge dunque un “passaggio di mano”, e a chi – data la presenza di un proletariato il cui peso specifico è superiore a quello della Germania 1850, e di un piccolo contadiname riottoso, famelico di pane e di terra; due classi che si tratta insieme di utilizzare per una politica un po’ meno guardinga e rispettosa, e di contenere nelle loro periodiche esplosioni di impazienza – se non a un amalgama di radicali piccolo-borghesi, intellettuali “anti-imperialisti”, socialdemocratici, “comunisti”-nazionali ed altre frange più o meno “ribelli”? Nello schema classico, la separazione dell’ala “democratico-progressista” dal corpo della borghesia, assume, almeno alle origini, aspetti di rottura: nella sua edizione cilena, è un passaggio di poteri non solo indolore ma ultra-conformista, benedetto dal responso dell’urna e sancito dalla sovrana maestà della legge: esce un presidente, se ne fa un altro. Già tutto combinato, prima della “consegna”: in forza dello “statuto delle garanzie” sottoscritto dalla Democrazia cristiana e dall’Unione popolare (UP), “noi [cioè, l’una e l’altra, grossa borghesia industriale e democrazia piccolo-borghese] vogliamo uno stato di diritto senza interferenze di altri organi di fatto che agiscano in nome di un sedicente potere popolare [mani avanti: non vogliamo, chissà mai, neppure lo spettro dei soviet]... Vogliamo che le forze armate e i corpi di carabinieri [i futuri eroi del “golpe”] continuino ad essere una garanzia del nostro ordine democratico, il che implica il rispetto delle strutture organiche e gerarchiche dell’esercito e della polizia [...] a salvaguardia del regime di proprietà e del funzionamento dei mezzi di informazione”!
Da Frei ad Allende
C’è di più (ed è il peggio!). Nello schema classico, consegnato alla storia nell’Indirizzo di Marx-Engels, sul pavido corso della democrazia radicale veglia dall’esterno, spingendolo avanti, forzandolo a misure sempre più energiche, obbligandolo non solo a “mantenere le promesse” ma a rincararne via via la dose – “alleata” scomoda, mai serva e neppure amica conciliante – la classe operaia “armata e organizzata in modo indipendente”. Nella versione cilena, il proletariato è guidato dalla controrivoluzione socialdemocratica e staliniana a camminare a rimorchio della nuova costellazione popolare, di cui condivide le responsabilità di governo: non indipendente ma subalterna; non armata ma sottomessa al solo potere in armi, l’esercito di Stato; non pungolo ma freno; non decisa “a mettere avanti la questione della proprietà, abbia essa raggiunta una forma più o meno sviluppata [ed è il “meno” che predomina sul “più” in Cile] come la questione fondamentale del movimento”, ma forzata a proteggere i rapporti di proprietà “legittimi”; non spinta a cavalcare i limiti dell’ordine costituzionale vigente ma costretta a osservarli. Già pavida, irresoluta, tentennante di fronte all’intero spettro delle classi dominanti e dell’imperialismo, la democrazia “radicale” di Allende non trova neppure alla sua estrema periferia la forza propulsiva, insistente, perennemente critica, gagliardamente in armi, del proletariato – a tal punto imperialismo USA e controrivoluzione nel segno di Stalin convergono, perfino nell’impedire la “modernizzazione delle strutture economiche e sociali” in senso pienamente borghese!
In questo incrocio di imbelle pacifismo interno e della sudditanza a poderose forze esterne di conservazione sociale (due smentite in una volta sola: niente via pacifica! niente via nazionale!), è la chiave del ciclo radical-democratico del “decollo capitalistico cileno” – di un regime statisticamente popolare e perfino plebeo, ma organicamente incapace di audacia sanculotta; che elude la violenza solo per subire la violenza; che rifugge da misure dispotiche solo per capitolare di fronte al dispotismo; che non attacca solo per precludersi la stessa difesa; che venera la legge e l’ordine solo per ritrovarseli davanti sulla bocca delle mitragliatrici e dei cannoni; che predica la pace solo per attirarsi la guerra. Come può, un amalgama di questo genere, affondare il bisturi nel corpo malato dell’economia e della società cilena?
La nuova riforma agraria porta un passo avanti quella di Frei, ma non ne modifica il corso: applicata per “tappe”, rispettosa dei diritti di proprietà – del suolo oltre che delle macchine e del bestiame – , essa lascia ai proprietari fondiari il tempo e il modo sia di sfuggirle sia di sabotarla aggravando il marasma del vettovagliamento delle città; crea delle cooperative agricole, ma di soli inquilinos, e lascia al margine i contadini poveri e la grande massa dei lavoratori stagionali senza terra; non mette freno, perché non da ai piccoli e piccolissimi coltivatori i mezzi e gli strumenti materiali necessari, né alla peste cronica dell’inurbamento né a quella del costante declino della produttività; nata e cresciuta all’insegna della legge, condanna non solo nelle parole ma negli atti – cioè con la repressione poliziesca – l’occupazione “illegale”, anche sporadica, delle terre: “Occupare le terre – risponde Allende a un delegato spintosi incautamente fino a insinuare che solo la mobilitazione dei contadini è in grado di paralizzare il quotidiano sabotaggio degli “agrari” – è violare un diritto”, e aggiunge, con parole che oggi hanno un sapore tragico: “E i lavoratori devono capire di far parte di un processo rivoluzionario che noi stiamo realizzando con un minimo di sofferenze, con un minimo di morti, con un minimo di fame”! (citato in Labrousse, L’experience chilienne).
L’UP interviene, certo, nell’attività industriale ampliando il settore misto e nazionalizzato, introducendo il controllo del credito, riunendo nelle mani dello Stato le diverse branche destinate a concorrere alla formazione dell’industria pesante, e infine incamerando il 49% del capitale minerario lasciato da Frei alle compagnie americane Anaconda e Kennecott durante il primo turno, pacifico e legalitario come il secondo, di nazionalizzazioni per decreto-legge. Lo fa, e lo paga caro: non solo con l’impegno ad assumersi il rimborso della prima metà del capitale investito nelle miniere, ma con il riconoscimento di un debito estero accumulato oscillante sui 3,8 miliardi di dollari e con il rifiuto dell’istituzione del monopolio del commercio estero, e più ancora con la precipitosa caduta delle quotazioni del rame sul mercato mondiale. Servile verso la grande borghesia industriale, codardo verso la piccola borghesia commerciale e bottegaia, trepidante per le “selvagge” impennate di contadini senza terra e di operai scioperanti lungo la... via del socialismo, rispettoso dei sacri impegni verso i creditori imperialistici come verso i proprietari fondiari assenteisti, ma fiero di avere con sé al governo socialisti e “comunisti” e di aver scoperto una via originale, senza vittime né sofferenze, non per abbattere ma per trasformare dall’interno l’ordine sociale borghese: questo è stato il regime di Allende, il regno senza corona della democrazia piccolo-borghese, il paradiso dei radicali incapaci di “andare alle radici”.
Il senso del sanguinoso epilogo
È legge storica che non si può soddisfare quel caleidoscopio di classi e sotto-classi che si chiama il “popolo”, senza scontentare e infine alienarsi, l’una dopo l’altra o tutte insieme, le parti componenti del confuso mosaico, anche quelle sul cui appoggio si contava perché si era eretto su di esse il proprio piedestallo. Le mezze misure – in un processo storico in cui o tutto si vince o tutto si perde – si ritorcono contro chi le prende, peggio che se neppure le avesse prese. I “provvedimenti dispotici” che ogni processo di scardinamento di strutture arcaiche o non più vitali impone non sono il prodotto di una scelta: sono un comando della necessità, una legge di vita. Chi predica pace riceve guerra; chi semina il disarmo politico e organizzativo delle sue stesse forze portanti raccoglie la tempesta delle armi nemiche; chi s’inchina alla legge provoca la legge che altri si dà; chi invoca ordine muore sotto l’uragano del “disordine”; chi “previene gli eccessi” dei suoi sostenitori si attira quelli degli avversari; un governo che si pretende rivoluzionario e non mette fuori legge i partiti che incarnano il passato e il presente da rivoluzionare prepara il terreno alla propria distruzione.
Dallo sciopero degli autotrasportatori alla defezione democristiana, dal sordo rancore contadino al malcontento bottegaio, dai giri e rigiri dell’esercito “leale” alla pressione incalzante benché nascosta dell’imperialismo, dal cancro dell’inflazione alla paralisi dell’industria e del commercio: tutto si è scatenato contro l’UP, perché doveva scatenarsi. E, di fronte al selvaggio esplodere di forze incontrollabili, nessun argine si è levato in difesa, perché l’argine o lo si costruisce prima o non sorgerà mai, e perché nei grandi svolti della storia ci si difende attaccando o si muore.
Nell’epilogo tuttavia lacrimevole della “rivoluzione democratica” tedesca del 1848-1849, la piccola borghesia democratica e radicale salvò almeno un lembo del suo pallido onore brandendo le armi. Lo fece – male e troppo tardi – sotto la spinta rabbiosa dei proletari; ma lo fece.
Non l’ha fatto, non poteva farlo, la piccola borghesia democratica e radicale cilena. Prigioniera del legalitarismo pacifista congenito – su scala mondiale – della propria classe, ha imprigionalo in esso l’unica forza che avrebbe potuto salvarla nell’immediato (ma per scavalcarla e abbatterla nella fase estrema del ciclo), il proletariato. La responsabilità non è soltanto sua: è anzi, in primo luogo, di quelle forze mondiali della controrivoluzione che si chiamano socialdemocrazia e stalinismo, e che da un trentennio e più tengono avvinta nelle pesanti catene dell’ossequio alla democrazia, alla legalità, al parlamento, al gradualismo riformistico, al pacifismo sociale, la classe operaia. Ad esse si deve soprattutto se due vie prima intrecciate, poi divergenti, si sono richiuse nel sangue a Santiago e a Valparaiso: la via di una trasformazione borghese “spinta fino in fondo”, quindi non pacifica né legalitaria, e quella della rinascita in armi di un proletariato levantesi a proclamare – come sarebbe possibile in una situazione internazionale non pregiudicata dal disarmo politico e organizzativo dell’unica classe veramente rivoluzionaria della società moderna – la rivoluzione in permanenza, nel grido – e nello spirito – del 1850.
Il Cile, così, non ha avuto non diciamo il “socialismo”, che era solo nella demagogia “democratico-progressista, ma neppure un “capitalismo normale-conseguente”.
Il cannibalismo di agrari e grossi borghesi ritrovatisi finalmente uniti sotto l’ombrello di un esercito di ignobili sgherri alle cui spalle non è certo difficile vedere l’ombra (ma un’ombra di ferro e di fuoco) del gendarme internazionale capitalistico, gli USA, si è rovesciato con selvaggia violenza sugli operai chiusi nella trappola delle “loro fabbriche” – simboli materiali della galera politica in cui l’opportunismo, questo servo fedele delle classi dominanti, li aveva e li teneva imprigionati. Essi erano vinti prima ancora di essere spietatamente attaccati, vinti dalla fede nelle vie pacifiche, parlamentari, nazionali, al socialismo. Da questa, purtroppo ennesima, lezione della storia, si leva il grido ammonitore: Nessuna classe può vincere senza rivoluzione violenta; nessuna può conservare il potere senza dittatura e terrore. Non lo può a maggior ragione – di fronte allo schieramento mondiale della conservazione borghese, con il suo codazzo di lacchè laici e preti – la classe operaia, che ha nulla da perdere fuorché le sue catene; non lo può nelle grandi aree del pianeta in cui la sua rivoluzione vittoriosa ha ancora da portare a termine compiti non suoi; ancora meno lo può là dove è chiamata a combattere e vincere per sé sola.
Salga questo monito grandioso dall’enorme carnaio di Santiago!
(da il programma comunista, n.18 del 27 settembre 1973)